|
PARTE X
(continuazione 2)
|
 |
|
 |
Soltanto dopo la
caduta del fascismo io ho sentito che tutti erano stati male, « Dio lo
sa che cosa ho sofferto » ma non tutti andarono esuli e nessuno preparò
la controrivoluzione, evidentemente perché tanto male non stettero e
quello che dissero dopo furono affermazioni di circostanza e
interessate, come, in fondo, non stette, poi, tanto male nemmeno il
Presidente Loschiavo, ossequiato, riverito e spesato!
Già all'altezza del portone della signora Ada arrivava, quasi assordante
il vociare della gente e le grida degli ambulanti della Piazzetta Duca
della Verdura, comunemente detta « Piazzetta del Pesce ». Era il posto
dove si trovava un po' di tutto, in particolare i prodotti dell'orto, ma
si trovava il pesce, i formaggi, le bancarelle erano tante ma vi erano
anche i negozi, nei locali intorno alla piazzetta, per lo più beccherie.
Una visita d'obbligo la facevano tutte le mamme alla piazzetta e, non
solo per comprare, ma per rendersi conto del mercato e anche dei prezzi,
delle novità stagionali e della qualità.
Di fronte alla Piazzetta, dove, oggi, vi è la tabaccheria Saluzzi, vi
era un « Bar-Pasticceria », direi poco bar e ancor meno pasticceria
perché aveva un po' di biscotti nelle scatole di latta e niente
pasticceria fresca, qualche bottiglia di liquore e una macchina per il
caffè, di quelle come una torre con una specie di piccola aquila sulla
volta, per lo più fredda e mai sotto pressione, clienti, in verità, non
ce n'erano molti. In compenso, però, vi erano molte qualità di
cioccolatini e tante, ma tante caramelle di diverse forme, di diversi
colori, di diversi gusti, non mancava il bastoncino di liquirizia e le
giuggiole, ma non mancavano i confetti, i cannellini e, nemmeno, lo
zucchero vanigliato e quei minuti confettini, dai mille colori, con cui
si ornavano le torte fatte in casa.
La proprietaria, a cui madre natura non aveva dato altezza e nemmeno
bellezza e neppure un marito, aveva garbo e pazienza, tenuto conto che
la maggior parte della clientela era fatta di bambini, che andavano a
spendere i centesimi, tutt'al più il soldo.
Sembrava una donna apatica, sempre distratta, afflitta da preoccupazioni
ma, credo, più che da problemi economici fosse afflitta da problemi di
salute.
Ma il gran bar e pasticceria era poco più lontano, nei locali del
negozio di tessuti del buon Ciccio Solimena, da poco scomparso.
Più locali, ben divisi, la sala con tavolini in ferro battuto e piano in
marmo, sedie, vetrinette in legno pregiato e lavorate, il bar con la
macchina per il caffè ed altra attrezzatura, il laboratorio, due entrate
e vetrina, sempre aggiustata con gusto e ben fornita, e c'era lui, il
padrone, il signor Viggiani, eccellente pasticciere, un pezzo d'uomo,
pletorico, ansimava anche quando parlava con gli amici, non so se
fumasse molto, di lui si diceva bene ma si diceva anche tanto male e si
disse anche dopo la sua morte, specialmente nel giudizioso periodo dei
voltagabbana. Per i più era « capatazza fascista » terribile ed anche
manesco, non so se fece volare qualche schiaffo di più ma non, certo,
l'Ospedale cittadino rigurgitò di sue vittime.
Non mi risulta che qualcuno l'abbia mai preso di petto e che tutto sia
stato contenuto « in iure murmurandi ».
Un giorno, in via Pretoria, mi si avvicinò un frettoloso signore, che mi
sussurrò in un orecchio « dievatt' e fa passà stu curnuto! ». Passava un
poveraccio, orfano da anni di madre, figlio unico, celibe e che, tutt'al
più, aveva fatto diventare cornuti gli altri e, forse, anche il mio
frettoloso suggeritore.
« Lu parlà è art' deggia » mi disse un amico, bersagliato dalle
malelingue, ma anche il parlare andrebbe contenuto e circostanziato, non
dimenticando che « ne uccise più la lingua che la spada » e non è giusto
nemmeno come rispose a me, che l'avevo dolcemente redarguita, una certa
signora, che snocciolava tutto il rosario delle maldicenze contro la sua
vicina di casa: « ...ah! ...duttore mio... dasc'mi gì ca pure la dengua
s'adda sfuà! ». Qualche volta si potrebbe sfogare pure a dire bene, non
si perde niente.
Della Chiesa della Santissima Trinità mi sono occupato poco quando ho
ricordato don d'Elia ma non ho ricordi personali. Posso affermare che è
stata sempre linda e pulita, come, del resto ancora oggi, anche di un
certo tono civettuolo, pure per il tipo di fedeli, che la frequentavano,
bastava fermarsi nei paraggi per la Messa della domenica e festiva di
mezzogiorno e mezzo: le signore « in ghingheri » con sfarfalloni di
cappelli (o paglie, a seconda la stagione) si sprecavano.
Ed eccomi all'ultimo tratto della via Pretoria prima di entrare in
Piazza Prefettura e, qui, mi riposo in ricordi simpatici e graditi.
La sala da barba di don Gerardo Di Pietro, facciata d'ingresso di marmo
rosa venato, porta a due battenti di cristalli pesanti con maniglia di
ottone sempre lucida, all'interno, all'esterno prima la « porta a
'ddegna » e, poi, a olocausto delle porte a 'ddegna compiuto, la solita
saracinesca, che faceva rumore anche quando era abbassata e la
tramontana infilava « la strara » e i suoi utenti obbligati o a diporto.
Era un locale molto accogliente con comode poltrone e grandi specchi con
enormi cornici, di pregiata fattura. Era simpatico ed accogliente lui,
don Gerardo, magro, piccolino, con un paio di baffetti alla « Vittorio
Emanuele » ingialliti dalla nicotina, due piedini piatti dall'uso con le
punte deviate completamente ad est e ad ovest, secondo un'antica e non
spenta caratteristica dei barbieri, fine nei modi, educato per
costituzione. Aveva servito sempre una clientela di un certo riguardo.
Di una riservatezza da rasentare l'esagerazione arrossiva anche quando
lo scoprivo io per visitarlo e gli ultimi anni della sua vita, che
dovette trascorrere nella casa di uno dei figli e tra nuora e nipote,
proprio per questo suo carattere, furono di grande disagio. Il figlio
Modestino, giovane simpatico e intraprendente, irrequieto, ufficiale
della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, dove raggiunse alti gradi,
fu valoroso combattente d'Africa e di Spagna: un esempio di dovere per
la fede, nella fedeltà.
A qualche metro dalla sala da Barba di don Gerardo Di Pietro, nei
locali, dove vendono, oggi, frutta e banane, vi era il negozio « chic »
per cravatte, cappelli, ombrelli, bastoni e biancheria di prima scelta.
Erano articoli delle « premiate » e rinomate case italiane, di cui il
negozio ostentava anche diplomi e quadri reclamistici.
I signori della cravatta, del cappello e del bastone di grandi marche,
erano don Amedeo e don Aristodemo Satriani. Io li ricordo già sulla
sessantina, distinti, ossequiosi, sempre rasati e con i baffetti,
vestiti bene e sempre di scuro, con colletto inamidato e cravatta a
farfalla, erano, insomma, l'espressione del carattere e del tono del
loro negozio. Il più loquace era don Aristodemo ma di una loquacità
molto controllata e, talvolta, fatta anche di pause, piene di mistero,
sempre molto fantasiosa, in genere, però, convincente, in sostanza,
sapeva presentare e vendere. Don Amedeo, in genere, prelevava dalle
scansie l'oggetto, che raramente faceva toccare dal cliente, si
misuravano solo i cappelli, ma era don Aristodemo che misurava, che
diceva che a quella faccia, a quella persona stava bene il Borsalino e
non il Panizza e che proprio quel tipo di Borsalino era quello che
portava Camillo Benso di Cavour, ai suoi tempi, che quel tipo di bastone
aveva visto in mano a Zanardelli, quando venne a Potenza, che quel tipo
di guanti usavano i grandi ufficiali di cavalleria. Tutto faceva brodo
ma per loro faceva anche soldi e, mi pare, che i fratelli Satriani
fossero stati degli antesignani perché, oggi, le ditte per vendere
meglio si servono della firma degli stilisti essi si servivano del nome
di Cavour o di Zanardelli o di altri. Non mi pare fossero stati troppo
in odore di santità con il fascismo anche perché il fez e la sahariana
toglievano clienti. In fondo, due signori negozianti pieni di saper fare
ed anche di gusto, con predilezione verso determinati articoli ma,
innanzitutto verso una clientela più scelta.
E all'angolo, dove fu la succursale del Banco di Napoli e dove, oggi, vi
è la gioielleria Lamorgese, vi era l'Agricom, una banca con
corrispondenti in molti comuni della provincia di Potenza, che occupava,
oltre il pianterreno con la cassa e l'ufficio riscontro, anche i due
piani soprastanti con la Direzione e gli altri servizi.
Questo dell'Agricom è un ricordo che se, da un lato, ancora mi « brucia
» perché fu determinante nella mia scelta di vita e della professione,
dall'altro, posso affermare che il mio rapporto di lavoro con la banca
mi fu utile per l'esperienza che mi offrì, per le conoscenze di uomini e
vicende che feci.
Non mi ero ancora riavuto dalla stanchezza, l'emozione, la gioia della «
conquistata » maturità classica, i quadri furono affissi nell'atrio del
Liceo il 21 luglio, che il 1° agosto mi ritrovavo dietro lo sportello
fra moduli, cartelle, numeri con a fianco una cassaforte ed un tiretto
pieno di soldi, di cui sapevo l'esistenza ma non avevo mai visto prima.
Mi sentivo un pesce fuor d'acqua fra cose e persone, di cui non
conoscevo nemmeno l'esistenza, impacciato anche perché tirato a lucido e
stirato in un inconsueto abito scuro con camicia e cravatta, era di
agosto, e anche « strigliato » bene dal direttore sui comportamenti e
modi da usare con i clienti e con i compagni di lavoro.
Come vi ero entrato? Senza alcuna mia partecipazione o richiesta e
nemmeno interessamento di mia madre, che, fra l'altro, non conosceva
persone in condizioni di darle una mano. Un signore, che, per diversi
motivi, esercitava un certo potere nella banca e che conosceva,
indirettamente, la mia famiglia e le nostre condizioni di bisogno,
propose la mia assunzione e la Direzione, dopo aver esaminato il mio
curriculum di vita studentesca, mi fece arrivare la lettera per prendere
servizio. Così, mentre i miei professori del Liceo preconizzavano un mio
futuro sulla cattedra, mentre io mi vedevo già sulla strada della
realizzazione del mio sogno di diventare medico, mi trovai,
improvvisamente, fra conti e ragionieri, deluso, amareggiato, con
qualche imprecazione ingenerosa e irriconoscente verso il mio santo
protettore ma, in compenso, con un grosso stipendio mensile: 344 lire e
25 centesimi! (ed era veramente molto). Si lavorava molto, si conosceva
l'orario di entrata, 8,30, ma già alle 8,25 il direttore aveva prelevato
il foglio di presenza, ma non si conosceva l'orario di uscita e poi vi
era anche il supplemento alla giornata perché, a turno, la sera,
talvolta anche fino alla mezzanotte, si scendeva nello scantinato, dove
erano le presse-copia lettere per sorvegliare il commesso di cassa, il
paziente e buon Ermenegildo Claps, perché eseguisse regolarmente le sue
mansioni, compresa l'inclusione nelle lettere di tutti i valori bollati.
Questo turno molto spesso capitava a me, talvolta per preghiera dei miei
colleghi impiegati con famiglia, talvolta per deferenza verso la loro
età e la loro anzianità di servizio. Ho fatto sempre del lavoro la
ragione della mia stessa vita ed ho lavorato, comunque, di notte e di
giorno, volentieri, con zelo ma non riuscii, assolutamente, ad
affezionarmi a quel tipo di lavoro piatto, noioso, senza stimoli e senza
fantasia, ricavandone, a mano a mano che passavano i giorni, un
malessere fisico e psicologico ed un odio per i numeri e i conti.
Non ho fatto più conti in vita mia, non ho più contato nemmeno il resto
della spesa!
Questo mio particolare stato di malessere non sfuggì, certamente, a mia
madre, che già aveva preventivato lo scoppio della bomba, che non si
fece attendere.
Dopo sette mesi di servizio, nonostante fossi già in pianta stabile, fra
il dispiacere del Direttore, severo, forse, eccessivamente, ma
comprensivo, il ragionier Raimondo Maccio, il disappunto dei miei
colleghi, che mi avevano trattato affettuosamente come un fratellino,
probabilmente, piccolo, magro, ubbidiente, come ero, facevo anche
tenerezza, presentai le dimissioni, con l'avallo della firma di mia
madre perché ero minorenne, chiedendo l'immediato esonero dal servizio.
Rinunziavo ad una carriera quando la piccola banca era stata già
assorbita dal Banco di Napoli e, perciò, ho detto che il ricordo « mi
brucia » ancora oggi perché nella vita di ognuno di noi, e io incluso,
vi sono i dubbiosi e indefinibili « se », che durano quanto dura la
stessa vita ma, credo, di aver ubbidito ad una « chiamata » del destino,
e, sono convinto, di aver ubbidito con passione, con abnegazione e
spirito di sacrificio, con amore verso la professione medica e verso la
gente, con onestà. Ogni altro giudizio lo lascio agli altri, ai miei
colleghi, che ho sempre stimato ed amato, come me stesso, alle migliaia
di pazienti, che si sono serviti di me e della mia opera, che accetto
con la coscienza, tranquilla e serena, di chi ha fatto il suo dovere,
oltre il limite delle sue stesse forze fisiche, psichiche e
intellettuali. E' un'affermazione che faccio senza sicumera ma con la
modestia, che mi ha sempre guidato e contraddistinto, e, proprio, perché
sono al « consuntivo » della mia vita professionale e di uomo.
E' un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno onorato con la loro
stima, la loro fiducia e che, nello stesso tempo, mi hanno fornito i
mezzi e gli stimoli per diventare « migliore », innanzitutto, nell'animo
ma anche socialmente e culturalmente. Uno show personale? Mi sentirei
mortificato al solo pensarlo ed ancora più mortificato se lo dovesse
pensare uno solo dei miei cari lettori. L'ho scritto perché è un mio
ricordo ed io stesso sono, ormai, un ricordo della mia città ma l'ho
scritto per ricordare quei miei amici, che appusirono fra i numeri,
senza l'aiuto delle macchine calcolatrici, i ragionieri: Granata, capo
contabile, d'Antonio, Giubilei, che nella lunga notte del 30 dicembre
non riusciva a quadrare i conti perché esausto dalla stanchezza
continuava a sommare 6+7 = 12 in una maledetta e affollata colonna di
numeri, le signorine Moccia, Gallo, Laurita, segretaria del Direttore,
il flemmatico commesso Pergola, il lungo, astenico, distonico cassiere
Peppino Pace, che, al mio ritorno dalla guerra, non trovai perché perito
sotto le bombe alleate dell'8-9 settembre del 1943.
L'ho scritto perché attraverso la porta a vetri, sulla via Pretoria,
alzando gli occhi dalle carte e dai numeri, io vedevo, tutti i giorni e
più volte al giorno, l'Albergo Lombardo, di cui non v'è più traccia ma
che rappresentò una vera « istituzione » della vecchia Potenza. E,
questa volta, concordo con il Loschiavo, che, a pag. 81 del suo già
citato libro, ha scritto: « ...Ciò perché il " Lombardo ", come il
famoso battello dei Mille, nella piccola città ha adempiuto ad una
funzione storica a tutta la vita di Potenza, della provincia e della
regione si può dire che fisiologicamente e intellettivamente è passata
da lì, ospitando, fra l'altro, tutte le persone più rappresentative colà
convenute ». Ed io, aggiungerei tutti i più grandi attori dell'epoca, le
più belle compagnie teatrali, dalla lirica alla prosa all'operetta,
tutta una clientela scelta ed anche « chic », adescata dal punto
centrale dell'albergo, dall'ambiente e dai modi signorili ed ospitali
del personale di servizio, nonché dalla squisita e rinomata cucina e,
soprattutto, dai padroni, don Giovanni Boccia, il padre, don Antonio, il
figlio, due personaggi caratteristici anche fisicamente, tarchiati, con
la buona pancetta aristocratica, con due teste rotonde e lucide, come
due palle da bigliardo, in tutto somiglianti a quel « Kojach », attore
americano di films gialli.
Ebbi la sfortuna di assistere alla fine velocissima di don Antonio, per
una violenta, irrefrenabile enterorragia, che non esiterei a definire «
torrentizia », che, per fortuna, può capitare una sola volta nella vita
di un medico e, solo, di qualche medico e che non dà scampo al paziente
e, allo stesso medico, non dà nemmeno il tempo di poter aprire la sua
borsetta di pronto soccorso.
L'Albergo fu tenuto ancora aperto dalla vedova di don Antonio, la
signora Elvira, che, pur fra tante e comprensibili difficoltà, dimostrò
coraggio e sufficienti capacità fino alla chiusura ed alla distruzione
anche dello stabile.
Ho scritto del mio episodio di bancario per non dimenticare di citare.
che, prima dell'Agricom, nei locali a pianterreno, vi era il « Caffè
Italia », piccolo e civettuolo ritrovo per uomini di bella vita e
biricchini, dove era possibile l'avventura galante con l'attricetta o la
ballerina, che alloggiava al Lombardo, o con qualche farfalletta piovuta
da fuori nei giorni di festa.
Ma si faceva tutto con molta discrezione e decenza e non solo perché «
il paese era piccolo e la gente mormorava » ma per quel pizzico di
rispetto verso se stessi e verso la società potentina, che è stato, in
fondo il sale buono e misurato di tutte le nostre azioni.
Comunque, allora, in quel « caffè » faceva il vuoto intorno e strage di
uomini « Alfonsina », meglio conosciuta, in seguito, come « signorina
Quacqualà ». Non era una bellezza da « Madonna di Raffaello » ma,
certamente, una « prorompente maggiorata » tale da suscitare occhiatacce
invidiose delle donne e occhiate vogliose degli uomini, a cui tormentava
i sonni della notte. Rimase nostra concittadina ma cambiò mestiere,
fornita di automobile e di borsetta con lo strumentario necessario ed
adeguato, si fece callista e « medichessa dei piedi », visitando e «
operando » a domicilio una nutrita clientela, sollevandola da penose
sofferenze.
|
 |
|
 |
|
Nella foga parolaia della "stirpe dalle culle piene". |
Ed eccomi a Piazza
Prefettura, già dell'Intendenza, poi piazza del Mercato, quindi, piazza
Mario Pagano ma sempre detta piazza Prefettura e soprannominata « piazza
Polmonite » per via di quei maledetti e inclementi spifferi di vento, da
cui è stata, in ogni tempo investita, impietosamente. Fu seconda ma solo
nel tempo a Piazza Sedile perché la presenza della Prefettura, degli
Uffici Giudiziari, del Teatro Stabile le dettero il tono e l'importanza
di prima della classe, che ha, poi, conservato. Ospitò, così, grandi
manifestazioni di popolo e di elite, soldati, fanfare e grandi
orchestre, il Re Umberto I e la Regina Margherita, in occasione
dell'inaugurazione del Teatro Stabile, del Re Vittorio Emanuele III e
del Principe Ereditario Umberto, il 30 agosto del 1925, per
l'inaugurazione del Monumento ai Caduti, sistemato in Piazza XVIII
Agosto, e per la posa della prima pietra dell'Acquedotto Pugliese, che
avvenne in uno scavo preparato all'ingresso di via Angilla Vecchia, tra
il palazzo dei nobili Viggiani, sparito, e la villa Comunale. Accolse i
più grandi uomini politici del tempo prefascista, del tempo fascista,
fra cui Bottai, Starace e lo stesso Mussolini, che, il 30 agosto del
1936, in divisa di Maresciallo d'Italia, aveva assistito alle grandi
manovre dell'Esercito nell'Irpinia, pronunziò dal balcone della
Prefettura, di fronte ad una folla, veramente oceanica, non vi era
spazio nemmeno per uno sputo, con la sua solita enfasi oratoria e il suo
inconfondibile stile letterario, un caloroso discorso, inneggiante alla
generosità della nostra Terra e delle nostre genti e alla fecondità del
nostro popolo. Un discorso retorico-demagogico? Non ho l'abitudine di
associarmi ai giudizi degli altri anche perché li so coniati da quelli
che erano fra quella folla a spellarsi le mani per gli applausi, da
quelli che vollero che quel discorso, stampigliato su marmo a grossi
caratteri, fosse affisso sulla facciata del Palazzo della Prefettura,
sulla sinistra di chi guarda. Era là quando sono partito per la guerra,
non vi era più quando sono ritornato. Se fu un atto servile il primo, di
cui il Dittatore, certamente, non si accorse, a meno che non gli
avessero inviato un attestato fotografico, il secondo fu, non solo, un
atto più servile verso i nuovi padroni, esterni ed interni, ma fu una
bruttura ed inutile atto vandalico. Ho detto « inutile atto vandalico »
perché ogni distruzione è vandalismo, inutile perché non è servito a
cancellare la storia e, piaccia o non piaccia, « quel 30 agosto del 1936
e quel discorso » fanno parte della storia della nostra città, così come
la visita di Zanardelli. D'altronde, l'hanno distrutto i potentini, e
non so di sicuro se l'hanno distrutto o se il marmo giace negli
scantinati di qualche palazzo di uffici governativi, pronto per essere
rispolverato e riesumato in altre maleaugurabili simili occasioni, ma il
discorso non lo tengo solo io, modesto raccoglitore di carte, ma è in
tutti gli archivi storici, nelle biblioteche, nei giornali dell'epoca.
Accolse tutti gli uomini politici dell'antifascismo e riservò anche per
loro folla e omaggi: da Pertini a Nenni, a Togliatti, a De Gasperi, a
Saragat, a Fanfani, a Moro fino agli ultimi nati. Che popolo buono è il
nostro! Quando si tratta, poi, di forastieri diventa anche tre volte
buono. Ho sempre creduto e continuo a credere che, in campo politico,
siamo dei meteoropatici, pronti a subire l'influsso del « vento », che,
fra l'altro, non è stato mai « vento del Sud » ma sempre « vento del
Nord »: sentir parlare « sci-sci » ha avuto sempre un certo effetto su
di noi, aumentando le nostre capacità servili eppure i « polentoni » o
ci ignorano completamente o ci schifano abbondantemente.
|
 |
|
 |
|
Così rimasero quelli dell'U.N.P.A. a vegliare sui destini della
città ... |
Aldo Moro fu
ospite della nostra città e di Piazza Prefettura anche durante il
periodo fascista, quando era studente universitario e non so se avesse
letto già nel suo destino il suo futuro. Accompagnava il padre,
ispettore ministeriale per le scuole elementari, e mentre il padre si
aggirava fra scuole e uffici scolastici, guardando, ascoltando,
annotando, consigliando, il figlio si aggirava per la nostra città, in
compagnia di Attilio e Aldo Viola, anche lui guardando e ascoltando ma
sembrava senza interesse. Pallido, allampanato, non era, certo,
l'immagine della buona salute, anzi, dava l'impressione di essere un
ospite della nostra città, convalescente di malattia, venuto a respirare
un po' della nostra aria, rinomata e ritenuta sana-malati.
Piazza Prefettura raccolse le lagrime delle spose e delle mamme di quei
nostri concittadini che partirono per le guerre, 1911, 1915-18, 1936 «
il battaglione Lupi della Lucania » per la campagna d'Africa, 1940. Ma
raccolse palpiti e sospiri di amanti e innamorati, di gente spensierata
e benestante, di perditempo, di gente povera e preoccupata e non solo
della situazione economica ma perché aveva da fare con la Questura o con
gli Uffici Giudiziari o con gli Uffici della Prefettura o della
Provincia.
Non ricordo la Piazza ai tempi della parata militare del 1908, in
occasione della Festa dello Statuto, ma ricordo la Piazza con gli
alberi, le carrozze, i lampioni, che avevano tre bracci con tre lampade
all'ingiù. A proposito delle tre lampade dei lampioni circolava voce che
fosse stata una vittoria, fra tante sconfitte subite nella stessa seduta
di un consiglio Comunale pre-fascismo, dei massoni: 3 come 33!
Ricordo la Piazza prima delle sopra-elevazioni, degli scatoloni di
cemento armato, che, forse, nel proponimento di darle una veste nuova,
l'hanno imbruttita. Era una piazza semplice che, con qualche ritocco
d'antico, avrebbe potuto costituire l'ambiente vero ed idoneo al Teatro
Stabile, allo stesso Palazzo della Prefettura, alla Chiesa di San
Francesco. Conservare il « rudere » senza il suo ambiente non ha senso,
svilisce il valore del « rudere » e non fa visitatori.
Ricordo il « Caffè Pergola » nella sua antica attrezzatura, tanto
suggestiva, i pesanti tavolini di marmo, dal piede in pesante ferro,
artisticamente lavorato, con la vecchia caffettiera, che fischiava e
cacciava vapore acqueo, come una di quelle locomotive in uso sulla
Napoli-Potenza o sulla Potenza-Foggia, i suoi frequentatori, austeri
nell'aspetto e nel vestire, che tanta soggezione incutevano a me
bambino. Il « Pergola » custodiva per i potentini, come il « Pedrocchi »
per i padovani, come il « Michelangelo » per i fiorentini, un nobile
retaggio spirituale e sentimentale. E non soltanto perché conobbe ed
ospitò uomini insigni della politica, della cultura, dell'arte ma perché
fu il centro della reazione: quella contro la tracotanza del
conquistatore piemontese e quella contro il fascismo.
Dal « Caffè Pergola » partì la miccia che accese focolai di rivolta in
città contro il piemontese invasore ed oppressore e culminati con
piccoli fatti di sangue allorché lo spavaldo generale, comandante della
guarnigione e governatore militare della città, colpì, in pieno volto,
con una frustata, il barista, che invece di servirgli subito il caffè
aveva indugiato per chiedergli, civilmente ed educatamente « con lo
schizzo o senza lo schizzo ». Lo « schizzo » era, in genere, la
spruzzatina di anice.
|
 |
|
 |
Nel « Caffè
Pergola » faceva crocchio l'opposizione al fascismo e nel « Caffè
Pergola » e davanti al Caffè furono distribuite le « famose purghe di
olio di ricino », a dosi alte e tali da sterminare un animale in buona
salute, circa un quarto di litro!
Una delle vittime fu l'avvocato Gerardo Palermo, noto e valente
penalista della nostra città, nativo di Pignola, che aveva sposato una
cugina di mia madre, Adele Nardiello. Naturalmente, la prima ad
accorrere fu mia madre, che rimase profondamente sconvolta sia per le
precarie condizioni del povero avvocato, distrutto da dolori addominali
violenti con vomito e diarrea, sia per l'episodio in sé, che definiva «
disgustoso e cattivo ».
Da bambino guardavo la facciata del Teatro Stabile con sguardi
rispettosi, nutrendo il pio desiderio di poterci entrare, un giorno,
come entravano gli altri, i grandi, le persone per bene della città, per
ammirare l'interno, di cui mi raccontavano meraviglie, certamente
esagerando: poltrone, palchi, palcoscenico, velluto rosso, scene,
colori, luci. Serviva a stimolare la mia fantasia e, qualche volta,
giravo intorno al palazzo come se potessi scoprire la verità attraverso
i muri o, magari, qualche feritoia o finestrella aperta.
Ammiravo anche la gente che vi entrava, era ben vestita e corretta, non
l'invidiavo, perché l'invidia non mi è stata congeniale, e perché ero
sicuro di essere, un giorno, uno di loro.
Era quasi uno spettacolo in Piazza quando, in determinate occasioni, si
accendevano i grandi lampadari dei saloni, che con i grandi balconi e la
lunga balaustra, rendevano più imponente la facciata del Teatro. Erano
le feste dei « galantuomini », che avvenivano anche con una certa
frequenza, in particolare durante il periodo di Carnevale, o erano feste
di ricevimento di grandi personalità, venute da fuori.
Attraverso quei balconi filtravano immagini di crocchi di uomini e donne
in eleganti abiti da sera, di coppie, che si dondolavano alle struggenti
note di indiavolate polche o valzer o mazurche o di appassionati tanghi
argentini, con pause per il meritato rinfresco.
Al di là di quello che si vedeva, si diceva, vi fossero i locali
riservati con i tavoli da gioco, dove qualcuno si giocava anche l'anima,
commentò un giorno un amico. Non ho mai approfondito le dicerie perché
non ho mai saputo giocare, non ho mai avuto beni da dilapidare al tavolo
da gioco, anzi, ho avuto sempre una specie di idiosincrasia per le carte
e per i giochi, in genere.
Non ho ricordi personali dell'attività del Teatro perché non ebbi
possibilità di frequentarlo ma so che opere, operette, drammi, commedie,
con grandi compagnie dell'epoca, furono rappresentate allo Stabile e che
grandi attori « tuonarono » dal suo palcoscenico.
Purtroppo, con il tempo malvagio, anche il Teatro finì di essere tale e
fu trasformato in una comune sala cinematografica con scricchiolanti
poltroncine di legno e il terremoto del novembre del 1980 ha completato
l'opera. In me non resta l'insoddisfazione per le opere teatrali, che
non ho visto, resta l'amarezza per il degrado inesorabile e progressivo,
che ha subìto il Teatro, ma alimento anche la speranza che io possa
rivederlo restituito al suo antico splendore per il godimento spirituale
e culturale dei miei figli e dei miei nipoti, di coloro che
continueranno ad amare questa città.
E dopo il Teatro, il ricordo corre all'Emporio Ricasoli, che era subito
a lato, dopo l'arco, dove, oggi, vi è Ferrara con « Tabacchi e Giornali
».
Se è vero come è vero che » a dir le sue virtù basta un sorriso » è
altrettanto vero che « a dire le virtù dell'Emporio Ricasoli
basterebbero la foto e il depliant nel testo ».
Erano in due, i Ricasoli, fratello e sorella. Due figure caratteristiche
fisicamente ed ancora di più negli atteggiamenti e nei discorsi.
Piccolini di statura, rotondetti, con la pelle liscia e lucida, quasi
burrosa, cerimoniosi, pieni di « inchini » e di « prego » « grazie »
erano « una macchietta » di tutti i giorni ed a tutte le ore.
Furono, però, e, credo, questo fu il loro merito maggiore, i primi a
capire il significato commerciale dell'Emporio e ad attrezzarsi ad
Emporio. Vissero bene ed ho motivi per credere che fecero anche buoni
affari sia per la varietà e la buona qualità della merce e sia per la
ubicazione del negozio: un punto di obbligato passaggio. Il più delle
volte si entrava per curiosare e si usciva con il pacco.
|
 |
Tutt'intorno alla
Piazza vi era « una sequenza di botteghe e di affollati ritrovi », come
scrive Michelino Pergola, nel suo già citato libro «Potenza scomparsa»,
la drogheria Telesca, la Tabaccheria Ferrara, la pasticceria Larocca, i
Tessuti di don Domenico Manzo, uomo di una certa imponenza fisica, che
ricordo Priore della Congrega di Santa Maria nel suo candido camice
bianco con tracolla di sciarpa, tempestata di ricami in oro, e bastone
di comando, sormontato da un grosso pomello, raffigurante una « tiara »,
che alle luci dell'altare o ai raggi del sole mandava luccichii vari e
variamente colorati. Ma lo ricordo anche per la sua voce baritonale, che
spiccava fra quelle del coro, durante la Messa cantata o le varie
funzioni religiose.
Non ricordo il cinema Moderno, che, sempre a quanto scrive Michelino
Pergola, propinava per quaranta centesimi fumettoni di due o più
puntate, mentre ricordo la « popolare Sala Roma dove s'alternavano
piovosissime pellicole e casalinghi cancans. Di tanto in tanto qualcuna
delle « 10 Ghirilles 10 » abbandonava la fila per zittire con frettolose
poppate il frignante rampollo. Le rumorose proteste del pubblico
venivano stroncate dal baffuto gestore con la decimazione degli
spettatori più gracili ».
Non ho motivi per non ammettere che la Piazza, nel corso degli anni,
vide, fra i tanti, anche degli ottimi Prefetti, capaci di dirigere una
Provincia difficile, come la nostra, e competenti. Sono sempre
antipatiche e poco cortesi le graduatorie di merito ma, in coscienza,
non potrei nemmeno azzardarle perché non avevo l'età, non peso sociale
e, quindi, nessuna esperienza diretta. Potetti raccogliere delle voci
ma, il più delle volte, la «vox populi» non corrisponde alla « vox Dei »
ed allora è onesto tacere. Un Prefetto, però, non sfuggì alla mia
attenzione e, nemmeno, alla attenzione delle persone per bene, capaci di
superare pregiudizi e prevenzioni, di saper apprezzare il bene, da
qualsiasi parte venisse: il ragionier Giuseppe Avenanti (dal 20-1-1934
al 30-6-1937).
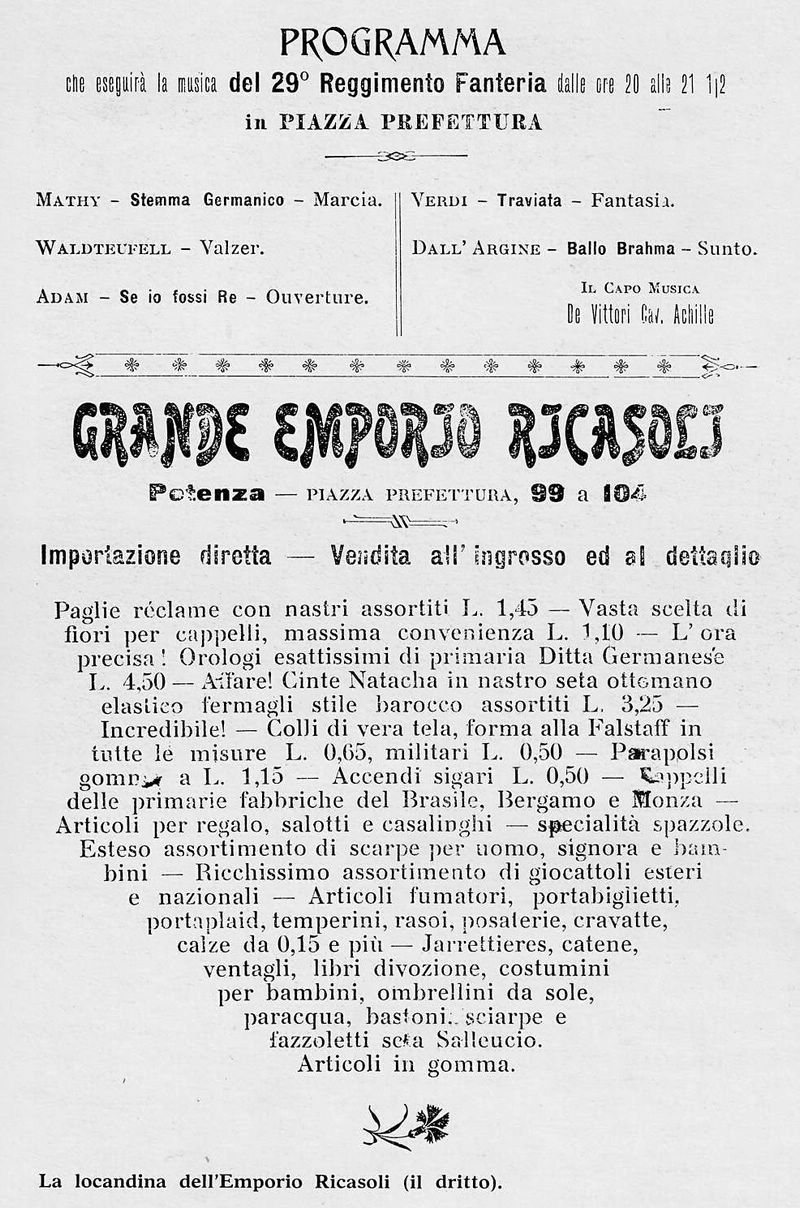
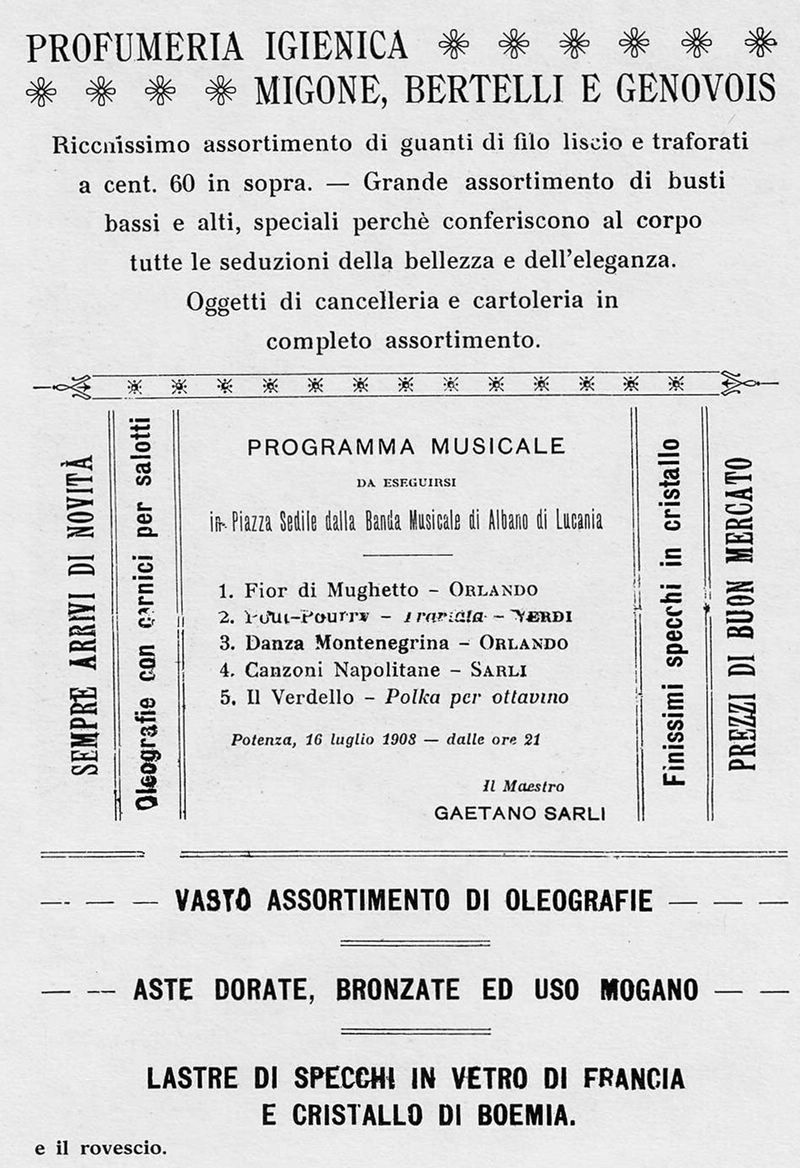
|