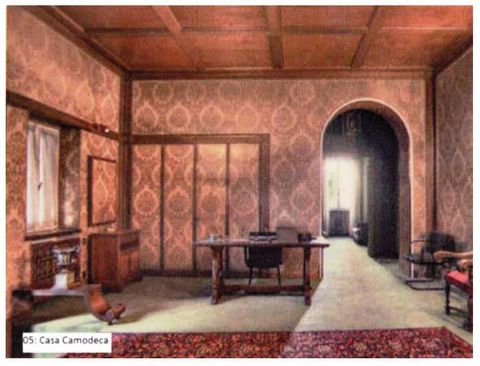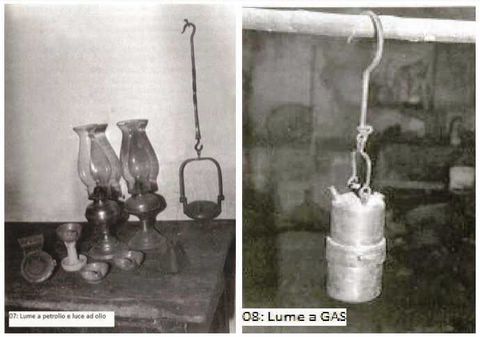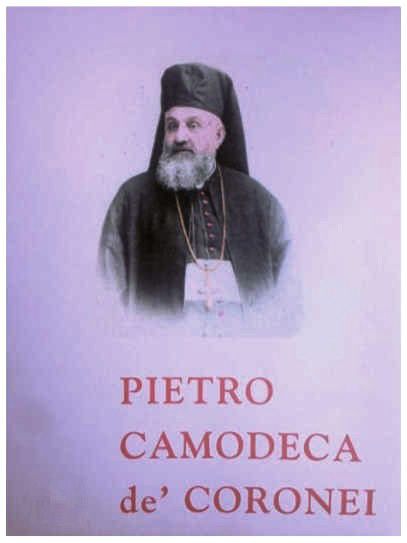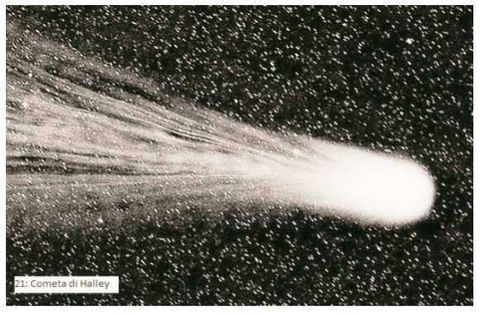|
INTRODUZIONE
Per questo breve ricordo su Mons. Pietro Camodeca de’ Coronej, desidero
partire dalle conclusioni che il Prof. Laviola ha scritto nel suo
magnifico libro pubblicato negli anni 60 ed al quale ci siamo ispirati e
dal quale abbiamo desunto materiale originale. Potrebbe sembrare un
plagio, ma la scomparsa completa dei documenti da casa Camodeca ci ha
indotti a seguire solo questa via, per portare a compimento il nostro
intento. Abbiamo voluto anche riportare la prefazione che ha
caratterizzato una seconda pubblicazione.
“Giunti a questo punto, sembra a noi di aver ricostruita, servendoci, in
primo luogo, dei suoi scritti, la figura di un uomo singolare che non
poteva restare nell’oblio. Un uomo che ebbe un ingegno versatile e
spazio, anche se non sempre con profondità, nei vari campi del sapere
umano: filologia, letteratura, arte, archeologia, poesia, religione ……
……. un individuo complesso al quale non mancarono i riconoscimenti dei
suoi contemporanei, e che sicuramente avrebbe potuto dare di più nel
campo letterario, se fosse riuscito ad imbrigliare quel suo ingegnaccio
che era un vulcano di idee e di progetti. Castroregio a lui deve molto,
e con Castroregio la causa albanese e la Chiesa di rito greco. Il De
Rada combatte le sue battaglie per la lingua e per la letteratura,
Camodeca combatte per il rito, per i suoi confratelli, per la creazione
di una diocesi autonoma. Forse indulse un po’troppo a certa deteriore
lotta paesana e dimenticò per poco i nobili ideali di cui era preso
quando terminò i suoi studi ed uscì entusiasta dal Collegio di San
Demetrio e dal Seminario di Tursi. Se si fosse mantenuto sempre in
quell’aura di studio sereno ci avrebbe, senz’altro, dato qualcosa di più
duraturo e forse sarebbe arrivato più in alto nella carriera
ecclesiastica. Ma tant’è l’uomo è schiavo dell’ambiente e non vi era (e
non vi è) peggior ambiente di un piccolo centro dove, e lo abbiamo
scritto più volte, è cosa estremamente difficile vivere al di sopra
della lotta, degli interessi, delle invidie e delle gelosie inevitabili
tra casato e casato e, quello che più meraviglia, tra membri, alle
volte, di una stessa famiglia, perché, in fondo, nel piccolo centro,
comune è il ceppo e comuni sono gli antenati. Considerato da questo
punto di vista, il ritorno al paese fu un male per lui ……… . Nessuno può
negargli l’attaccamento alla sua gente, al suo paese, alla sua stirpe,
al Sommo Pontefice, alla Chiesa. Nessuno può misconoscere il suo
contributo a tutte le iniziative, a tutti gli sforzi per risollevare e
tenere in vita usi, tradizioni, lingua e rito. Ci sia consentito citarlo
ancora una volta e trarre un ultimo ammaestramento e un chiarissimo
monito. Si è soliti che i libri scritti in albanese, ciascuno, o
istruito o no, pretenda leggerli col solo ausilio della lingua italiana,
senza punto studiare l’alfabeto proprio secondo il quale sono scritti
………… . Il monito di Pietro Camodeca non ha perduto efficacia: proiettato
nel futuro, è ancora palpitante di attualità. Oggi si pubblicano riviste
e periodici scritti nella lingua albanese, ma la maggior parte di noi
ben poco può leggere, ben poco può gustare della bellezza di una lirica,
che, nella traduzione perde quasi sempre la sua freschezza e la sua
originalità. Così muore la lingua, non è sufficiente per mantenerla in
vita la tradizione orale. Ecco la necessità di uno studio sistematico,
organico; ecco l’urgenza di un provvedimento legislativo che istituisca
lo studio dell’albanese nei paesi albanofoni. Se ne discute da anni, si
fa appello al dettato costituzionale per i diritti delle minoranze, si
creano associazioni, ma ancora si assiste al lento e continuo tramontare
della nostra lingua. Non si vuole ripetere il concetto: ma come si fa ad
amarla la lingua scritta, se non si è’in grado di leggerla?......
Diventa vano il lavoro degli studiosi che si sobbarcano a sacrifici di
ogni genere perché tutto non muoia, perché il folclore senza lingua è
destinato a scomparire, a non essere compreso nel suo giusto valore,
perché non solo una èlite possa essere capace di leggere, ma tutta la
gente che vive nei paesi italo-albanesi. Uomini come Camodeca restano
sempre attuali; ma, purtroppo, sono attuali anche le parole contenute
nella lettera aperta, pubblicata in altra parte di questo lavoro, << lo
spirito contraddittorio che anima la nostra razza ». Non devono sembrare
fuori luogo queste nostre considerazioni: nel centenario della morte di
Pietro Camodeca ci si consenta di nutrire la segreta speranza che il
tributo di riconoscenza si estrinsechi da parte di tutti in un proposito
di amare, esaltare e realizzare le cose che amarono, esaltarono e, in
parte, realizzarono Gerolamo De Rada e Pietro Camodeca.”
PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE
“Questa seconda edizione del saggio su Pietro Camodeca de’ Coronei vede
la luce arricchita da un’appendice, nella quale trovano posto, insieme
con alcune pagine inedite del Camodeca, due interessanti scritti di
AntonioMolfese, medico e giornalista, che ha raccolto i “ Ricordi “ di
sua madre, Donna Giuseppina Camodeca, nipote dell’Archimandrita, ed ha
descritto un viaggio compiuto in Albania, in compagnia della stessa
madre, alla ricerca delle radici. La nuova pubblicazione rappresenta un
duplice atto di amore dei fratelli Francesco, Giuseppe ed Antonio
Molfese verso lo zio Monsignore e verso la loro genitrice. Come nipoti,
infatti, essi sono convinti che nessuna azione sia più meritoria di
questa che vuol far rivivere le opere dell’Archimandrita e perpetuare il
ricordo tra i posteri. Come figliuoli, poi, non potevano onorare in modo
migliore ed offrire un omaggio più gradito e più significativo alla loro
madre, il giorno in cui essa taglia felicemente il traguardo dei
novantanni. Auguri, Donna Giuseppina, auguri: verso il secolo ed oltre!”
Trebisacce - Marzo 1992
Si sta avvicinando il centenario della morte del mons. Pietro Camodeca
de’ Coronej e si desidera preparare l’evento con qualche ricordo che
questo prete di campagna dell’800 ha lasciato indelebile nella storia
degli albanesi in Italia e nel suo paese.
PARTE PRIMA
CASTROREGIO: VITA IN PAESE. I RICORDI DI DONNA GIUSEPPINA
Castroregio, paese di 400 abitanti, era posto su un cocuzzolo esposto ai
venti alle falde del massiccio del Pollino e quando tirava la tramontana
bisognava rinforzare la chiusura delle finestre e dei balconi e la
temperatura, già bassa di inverno, si abbassava ancora di più a tal
punto che nelle stanze da letto gelava l’acqua nella brocca. Nonostante
le molte coperte poste sul letto, il freddo si faceva ancora sentire per
cui prima di coricarsi, oltre lo scaldino per ogni stanza, era invalso
l’uso di prendere una bevanda calda a base di liquore di mandarino, rum
e zucchero, « il punch ›› . Era un paese albanese al confine tra
Calabria e Basilicata, posto su un cucuzzolo a circa 900 m. sul livello
del mare, un osservatorio naturale privilegiato, dal momento che era un
paese isolato, circondato da boschi e quindi in posizione ideale per
l’osservazione degli eventi celesti. Posto nell’entroterra appenninico
ad economia esclusivamente agricola, vi svolgeva la sua attività qualche
artigiano (fabbro, falegname, calzolaio, sarto ecc). Nel circondario le
colture prevalenti erano le cerealicole, pochi vigneti ed oliveti; non
esisteva strada rotabile. I collegamenti con i comuni vicini avvenivano
mediante cavalcatura ed il centro più vicino era Amendolara, collegata
con una pessima strada a 2 ore di cavalcatura, dove esisteva
 anche
una stazione ferroviaria. Le condizioni sanitarie erano precarie, come
nella maggior parte dei paesi del sud, e vi esercitava un medico (non
esisteva una farmacia). Non vi era acquedotto comunale, ne’ rete
fognante e la erogazione dell’acqua proveniente da sorgenti locali
avveniva mediante fontanini pubblici posti fuori dal paese. Non vi era
posto telegrafico pubblico, ne’edificio scolastico e le scuole primarie
erano tenute presso la casa dell’unica insegnante che teneva insieme le
5 classi. La maggior parte dei fanciulli (pochi in quanto gli albanesi
usavano ed usano mezzi anticoncezionali empirici ma molto efficaci ed
ogni famiglia non procreava più di un figlio), infatti, veniva adibita a
svolgere lavori agricoli o lasciata a custodire le case in paese durante
l’assenza dei genitori impegnati nei campi. Prima di addentrarci ad
illustrare la figura di Mons. Pietro Camodeca, desideriamo riportare i
ricordi di Donna Giuseppina, nipote prediletta di Don Pietro, che ha
raccontato come si svolgeva la vita in Castroregio ai primi del ‘900 e
nella sua famiglia. anche
una stazione ferroviaria. Le condizioni sanitarie erano precarie, come
nella maggior parte dei paesi del sud, e vi esercitava un medico (non
esisteva una farmacia). Non vi era acquedotto comunale, ne’ rete
fognante e la erogazione dell’acqua proveniente da sorgenti locali
avveniva mediante fontanini pubblici posti fuori dal paese. Non vi era
posto telegrafico pubblico, ne’edificio scolastico e le scuole primarie
erano tenute presso la casa dell’unica insegnante che teneva insieme le
5 classi. La maggior parte dei fanciulli (pochi in quanto gli albanesi
usavano ed usano mezzi anticoncezionali empirici ma molto efficaci ed
ogni famiglia non procreava più di un figlio), infatti, veniva adibita a
svolgere lavori agricoli o lasciata a custodire le case in paese durante
l’assenza dei genitori impegnati nei campi. Prima di addentrarci ad
illustrare la figura di Mons. Pietro Camodeca, desideriamo riportare i
ricordi di Donna Giuseppina, nipote prediletta di Don Pietro, che ha
raccontato come si svolgeva la vita in Castroregio ai primi del ‘900 e
nella sua famiglia.
Casa Camodeca,
attigua alla chiesa, molto spaziosa ed articolata su tre piani con
numerose camere da letto, salone e biblioteca, dove erano presenti
migliaia di volumi (donati dopo le molte ruberie alla diocesi di
Lungro), era anche dotata di una magnifica terrazza dalla quale si
scorgeva il mare ed il golfo di Taranto. L’approvvigionamento dell’acqua
per bere si faceva con i muli e con i barili che si riempivano ad una
fontana situata all’inizio del bosco, chiamata « Mastursi ››, dove vi
erano tre cannelle ed un abbeveratoio in pietra squadrata. Per le
faccende domestiche si usava l’acqua di cisterna, che veniva alimentata
con acqua piovana. La cisterna era costruita in modo che l’acqua prima
di essere usata passasse attraverso filtri naturali di varia dimensione
fino alla sabbia sottile, che tratteneva l’impurità grossolana ma anche
i microbi. Quando si svuotava la cisterna (operazione che si faceva ogni
4-5 anni), si era soliti porre nel fondo delle pietre di calce viva,
che, sciogliendosi, avrebbero reso l’acqua utilizzabile quasi potabile
(l’acqua di calce è un buon disinfettante). Si soleva porre anche una
sola anguilla, che aveva il compito di tenere pulita l’acqua da insetti
ed altri animali. La illuminazione della casa era fatta con luce a olio
e quando annottava il primo incarico della donna di servizio era quello
di riempire le lampade ad olio che sarebbero rimaste accese tutta la
notte. Poi si passò all’uso del petrolio e la casa molto grande era
piena di lumi a petrolio che spesso bisognava riempire. Solo nel 1918,
alla prima carica di olive a Frangili, fu deciso di “aggiustare” la casa
e, per l’occasione, si mise in atto un nuovo sistema di illuminazione,
che utilizzava il carburo come gas illuminante. Vi era una stazione di
distribuzione, dove veniva posto il carburo in pietra, che, a contatto
con acqua, produceva un gas chiamato « gas illuminante ››, che
attraverso tubi veniva portato in tutte le stanze di rappresentanza ed
una volta acceso illuminava gli ambienti. La casa era fornita di stalle
per i tanti muli, che necessitavano per il trasporto di persone e di
cose. Non vi erano, infatti, strade rotabili, che collegavano
Castroregio ai paesi vicini (Amendolara, Oriolo), per cui l’unico mezzo
di trasporto era il mulo. Venivano utilizzati muli martinesi (incrocio
tra cavalle murgese ed asini di Martina Franca) in quanto erano alti di
statura, molto forti ed abili specie ad attraversare corsi d’acqua in
piena. I numerosi mulattieri, che con le loro famiglie abitavano nei
pressi del palazzo, badavano alla cura degli animali, indispensabili
all’andamento quotidiano della vita della famiglia.
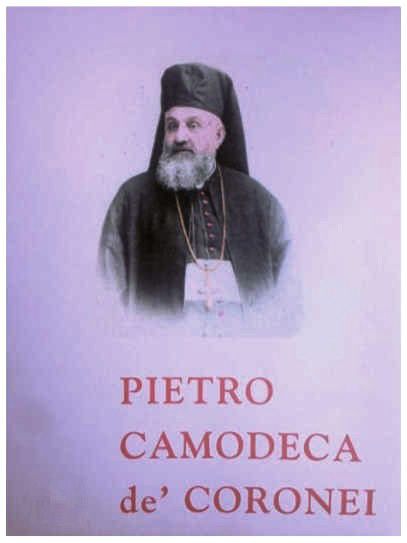
I componenti della
famiglia Camodeca de’Coronej erano i seguenti: Monsignor Pietro
Camodeca, Archimandrita di Oriente (equivaleva a Vescovo dal momento che
non esisteva un vescovo cattolico di rito albanese, come attualmente è
il Vescovo di Lungro; le autorità ecclesiastiche gli avevano conferito
questo titolo equipollente). Crispino Camodeca, proprietario terriero,
che fu Sindaco di Castroregio per tutta la sua vita;

Domenico Camodeca,
medico;
Alfonso Camodeca, Consigliere di Prefettura a Roma.
Riportiamo come
era composta più nei dettagli la famiglia di Mons. Pietro Camodeca
FAMIGLIA
CAMODECA
La famiglia era
così formata:
- Monsignor Pietro Camodeca de’Coroney,Archimandrita di Oriente
- Crispino Camodeca e Rosa Rusciani, sua moglie, che ebbero i seguenti
figli:
- Carolina che sposò Salvatore Lonigro, notaio: (5 figli)
- Antonio
- Crispino
- Armando
- Titina
- Rosa
- Marietta che sposò Costantino Blumetti, proprietario terriero (3
figli)
- Serafina
- Ettore
- Anna
- Salvatore che sposò Dilla Parapugna
- Francesco, medico, morto a 25 anni.
- Giuseppina che sposò Eugenio Molfese, medico (3figli)
- Francesco - Giuseppe - Antonio
- Domenico Camodeca, medico in Castroregio, che sposò Isabella Smilari
- Alfonso Camodeca, consigliere di Prefettura in Roma, che sposò Rita
Marongiu Solinas
- Giuseppe Camodeca, proprietario , che sposò Lucia Camodeca (4 figli)
- Salvatore
- Francesco, Parroco di Civita
- Agostino, Presidente Corte di Appello di Napoli
- Antonio Camodeca, proprietario terriero, che sposò Maria Rosa Camodeca
(3 figli)
- Pietro
- Francesco
- Domenica
- Caterina Camodeca che sposò Parisio Camodeca (4 figli)
- Domenico
- Francesco Antonio
- Rosa
- Domenica La vita religiosa era appannaggio di uno della famiglia
Monsignor Pietro Camodeca de’ Coronej, come avremo modo di leggere più
diffusamente in seguito.
|
 |
Crispino Camodeca,
padre di donna Giuseppina, era il sindaco del paese ed avendo la
passione per la caccia per Natale organizzava la caccia al
cinghiale nei boschi e poi inviava regali (pezzi di selvaggina)
agli amici, sparsi per la nostra regione e anche nelle regioni
limitrofe, a mezzo di corrieri espressi, mulattiere con
quadrupede fino alla stazione di Amendolara e poi con il treno.
Il paese, infatti, non aveva strade rotabili e solo i quadrupedi
potevano trasportare le persone e le cose. Gli amici
ricambiavano i doni inviando frutta invernale: bergamotti,
arance, mandarini, castagne e dolci fatti in casa con mandorle e
miele. |
|

|
Domenico Camodeca,
prestò nel piccolo paese della Calabria, Castroregio, la sua
opera di medico. Studiò a San Demetrio Corone e conseguì la
laurea in medicina presso l’Università di Napoli nel 1883.
Aveva sposato, Isabella Smilari, e dopo una prima permanenza
come medico ad Alessandria del Carretto e a San Paolo Albanese
(dove aveva incontrato la moglie), vinse il concorso come medico
condotto. Alla proclamazione del Regno d’Italia, la forma più
diffusa ed organizzata di assistenza sanitaria nel paese era
certamente quella rappresentata dalle condotte mediche, istituto
attraverso il quale le amministrazioni comunali, da sole o in
consorzio, stipendiavano un sanitario per l’assistenza gratuita
della popolazione povera. L’assistenza sanitaria di condotta era
quindi disponibile per circa un terzo della popolazione
italiana; tuttavia tale media nazionale celava profonde e
sostanziali diversificazioni della diffusione della condotta
medica. Era l’uomo che senza aiuto era capace di fare miracoli
ed imprese incredibili; a disposizione dei pazienti per l’intero
arco della giornata, a Pasqua e a Natale, a Ferragosto ed a
Carnevale, di giorno e di notte. Aveva funzioni di pubblico
ufficiale, esplicava la medicina preventiva, che quasi non
esisteva, esercitava il controllo igienico, si fa per dire,
nella circoscrizione del comune, praticava le vaccinazioni
obbligatorie (quasi assenti a quei tempi) ed altri controlli,
effettuava le prime rilevazioni necroscopiche e curava
soprattutto le ferite da arma, in quanto frequenti erano le
risse e spesso spuntavano i coltelli. Le difficoltà ambientali
di diagnosi e di cura efficace, con gli scarsi mezzi a
disposizione e le medicine di allora, il medico le affrontava
con la forza della disperazione, come anche eventi morbosi
spesso più grandi di lui. Ricoverare a quell’epoca un malato in
ospedale, che per la maggior parte dei casi distava ore ed ore
di viaggio tormentoso su strade impossibili a bordo di un
quadrupede fino alla ferrovia con i mezzi approssimativi di
allora, costituiva un caso di coscienza; il malato sarebbe
arrivato in condizioni disperate vanificando qualsiasi tentativo
di cura fosse stato intrapreso ed inoltre il ricovero
ospedaliero sarebbe stato oneroso ed avrebbe assestato un fiero
colpo alle magre finanze familiari (allora l’assistenza
sanitaria era completamente a carico del cittadino). Si
preferiva invece far visitare il paziente che non guariva a
qualche medico di un paese vicino che aveva maggiore esperienza
e che quindi poteva aiutare il giovane collega a formulare una
diagnosi e prescrivere una terapia risolutiva. Allora, all’epoca
del nostro medico classe 1860, laurea 1883, la farmacopea era
dominata da farmaci galenici, oltre che da una lista di farmaci
di pronto soccorso o di impiego più rischioso che il medico si
procurava personalmente e custodiva gelosamente nell’armadio
farmaceutico; dal momento che non vi era farmacia, potevano
essere adoperati tempestivamente laddove la necessità lo avesse
richiesto, come nel corso di una tormenta di neve o in una
località distante molti chilometri dal più vicino centro
abitato. Oltre all’onnipresente chinino, l’armamentario
farmaceutico si avvaleva della valeriana, del laudano, della
belladonna, che in opportune misture riuscivano a risolvere
molti casi. Comparivano i sieri, uniche armi contro le affezioni
batteriche, gli infusi di digitale, gli impacchi di linseme, gli
impiastri, i preparati bromoiodici ed jodarsenici, quelli
mercuriali, gli elisir, la canfora, il calomelano, l’olio di
fegato di merluzzo, la china aromatica e ferrata, i liquori
arsenicati, la caffeina, la bromo-lecitina, il salicilato di
sodio, il boldo, la polvere di liquirizia, la stricnina ed altri
preparati che oggi farebbero sorridere il giovane medico. Alcuni
aspetti particolari coinvolgevano in quell’epoca l’opera del
medico, giovane e preparato, ed interferivano con la serenità
del suo svolgimento: aspetti che per i medici di oggi possono
sembrare assurdi o patetici ma che allora potevano avere un peso
(voglio riferirmi ad esempio alla convivenza e alla lotta con le
superstizioni). Di fronte all’impotenza di allora della medicina
ufficiale, era comprensibile da parte di popolazioni così
sensibili e rassegnate alla legge della natura, il ricorso
all’aiuto del sovrannaturale o meglio dell’extranaturale. Il
bacio della mano che veniva tributato, e che ancora oggi è in
qualche caso praticato, al medico tra le nostre genti, non era
altro che un’ancestrale identificazione del potere misterioso e
lontano del bene tradotto nelle spoglie tante volte modeste
“dell’artefice del miracolo della guarigione e del recupero
delle facoltà fisiche vitali”. Questo era anche il motivo per
cui la popolazione era solita usare rimedi naturali per la cura
di quasi tutte le malattie, così come avevano fatto i loro
antenati. Erano in uso vini ed oli medicati, in questo favoriti
dall’ottimo vino ed olio che si produceva nel paese, e la
povertà del luogo induceva poi ad utilizzare medicine popolari
tradizionali del popolo. |
 |
 |
 |
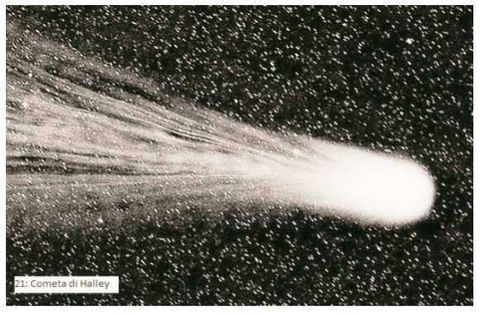 |
Alfonso Camodeca,
consigliere di prefettura, che lavorava a Roma, nelle feste
comandate rientrava in famiglia.
Era il 1910, il mese di
Maggio, quando passavamo le notti insonni per osservare la
cometa con la coda (Cometa di Halley); l’attesa era spasmodica
dal momento che era stata messa in giro la voce che con l’evento
celeste sarebbe venuta la fine del mondo. Quando arrivava Natale
la famiglia si riuniva per la grande festa. Dei fratelli quattro
vivevano nella stessa casa con le rispettive famiglie e sono
vissuti insieme per tutta la vita. Per le feste natalizie e
specie per il cenone si preparava la tavola con posate e
candelabri d’argento per illuminare il pranzo di Natale, dal
momento che a Castroregio non vi era luce elettrica. Al focolare
si poneva un grosso ceppo, sia perché la stagione era molto
rigida e sia perché c’era la leggenda che la Madonna asciugava
al fuoco i panni che erano serviti per avvolgere Gesù alla sua
nascita. Natale così come tutte le altre solenni festività si
passava in famiglia, data anche la difficoltà degli spostamenti
ed il clima inclemente. Durante il periodo della quaresima il
vescovo della Diocesi S. E. Pulvirenti (allora Castroregio era
nella Diocesi di Anglona- Tursi ora è nella Diocesi di Cassano
Ionio) arrivava con due predicatori siciliani e il segretario
particolare. Nel giorno dell’arrivo il Sindaco del paese si
recava alla stazione di Amendolara per ricevere il Vescovo e
condurlo a dorso di mulo a Castroregio, dove non vi era un
albergo e si doveva far carico di ospitarlo con vitto e alloggio
per almeno 15 giorni per tutta la durata della visita con tutto
il seguito. Dal momento che si era in quaresima e il digiuno
carneo era stretto, la padrona di casa doveva inventare menù per
permettere agli illustri ospiti di non trasgredire alle regole
(per la quaresima il digiuno carneo si osservava tre volte alla
settimana: martedì, mercoledì e venerdì). Oltre che di pesce
salato (baccalà o stoccafisso) si faceva uso di pesce fresco,
per il cui approvvigionamento si inviava a Taranto uno dei
mulattieri, il quale viaggiava di notte perché il pesce, di
qualità, fosse servito agli illustri ospiti all’ora di pranzo. A
Trebisacce si trovava anche il pescato fresco, ma quello di
Taranto era più prelibato per specie e per sapore. Le case,
anche se signorili, erano sprovviste di acqua corrente, luce
elettrica e di riscaldamento, per cui era problematico, alcune
volte, poter offrire un soggiorno accettabile, ma era il solo
che la comunità più in vista potesse offrire. Quando fu il
momento di rimodernare la casa, la famiglia Camodeca fu
costretta a trasferirsi in un’altra abitazione durante il
periodo dei lavori. Dal momento che la madre era paralizzata, a
causa di un ictus cerebrale, il trasporto fu problematico così
come la permanenza nella nuova casa, data anche la mancanza di
comodità. Per “accomodare” la casa e fare il calcestruzzo furono
chiamati specialisti del cemento che venivano da Milano, che
usavano sabbia del mare portata a dorso di mulo e avevano cura
di fare gli impasti nelle ore meno calde della giornata. Donna
Giuseppina ricorda che vi era un vicino di casa molto vecchio,
di nome Giovanni, che riceveva un vitalizio da suo padre in
cambio della casa alla sua morte. Accadeva che con le amiche
giocava vicino alla sua casa e lo prendeva in giro, per cui lui
continuava a dire che lei veniva a rendere la sua vita difficile
e accelerava la sua morte per entrare così più in fretta in
possesso dell’abitazione. Pensiero di vecchio: « Per altri fini
viene qui ››, continuava a ripetere Giovanni. Ricorda che quando
la sorella Carolina andò in sposa al notaio Lonigro di Terranova
10/10/1910, il corteo nuziale, ora a bordo di macchine, allora a
bordo di cavalcature, si snodava lungo la strada per andare a
Terranova; bisognava attraversare il bosco di Castroregio, San
Lorenzo Bellizio, Alessandria del Carretto e poi attraverso la
porta del Pollino scendere a Terranova. Era un corteo di oltre
100/150 tra cavalli e muli tirati ognuno da mulattiere, dal
momento che con questo mezzo bisognava trasportare anche la dote
(bauli pieni di lenzuola, coperte e cose del genere). Giuseppina
era piccola (aveva 8 anni) e per paura di perderla nella folla
fu posta in testa alla cavalcata e così apriva il corteo.
All’entrata del paese di Terranova le persone che erano venute a
ricevere la sposa dicevano “ Don Salvatore ha scelto per moglie
una bambina “. Anche in questa occasione i terranovesi
mostrarono la loro poca perspicacia. Appena adolescente , da
sola, dopo la perdita dei genitori e dei fratelli partiti per la
guerra, Giuseppina ha dovuto mandare avanti il ménage
famigliare, molto gravoso per le numerose incombenze che le
proprietà della casa e della famiglia le imponevano. Le due
sorelle erano andate spose e quindi vivevano lontano.
Tra i ricordi di Donna Giuseppina spicca quello del suo lavoro
da adolescente, in quanto, appena sedicenne, dovette mandare
avanti la casa, essendo morti i genitori nel 1915. Monsignore
Camodeca aveva comprato nel 1912 dai Principi Pignatelli un
oliveto, « Frangili », con oltre 1000 piante di olive, con una
masseria a due piani posta al lato sinistro del fiume Ferro,
oltre abitazioni per i coloni ed un trappeto per la molitura
delle olive. Per rendere efficiente il trappeto fece montare una
turbina a vapore di locomotiva che permetteva di spremere l’olio
dai fiscoli.
Ai primi sentori della guerra furono fatte « le carte ›› per
evitare il militare a uno dei fratelli, ma non fu possibile, per
cui sia Salvatore, dottore in legge, che Francesco(chiamato
Ciccio), medico, dovettero partire per la guerra. Nel 1918 si
ebbe una « carica di olive ›› e la giovane,da sola, dovette
amministrare la proprietà (aveva solo 16 anni d’età). Bisognava
trovare personale per la raccolta e la molitura delle olive.
Fortunatamente la manodopera non mancava perché allora, essendo
tempi duri, la povertà regnava sovrana e ognuno si adattava a
qualsiasi tipo di lavoro. Il salario mensile era di 1/2 tomolo
di grano, 1 stoppello di legumi, 1 litro di olio e 4 lire di
soldi. Alla fine della raccolta veniva anche dato un pagamento
suppletivo in natura (olio) ed era una manna dal cielo. Solo
verso il novembre del 1918 suo fratello Ciccio, medico, ebbe il
permesso di venire dal fronte e si fermò un po’a casa ad
aiutarla. La molitura delle olive avveniva in campagna dove
c’era un trappeto, che veniva condotto durante la stagione
olearia da operai stagionali leccesi, che durante la stagione
della raccolta delle olive passavano in squadre per la Puglia,
la Basilicata e la Calabria. Venivano pagati con 10 lire al mese
oltre al vitto e l’alloggio. Erano per lo più muratori, che,
durante il periodo di magra per il loro mestiere, si adattavano
a fare i « trappitari ›› per mandare avanti la famiglia Per
andare a Frangili da Castroregio bisognava attraversare il fiume
Ferro a dorso di mulo. Infatti, tutti i trasporti di persone,
specie attraverso i corsi di acqua, avvenivano a dorso di mulo
(sono questi ibridi, dotati di particolare forza e statura
elevata, che erano abituati ad attraversare corsi di acqua in
piena). Sull’imbasto sedeva la persona da trasportare e sulla
groppa sedeva il conducente, che durante il percorso incitava
con la cavezza il mulo e lo guidava anche con grida, specie nei
passaggi difficili. Nei periodi di piena l’acqua lambiva le
scarpe delle persone a dorso del mulo e quando il fiume
diventava impetuoso a causa della lunghe piogge, in quanto aveva
un lungo ed esteso bacino di impluvio, era impossibile
attraversarlo. Le persone che si trovavano dall’altra parte del
fiume dovevano scendere verso Roseto Capo Spulico, attraversare
il ponte ferroviario e attendere che l’acqua rientrasse
nell’alveo, solo così il fiume si poteva di nuovo guadare. Si
restava anche senza generi di prima necessità, per cui durante
la raccolta delle olive, per sfamare decine di persone, quando
veniva a mancare la farina si bolliva il grano e si mangiava il
grano condito con molto olio, genere che non mancava mai. Quando
poi funzionava il mulino si macinava il grano e con la farina si
riuscivano a sfamare squadre di donne addette alla raccolta di
olive. Oltre che in campagna vi era un trappeto anche in paese,
dove venivano molite le olive. Come forza motrice del molino
così come del trappeto veniva usata la vaporiera di una vecchia
locomotiva di treno, che sfruttava la forza del vapore prodotta
dall’energia termica per far girare le macine che erano di
pietra e che sfregandosi rendevano in polvere il grano.
Zio Monsignore morì il 18 settembre del 1918, pare per una
indigestione, dal momento che aveva la sera prima della morte
mangiato formaggio « di quaglio ›› in grande quantità. Questo
formaggio, per la eccessiva quantità di quaglio, provoca un
processo di trasformazione dei componenti del formaggio stesso
(proteolisi), che determina una particolare proliferazione dei
vermi, i quali, a furia di scavare la forma, la bucano e la
rendono simile al gorgonzola. Allora non si usava tenere sotto
controllo la pressione arteriosa per cui si pensa che zio
Monsignore sia morto per un ictus cerebrale provocato da un
eccesso di istamina presente nel formaggio. Alla sua morte era a
casa la nipote Carolina, la sorella maggiore di donna Giuseppina
che era venuta a passare qualche tempo a casa dei genitori.
Carolina era con Crispino appena nato, che era un macrosoma (un
bambino grande), ed Antonio con la cameriera ‘ndoniella .
Antonio era capriccioso e quando si intestardiva era capace di
piangere per ore. La madre, che era molto buona, ma di carattere
forte, non voleva cedere. Un giorno Antonio prese a piangere
perché voleva bere e questa operazione doveva essere compiuta
dalla mamma. Dal momento che ella era impegnata ad allattare il
bambino piccolo, non poteva accontentarlo; egli pianse per ore
prima di riuscire ad ottenere che la madre almeno toccasse la
lancella prima che ‘ndoniella lo facesse bere. Capricci di
bambini! La lancella era un recipiente di creta a forma di
anfora svasata e della capacità di circa un litro, che si poneva
alla finestra per tenere l’acqua fresca. Il principio per cui
l’acqua doveva essere sempre fresca era dovuto al fatto che
l’argilla, essendo porosa, faceva fuoriuscire dell’acqua che
evaporando abbassava la temperatura. La spagnola, malattia che
imperversò in tutto il mondo tra il 1918 e il 1919, non arrivò a
Castroregio, forse perché per mancanza di strade rotabili gli
scambi con persone infette furono molto limitati. L’unico mezzo
di trasporto era il quadrupede, per cui il batterio, o virus,
non si adattava al trasporto di questo mezzo. Dal momento però
che Castroregio era un paese, anche se piccolo, autonomo con
autorità costituita, le autorità sanitarie centrali per
prevenire l’epidemia inviarono tutte quelle provvidenze ritenute
necessarie per combattere il male (specie sostanze
disinfettanti). Non avendo scoperto l’esatta causa del male
(anche ora nonostante gli sforzi compiuti da scienziati e da
storici non si è riuscita ad individuare la causa della malattia
pur ipotizzando la sinergia di più batteri) si disinfettavano i
luoghi aperti al pubblico con calce viva, che era allora il
toccasana per la prevenzione delle malattie infettive, ed altri
disinfettanti dell’epoca. Accadde che la popolazione di questo
sperduto paesino vide arrivare, inviati dalle autorità centrali,
bidoni di disinfettanti che dovevano essere impiegati per la
disinfezione del paese, ma, forse anche sobillata da qualche
intellettuale «illuminato del posto ››, si ribellò e si oppose a
queste pratiche di disinfezione ritenute non necessarie e
perfino dannose. Si riunirono tutti sulla piazza principale, si
impadronirono del disinfettante scavarono una fossa e
seppellirono i fusti in profondità. Infatti, l’arrivo di questo
materiale era stato interpretato come un mezzo per diffondere il
male alla stessa stregua degli untori della peste di Milano. Fu
improvvisata una ballata che diceva: «faccia di sedere hai
portato la morte senza occasione ››. Castroregio forse fu uno
dei pochi paesi dell’Italia meridionale dove la spagnola non
arrivò proprio. Il miglior nemico per combattere tale malattia
era considerato il fumo di sigarette per giovani e anziani e
anche una zia di donna Giuseppina, Isabella (detta Bella),
settantenne, fumava; a dare queste indicazioni era stato un
medico di Oriolo, paese vicino.
Una polmonite portò a morte nel 1926 il fratello Francesco (il
cui nome venne trasmesso al coautore di questo libro su
richiesta della madre del coautore donna Giuseppina) che si era
laureato nel 1923 in medicina; Salvatore, l’altro fratello di
donna Giuseppina, alla fine della guerra andò al Ministero degli
Affari Esteri come funzionario di collegamento tra il Governo
italiano e il Governo albanese. Era stato creato un apposito
ufficio al Ministero degli Affari Esteri, che teneva relazioni
con lo stato albanese retto da re Zogu.
La vitalità di donna Giuseppina, morta a 105 anni, era tale che,
quando all’età di 84 anni, espresse il desiderio di conoscere la
terra da cui erano partiti i suoi antenati, con i figli Antonio
e Giuseppe e le rispettive mogli si decise di fare un viaggio in
Albania.
|
 |
 |
 |
 |
SECONDA PARTE - SEGUE >>
|
 anche
una stazione ferroviaria. Le condizioni sanitarie erano precarie, come
nella maggior parte dei paesi del sud, e vi esercitava un medico (non
esisteva una farmacia). Non vi era acquedotto comunale, ne’ rete
fognante e la erogazione dell’acqua proveniente da sorgenti locali
avveniva mediante fontanini pubblici posti fuori dal paese. Non vi era
posto telegrafico pubblico, ne’edificio scolastico e le scuole primarie
erano tenute presso la casa dell’unica insegnante che teneva insieme le
5 classi. La maggior parte dei fanciulli (pochi in quanto gli albanesi
usavano ed usano mezzi anticoncezionali empirici ma molto efficaci ed
ogni famiglia non procreava più di un figlio), infatti, veniva adibita a
svolgere lavori agricoli o lasciata a custodire le case in paese durante
l’assenza dei genitori impegnati nei campi. Prima di addentrarci ad
illustrare la figura di Mons. Pietro Camodeca, desideriamo riportare i
ricordi di Donna Giuseppina, nipote prediletta di Don Pietro, che ha
raccontato come si svolgeva la vita in Castroregio ai primi del ‘900 e
nella sua famiglia.
anche
una stazione ferroviaria. Le condizioni sanitarie erano precarie, come
nella maggior parte dei paesi del sud, e vi esercitava un medico (non
esisteva una farmacia). Non vi era acquedotto comunale, ne’ rete
fognante e la erogazione dell’acqua proveniente da sorgenti locali
avveniva mediante fontanini pubblici posti fuori dal paese. Non vi era
posto telegrafico pubblico, ne’edificio scolastico e le scuole primarie
erano tenute presso la casa dell’unica insegnante che teneva insieme le
5 classi. La maggior parte dei fanciulli (pochi in quanto gli albanesi
usavano ed usano mezzi anticoncezionali empirici ma molto efficaci ed
ogni famiglia non procreava più di un figlio), infatti, veniva adibita a
svolgere lavori agricoli o lasciata a custodire le case in paese durante
l’assenza dei genitori impegnati nei campi. Prima di addentrarci ad
illustrare la figura di Mons. Pietro Camodeca, desideriamo riportare i
ricordi di Donna Giuseppina, nipote prediletta di Don Pietro, che ha
raccontato come si svolgeva la vita in Castroregio ai primi del ‘900 e
nella sua famiglia.