|
PARTE TERZA
PRIMI
ALBANESI IN CALABRIA
|
 |
Con la liberazione della
penisola di Morea - cosi chiamata perché era appartenuta a Roma
e perché somiglia ad una foglia dell’albero di more, e di
Corone, città dominio di Genova e Venezia che controllava
l’impero ottomano, intorno al 1535, grazie al trattato di pace
di Costantinopoli, ad altri accordi diplomatici tra Carlo V e il
Sultano Solimene II e all’intervento di Andrea Doria, ammiraglio
genovese, alle nobili famiglie cattoliche greche albanesi della
città fu consentito l’espatrio nel Regno di Napoli. Carlo V,
stupito del loro valore e di come era stata difesa la città di
Corone,

inviò duecento navi
mercantili per trarre in salvo le famiglie nobili tra cui i
Camidi, da cui Camodeca, menzionati come “ciertos caballeros que
an venido de Coron”, i quali, temevano la vendetta dei
musulmani. Volendo omaggiare i profughi insignì loro del Regio
Cavalierato (REGIO CAVALIERATO CORONEO DIPLOMA IMPERIALE DATO IN
MOREA il 22/11/1533). “… potevano cavalcare con briglie e
speroni, non pagavano tasse e dazi, si potevano stabilire a loro
scelta in uno dei villaggi di Calabria Puglia Sicilia e
Basilicata, potevano portare armi per il regno ed era stato loro
assegnato un appannaggio di 70 ducati ”. Il viaggio dalla Morea,
distante dal Regno di Napoli non oltre 900 miglia marine, alle
coste calabre e lucane fu compiuto a bordo di caravelle o galee,
che percorrevano con venti buoni in media 100 miglia al giorno,
per cui il viaggio durò 9/10 giorni più le fermate. Nel caso il
viaggio terminasse nel porto di Napoli, il tempo di percorrenza
si raddoppiava. I primi sbarchi avvennero a Napoli ed ancora
oggi vi sono delle zone dei vari quartieri di Napoli chiamate
quartieri dei greci o decumani. Il viaggio in nave necessitava
di approvvigionamento idrico, per cui, dove vi erano le
condizioni permettenti, le barche con carene piuttosto piatte
potevano avvicinarsi alla riva ai luoghi dove fare l’acquata
(cosi era chiamato il rifornimento idrico). I viveri non
deperibili, stipati nelle navi, permettevano ai fuggitivi di
alimentarsi a sufficienza data anche la brevità del tragitto.
Oltre che qualche suppellettile di pregio, oggetti personali
(abiti, gioielli ed altro), furono portati sulla nave anche
cavalli, che sarebbero serviti per la sistemazione dei primi
campi provvisori. Scrive Bisignano: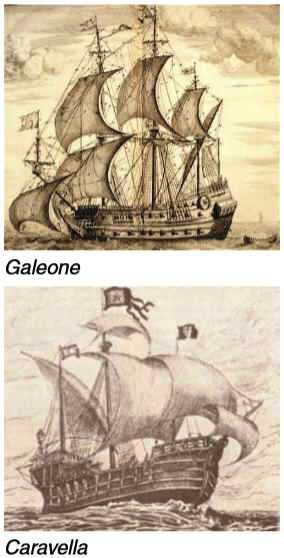 ” Vi erano state in precedenza altre emigrazioni di greci
albanesi, ma quella del 1535 fu senza dubbio la più consistente
emigrazione di un popolo, che aveva resistito per molti decenni
con tanto eroismo all’invasione dei Turchi, e che era costretto
a lasciare con tanta amarezza, per sempre, la terra natia,
privandosi delle cose più necessarie, approdando in lidi di
popoli stranieri, con idioma, usi, costumi differenti dai
propri, sorretto, soltanto dalla fede in Dio e dalla speranza di
trovare nelle nuove terre condizione di vita migliore . A tale
proposito il Papa Paolo II in una lettera indirizzata a Filippo
Duca di Borgogna – descriveva, con drammatici accenti, la
miserevole condizione dei profughi sbarcati in Italia. Molti di
questi albanesi si fermarono a Napoli, altri nell’isola di
Lipari, mentre, in gran parte, preferirono stabilirsi nei vari
paesi dell’Italia meridionale ed insulare, già popolati dai loro
connazionali nelle precedenti migrazioni. Un altro gruppo di
profughi, fondarono o ripopolarono in Lucania, in provincia di
Potenza, i paesi: Barile, Brindisi di Montagna Maschito,
Ginestra, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, Giorgio
Lucano o Mendullo; in provincia di Cosenza: Castroregio e
Farneta, in Campania, provincia di Avellino, Greci. Questi
godettero, a differenza degli altri profughi, della protezione
del Sovrano di Spagna, di privilegi speciali, come quello di non
pagare dazi fiscali, di potersi stabilire nei villaggi albanesi
delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, come si evince da
una lettera — dispaccio dell’Imperatore Carlo V, inviata da
Genova l’8 aprile del 1533 al Viceré di Napoli, con la quale lo
stesso disponeva l’assegnazione di villaggi e terre “in Puglia o
in Calabria o altra parte di cotesto reame onde a noi sembra
possono vivere e mantenersi, con un appannaggio di settanta
ducati di moneta dalla nostra tesoreria all’anno”.
“L’inserimento sociale dei profughi consentì anche il
ripopolamento di terre abbandonate e, quindi, una nuova
espansione demografica, con la formazione di ambienti culturali
omogenei, ma incontrò, per lo più, la diffidenza e
l’incomprensione degli abitanti del luogo. I baroni feudali ed
ecclesiastici ne sfruttarono la miseria, inserendoli nei lavori
più umili, perché ritenuti “barbari e rozzi”, a causa dei loro
“riti magici”, dell’appartenenza alla chiesa ortodossa
d’Albania, separata da Roma, dopo lo scisma d’oriente del 1054.
Disperazione, miseria, ribellione e servitù accompagnarono le
famiglie di quanti coraggiosamente scelsero la terra straniera,
piuttosto che la sottomissione ai Turchi. Avevano lasciato ogni
cosa nella terra di origine, compreso il loro cuore, ma
portarono con loro un ricco patrimonio spirituale e culturale”
Dunque, un popolo, quello di cui parla lo scrittore Bisignano,
che, nonostante fosse fortemente avversato in terra straniera e
sopraffatto dalle comunità locali, in condizioni di estremo
bisogno e di forte sudditanza nei confronti dei feudatari, non
si arrese, non chinò il capo, non dimenticò la storia di popolo
martoriato, ma lottò, tenacemente, per sopravvivere, ma anche
per mantenere viva la propria identità, la fede e le tradizioni
dei Padri. Fu così che sorsero intorno alla metà del 1500 nella
parte meridionale del regno di Napoli altre colonie albanesi.
Tra questi primi profughi vi furono gli antenati di Pietro
Camodeca, che si insediarono alle falde del monte Pollino e che,
dopo un villaggio di capanne provvisorie tra i boschi, fondarono
il paese di Castroregio (il nome deriva da quello di un castello
regio che sorgeva sulla sommità del monte). Circa la nascita e
l’insediamento di Castroregio sono state avanzate varie
versioni, rimandiamo ai vari autori che hanno illustrato la
storia. Sui contrafforti del monte Pollino in Calabria, come
“scrive Laviola”, sorse il primo casale dove presero momentanea
dimora i profughi venuti dalla Morea sul piano tra le querce di
Cerviola, fatto di capanne a paglia, chiamato Xorza, che
significa piccola città. A Castroregio, nel 1534, giunsero,
provenienti da Corone, le famiglie Di Lazzaro, Ierovante,
Camodeca, Pappadà ed altre, che si unirono alla “popolazione già
esistente” ……. Alcune famiglie, tra cui i Camodeca, come scrive
sempre Laviola, diedero una sistemazione urbanistica al
villaggio, che secondo alcune fonti, era già stato fondato. Con
la costruzione della chiesa il nuovo insediamento, chiamato poi
Castroregio, fu trasferito sulla sommità di una altura, e con la
costruzione delle prime case acquistò l’aspetto di un paese.
Come nido d’aquila si specchiava sull’alto Jonio, sul quale
avevano veleggiato le navi dei profughi provenienti dalla
opposta sponda dove sorgeva la patria di origine. Il paese sorge
tra il fiume Ferro ed il fiume Straface, su una sommità a quota
819 metri. Il panorama è incantevole, perché quivi è possibile
osservare il golfo di Taranto in tutta la sua magnificenza. Da
ricerche effettuate anche dal Prof. Laviola, è stato confermato
che la famiglia Camodeca è stata una famiglia di spicco nella
piccola comunità fin dal suo nascere; vi mantenne una
superiorità incontrastata e ne condizionò la vita religiosa,
politica ed amministrativa, un feudalesimo non legalizzato, ma
di fatto esistente. Ebbero in mano le redini che condizionarono
lo sviluppo del paese e la loro casa, dominante e attigua alla
chiesa, fu il centro del paese, dove risiedevano tutti i membri
della famiglia. La famiglia Camodeca per il ruolo predominante
che ha esercitato nel piccolo paese ha conservato alcuni
registri di battesimo risalenti alla fine del 1500, ridotti, in
verità, un po’ male, forse a causa di un principio d’incendio,
ma salvati e sottratti definitivamente all’inclemenza del tempo
ed all’incuria degli uomini. Salvatore Camodeca, unico erede
maschio vivente della famiglia, senza prole, ha curato nei
limiti del possibile la conservazione della casa di Castroregio
disabitata ed ha limitato lo scempio che ladri e vandali hanno
compiuto nella casa di famiglia. Il fratello Francesco, altro
erede, appena dopo la laurea in medicina all’età di 25 anni morì
di polmonite. La nobile famiglia esercitò una figura di spicco
nel paese senza interruzioni fino agli albori del nuovo Regno
d’Italia, perché fu proprio un Camodeca il primo sindaco di
Castroregio, dopo la caduta dei Borboni.
” Vi erano state in precedenza altre emigrazioni di greci
albanesi, ma quella del 1535 fu senza dubbio la più consistente
emigrazione di un popolo, che aveva resistito per molti decenni
con tanto eroismo all’invasione dei Turchi, e che era costretto
a lasciare con tanta amarezza, per sempre, la terra natia,
privandosi delle cose più necessarie, approdando in lidi di
popoli stranieri, con idioma, usi, costumi differenti dai
propri, sorretto, soltanto dalla fede in Dio e dalla speranza di
trovare nelle nuove terre condizione di vita migliore . A tale
proposito il Papa Paolo II in una lettera indirizzata a Filippo
Duca di Borgogna – descriveva, con drammatici accenti, la
miserevole condizione dei profughi sbarcati in Italia. Molti di
questi albanesi si fermarono a Napoli, altri nell’isola di
Lipari, mentre, in gran parte, preferirono stabilirsi nei vari
paesi dell’Italia meridionale ed insulare, già popolati dai loro
connazionali nelle precedenti migrazioni. Un altro gruppo di
profughi, fondarono o ripopolarono in Lucania, in provincia di
Potenza, i paesi: Barile, Brindisi di Montagna Maschito,
Ginestra, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, Giorgio
Lucano o Mendullo; in provincia di Cosenza: Castroregio e
Farneta, in Campania, provincia di Avellino, Greci. Questi
godettero, a differenza degli altri profughi, della protezione
del Sovrano di Spagna, di privilegi speciali, come quello di non
pagare dazi fiscali, di potersi stabilire nei villaggi albanesi
delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, come si evince da
una lettera — dispaccio dell’Imperatore Carlo V, inviata da
Genova l’8 aprile del 1533 al Viceré di Napoli, con la quale lo
stesso disponeva l’assegnazione di villaggi e terre “in Puglia o
in Calabria o altra parte di cotesto reame onde a noi sembra
possono vivere e mantenersi, con un appannaggio di settanta
ducati di moneta dalla nostra tesoreria all’anno”.
“L’inserimento sociale dei profughi consentì anche il
ripopolamento di terre abbandonate e, quindi, una nuova
espansione demografica, con la formazione di ambienti culturali
omogenei, ma incontrò, per lo più, la diffidenza e
l’incomprensione degli abitanti del luogo. I baroni feudali ed
ecclesiastici ne sfruttarono la miseria, inserendoli nei lavori
più umili, perché ritenuti “barbari e rozzi”, a causa dei loro
“riti magici”, dell’appartenenza alla chiesa ortodossa
d’Albania, separata da Roma, dopo lo scisma d’oriente del 1054.
Disperazione, miseria, ribellione e servitù accompagnarono le
famiglie di quanti coraggiosamente scelsero la terra straniera,
piuttosto che la sottomissione ai Turchi. Avevano lasciato ogni
cosa nella terra di origine, compreso il loro cuore, ma
portarono con loro un ricco patrimonio spirituale e culturale”
Dunque, un popolo, quello di cui parla lo scrittore Bisignano,
che, nonostante fosse fortemente avversato in terra straniera e
sopraffatto dalle comunità locali, in condizioni di estremo
bisogno e di forte sudditanza nei confronti dei feudatari, non
si arrese, non chinò il capo, non dimenticò la storia di popolo
martoriato, ma lottò, tenacemente, per sopravvivere, ma anche
per mantenere viva la propria identità, la fede e le tradizioni
dei Padri. Fu così che sorsero intorno alla metà del 1500 nella
parte meridionale del regno di Napoli altre colonie albanesi.
Tra questi primi profughi vi furono gli antenati di Pietro
Camodeca, che si insediarono alle falde del monte Pollino e che,
dopo un villaggio di capanne provvisorie tra i boschi, fondarono
il paese di Castroregio (il nome deriva da quello di un castello
regio che sorgeva sulla sommità del monte). Circa la nascita e
l’insediamento di Castroregio sono state avanzate varie
versioni, rimandiamo ai vari autori che hanno illustrato la
storia. Sui contrafforti del monte Pollino in Calabria, come
“scrive Laviola”, sorse il primo casale dove presero momentanea
dimora i profughi venuti dalla Morea sul piano tra le querce di
Cerviola, fatto di capanne a paglia, chiamato Xorza, che
significa piccola città. A Castroregio, nel 1534, giunsero,
provenienti da Corone, le famiglie Di Lazzaro, Ierovante,
Camodeca, Pappadà ed altre, che si unirono alla “popolazione già
esistente” ……. Alcune famiglie, tra cui i Camodeca, come scrive
sempre Laviola, diedero una sistemazione urbanistica al
villaggio, che secondo alcune fonti, era già stato fondato. Con
la costruzione della chiesa il nuovo insediamento, chiamato poi
Castroregio, fu trasferito sulla sommità di una altura, e con la
costruzione delle prime case acquistò l’aspetto di un paese.
Come nido d’aquila si specchiava sull’alto Jonio, sul quale
avevano veleggiato le navi dei profughi provenienti dalla
opposta sponda dove sorgeva la patria di origine. Il paese sorge
tra il fiume Ferro ed il fiume Straface, su una sommità a quota
819 metri. Il panorama è incantevole, perché quivi è possibile
osservare il golfo di Taranto in tutta la sua magnificenza. Da
ricerche effettuate anche dal Prof. Laviola, è stato confermato
che la famiglia Camodeca è stata una famiglia di spicco nella
piccola comunità fin dal suo nascere; vi mantenne una
superiorità incontrastata e ne condizionò la vita religiosa,
politica ed amministrativa, un feudalesimo non legalizzato, ma
di fatto esistente. Ebbero in mano le redini che condizionarono
lo sviluppo del paese e la loro casa, dominante e attigua alla
chiesa, fu il centro del paese, dove risiedevano tutti i membri
della famiglia. La famiglia Camodeca per il ruolo predominante
che ha esercitato nel piccolo paese ha conservato alcuni
registri di battesimo risalenti alla fine del 1500, ridotti, in
verità, un po’ male, forse a causa di un principio d’incendio,
ma salvati e sottratti definitivamente all’inclemenza del tempo
ed all’incuria degli uomini. Salvatore Camodeca, unico erede
maschio vivente della famiglia, senza prole, ha curato nei
limiti del possibile la conservazione della casa di Castroregio
disabitata ed ha limitato lo scempio che ladri e vandali hanno
compiuto nella casa di famiglia. Il fratello Francesco, altro
erede, appena dopo la laurea in medicina all’età di 25 anni morì
di polmonite. La nobile famiglia esercitò una figura di spicco
nel paese senza interruzioni fino agli albori del nuovo Regno
d’Italia, perché fu proprio un Camodeca il primo sindaco di
Castroregio, dopo la caduta dei Borboni.
Infatti, il decreto di nomina é del 22 settembre 1861, si legge:
<< Una tale scelta non è come altra volta l’effetto della
isolata fiducia del Governo, ma sibbene di quella fiducia che,
partendo dalla pubblica opinione, e per mezzo di voti, determina
il governo attuale a valutare i pregi dello Individuo, e
chiamarlo alla carica, facendosi sacrifici degli interessi dj
Famiglia, per applicarsi temporaneamente al vantaggio pubblico e
corrispondere all’aspettazione dei cittadini, dando opera ad
energica, patriottica ed onesta amministrazione ». Sacrificare
gli interessi di famiglia per il vantaggio pubblico era, come é
scritto a chiare lettere, il primo compito dell’uomo politico di
allora Salvatore Camodeca, che aveva sofferto il carcere, perché
in una perquisizione, eseguita nella sua casa, era stata trovata
una copia dello Statuto della Giovine Italia. Questa era la
stirpe, questo il paese e questa la famiglia di Pietro Camodeca
de’Coronei.
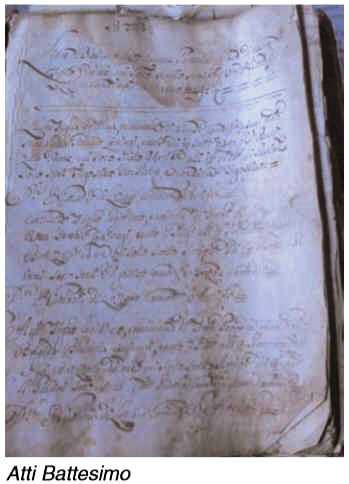

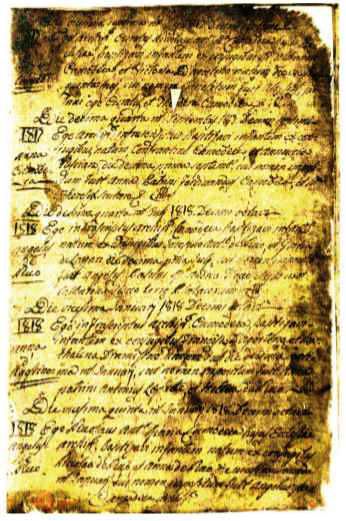
|
 |
 |
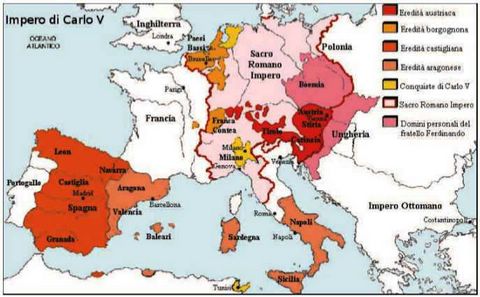 |
|
 |
 |
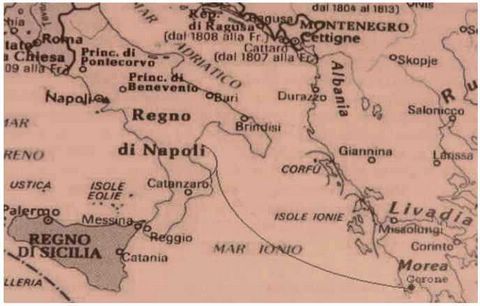 |
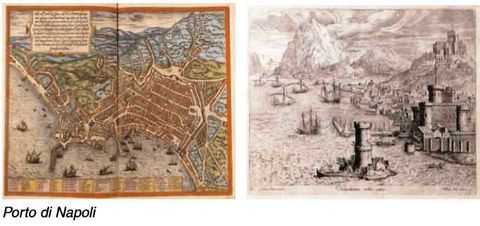 |
 |
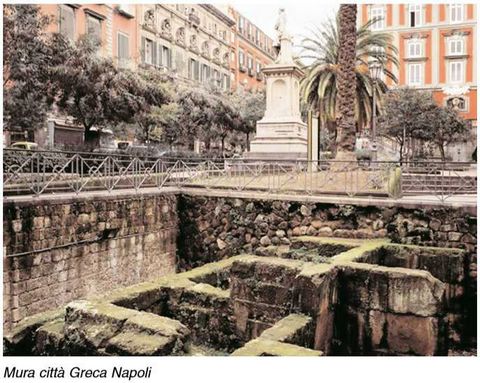 |
|
 |
B) INFANZIA, PRIMI
STUDI E ORDINAZIONE SACERDOTALE
Pietro Camodeca nasce l’11
Ottobre 1847 da Francesco Camodeca e Rosina Basile, in un
periodo turbolento in quanto si stava realizzando l’unità
d’Italia. Frequentò le scuole elementari nel suo paese ed in
seguito continuò gli studi nel Collegio italo-greco di San
Adriano in San Demetrio Corone, nel quale dimorerà per sei anni
consecutivi in qualità di alunno interno. Il Collegio di S.
Demetrio giocò un ruolo di primaria importanza nella vita
sociale e politica delle colonie albanesi di Calabria e di
Basilicata. Dopo il 1860, proprio nel periodo in cui Pietro
Camodeca fu alunno del Collegio, erano tornati i vecchi
professori con a capo il Marchianò, colui il quale nel 1848,
chiuso il Collegio, era corso con tutti gli alunni a combattere
a Campotenese. Nel 1860 Garibaldi attraversando la Calabria sale
verso Napoli e le sue schiere si ingrossano anche con il
contributo degli italo albanesi, i quali ebbero per lui una
stima e una adorazione sincera e profonda confinante con
l’idolatria, perché riconoscevano in lui le virtù che erano
state possedute in sommo grado dal loro eroe Scanderbeg. Nel
Collegio Italo greco di San Demetrio egli apprese a meraviglia
il latino ed il greco. Gli alunni gareggiavano a scuola, due
volte la settimana, oltre che con le lezioni giornaliere, a ben
comporre in prosa e versi ed i più distinti erano fatto segno
all’attenzione di tutto il convitto, mediante pubbliche lodi e
con particolare trattamento a pranzo e a cena. Pietro Camodeca
rivelò subito il suo ingegno vivace e si affermò come uno degli
alunni più preparati. Sveglio ed attivo, studiò con serietà e
gettò le basi solide di quella preparazione umanistica che lo
accompagnò per tutta la vita, ponendolo sempre su un piano di
prestigio. Le sue simpatie erano per la lingua greca, che gli
divenne molto familiare. Nell’anno scolastico 1865-66 riportò il
premio della medaglia d’onore per essersi distinto negli esami
finali. Dopo sei anni di permanenza, Pietro Camodeca, deciso a
seguire gli studi teologici e intraprendere la carriera
ecclesiastica, dovette cambiare sede, perché, dal1864, la scuola
di San Demetrio era stata costituita in Ginnasio-Liceo,
assoggettata conseguentemente alle leggi dello Stato ed erano
stati soppressi gli studi del ramo ecclesiastico. Egli lasciò,
pertanto, il collegio, e la sua <<montagnola folta di querciuoli
che con la sottostante luminosa vallata aveva acceso il suo
estro poetico>>, prese congedo dagli amici numerosi e dalle
famiglie, che tante volte lo avevano avuto ospite, e si trasferì
nel Seminario di Tursi, sede della diocesi a cui apparteneva la
natia Castroregio. Tursi era un piccolo centro nel cuore della
Basilicata e dal 1500 sede dell’antica diocesi di Anglona, di
cui rimane in piedi solo la cattedrale del secolo XI, alta su un
colle sovrastante la pianura di Policoro, l’antica Eraclea della
Magna Grecia.
.
A Tursi fu costretto a
trasferirsi per intraprendere gli studi di teologia; comincia
una nuova vita per lui: diversi gli studi, diversi i professori,
diverso il rito nelle funzioni della chiesa, diverso perfino il
linguaggio dei suoi colleghi. Appena ventenne, il Camodeca era
già padrone della lingua greca e di quella latina; non ci
meraviglia, il fatto che, essendo ancora seminarista, il vescovo
Acciardi, conosciutolo ed apprezzatolo, gli affidò l’incarico
dell’insegnamento del greco, che accettò con entusiasmo,
iniziando cosi una delle attività giovanili a lui più care:
l’insegnamento. I suoi discepoli, che poi erano quasi suoi
coetanei, lo stimavano perché riconoscevano in lui la
superiorità che gli derivava dalla preparazione e dalla
formazione. Nell’insegnamento egli portò il fervore del neofita,
l’erudizione dello studioso e la dirittura del sacerdote, fermo
nelle sue credenze, egli, che era diventato prete non per
calcolo. Nell’anno scolastico 1868-69 venne nominato insegnante
di latino e greco nell’Istituto Petta di Oriolo Calabro, un
paese che rappresentava, in quell’epoca, un centro di studi in
cui confluivano i giovinetti delle famiglie abbienti della zona.

Nel 1870-71 tornò
all’insegnamento nel Seminario di Tursi e, nello stesso tempo,
portò a compimento i suoi studi teologici. Non possedendo, però,
l’età prescritta per essere ordinato sacerdote chiese la
dispensa al Sommo Pontefice, accordata il 7 marzo del 1871, ed
il Camodeca venne ordinato Sacerdote dal Vescovo Acciardi il 25
marzo dello stesso anno, Domenica delle Palme. In precedenza,
dallo stesso Pontefice Pio IX — referente il Segretario della S.
Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari del Rito
Orientale — era stata data al Vescovo di Anglona e Tursi<< la
facoltà di conferire al chierico Pietro Camodeca gli ordini
minori e maggiori nel rito latino continuando, pero, lo stesso a
rimanere nel proprio rito greco » . Nell’anno scolastico 1873-74
viene chiamato ad insegnare storia e geografia nell’Istituto
Cirino di Napoli, per passare, l’anno successivo, a Viggiano,
professore di lingua latina e greca nel Collegio Silvio Pellico.
Appena giovinetto Camodeca con una precoce vena poetica a
ricordo dell’avvenimento, l’allontanamento da Corone, scrisse
una mirabile rapsodia pervasa da un’amarezza cocente. C’era in
essa lo strazio della partenza coatta e la nostalgia dei boschi,
delle terre e delle case di Corone. Un canto di sofferta
tristezza in cui si intrecciavano sentimenti di odio e di
disprezzo verso i Turchi.
“Le nostre
possessioni ed i nostri beni
noi li abbiamo lasciati in Corone;
ma abbiamo Cristo con noi!
O bella Morea!
Accorati e con gli occhi velati dal pianto
noi ti compiangiamo, o Albania! .......... …….
abbiamo Cristo con noi!
[…]
….. abbiamo la Santa Vergine Maria con noi!
O bella nostra Morea
…. ma abbiamo il Papa con noi! ,
O Morea;
O Albania! Addio….” |
 |
 |
|

Giuseppe Garibaldi |
 |
 |
|
 |
C) INSEGNAMENTO E
PRIME PUBBLICAZIONI
Nel Convitto Municipale di
Viggiano, dove era stato nominato vicerettore e direttore
spirituale, insegnò latino e greco. Nel grosso centro lucano,
dove fioriva un circolo di tendenze spiccatamente anticlericali,
Camodeca condusse numerose schermaglie e diatribe e rivelò la
sua indole di vivace polemista. Laviola, nel suo volume, ha
avuto la possibilità e l’occasione di riportare suoi scritti ed
appunti non sempre pubblicati; il suo lavoro è stato quello di
portare alla luce almeno le pagine inedite più significative e
tale impostazione giustifica, pertanto, le frequenti e numerose
citazioni.
La pubblicazione del
sonetto
<< Le tasse e le
consorterie in Italia »,
che riportiamo, causò la sua prima polemica.
<< Oh cara Italia, per giardini e ville
e per bellezze d’arte impareggiata:
vedi che in faccia al mondo t’han macchiata
turpi consorterie e camerille.
<< Di che ti vanti omai se cento e mille
ingrassano il tuo seno ed angariata
é la plebe che langue disprezzata,
_ e crescon di discordie le faville?
<< Mira una volta e piangi... in la sentina
é prostrata e languente e negli affanni
la gente robustissima latina!
<< Un giorno, sette... ed or molti tiranni
ti sbranano dai monti alla marina:
come ti sei ridotta in quindici anni!
Un anonimo sonetto di
risposta, sostenne di aver parlato male di Garibaldi, del quale
si esaltava il nuovo corso impresso all’Italia, ignorando,
l’anonimo, che il Camodeca non era un prete borbonico ed aveva,
anzi, al suo attivo una tradizione familiare di indiscusso
patriottismo. Pietro Camodeca ribatté e giustificò il contenuto
del suo sonetto, non risparmiando le sue frecciate all’anonimo.
Così rispose: << Tu non hai capito neanche per ombra il mio
sonetto. Io non parlavo di tasse e balzelli [….] Ma degli abusi
della camorra[…] - le tasse si devono pagare, esse sono la vita-
ma di tasse giuste; di camorra nella riscossione, mai! Senza
questa selva di impiegati, senza questa setta invereconda che ha
portato la miseria nelle famiglie e ritardato per scoraggiamento
le arti e le industrie in Italia, e con una (non parecchie
centinaia) buona, chiara e positiva legge di riscossione>>. <<
Smettete l’abito altiero dello aristocratico, scendete giù nel
basso ceto, procurate di convivere ed immedesimarvi un tantino
con questo……e vedrete come è amara e stentata la vita …..e
vedrete se la gente latina…..non è prostata nella sentina >>>
(sono parole che si adattano alla situazione attuale
dell’Italia, n.d.a.) La polemica non si esaurì e nuova esca al
fuoco fu gettata dal canonico Francesco Paolo Caputi, su un
periodico di Marsico Nuovo, << Il maestro elementare» n. 14 e 15
- 1875 >>, che sebbene l’abbiamo cercato nei vari archivi non
siamo stati in grado di reperirlo. Il Camodeca era giovane,
esuberante e non a corto di argomenti; perciò affrontò il nuovo
avversario con veemenza, determinazione ed argomenti
appropriati. Gli scritti originali, riportati da Laviola, nella
sua pubblicazione e che sono andati definitivamente perduti,
dimostrano, anche, che il carattere di Don Pietro non era dei
più dolci e che la sua penna non venne intinta nel miele. Egli
si faceva trascinare dall’impeto, era un combattente di razza,
difficilmente riusciva a frenare le irruenze e a dominare le
passioni. Forse ciò, in avvenire, creò situazioni tese e
rappresentò uno dei lati negativi del suo ministero sacerdotale,
ostacolando ascese che per tanti altri requisiti, egli avrebbe
meritato. Nel 1876 vide la luce in Napoli un volumetto dal
titolo “Dissertazione sulla pronunzia delle lettere greche “; la
prima pubblicazione di un certo impegno del “Mons. Pietro
Camodeca sacerdote di rito greco” come egli volle qualificarsi.
L’operetta sarebbe dovuta servire di prefazione ad un manuale di
grammatica greca, almeno secondo quanto asseriva l’autore
nell’avvertimento iniziale e nella prima pagina. <<Incoraggiato
da parecchi buoni amici, e da non pochi direttori di istituto, a
raccogliere qua e là tutto quello che finora i grammatici
scrissero di buono in fatto di lingua greca, e quindi a fare un
acconcio e succinto manuale, utilissimo per le scuole
secondarie, non potemmo resistere alle loro amorevoli insistenze
e ci accingemmo all’opera comunque malagevole e scabra ». << Ci
parve pero troppo sconveniente incominciare così di botto la
grammatica, senza esordire un pochino e chiarire con una breve
ed accurata critica, un punto di storia linguistica: la
pronunzia dell’alfabeto greco ».
L’autore si proponeva di dimostrare che “le lettere
dell’alfabeto greco si pronunziarono dai piu vetusti scrittori
di quella nazione, quali si pronunziano adesso in tutta la
Grecia e nelle sue colonie”. Scrive Laviola: ”Nell’operetta egli
accenna ad un suo scritto inedito dal titolo << Paleologia »,
che noi non abbiamo trovato tra le sue carte”.
Sappiamo, però, che in esso, egli cercò di dimostrare che
l’idioma albanese é l’elemento pelasgo restato in Grecia dopo
l’ultima emigrazione di questa gente, e che Erodoto nel libro I,
57, Tucidide nel libro IV, 109 e Platone nel Cratilo, chiamano
lingua pelasga” . I tranquilli soggiorni nei convitti, dove
prestò la sua opera, lo indussero a intensi studi filologici, un
siffatto genere di studi che, tra l’altro, rappresentava anche
la ricerca di un sussidio didattico. Diligenza encomiabile,
questa che era prerogativa di coloro i quali nell’insegnamento
portavano salda preparazione e calda passione, in una parola di
coloro che profondamente e sinceramente sentivano la vocazione e
il tormento del magistero. Numerosi sono gli appunti che egli
scrisse sugli argomenti che sarebbero stati trattati nelle sue
lezioni: appunti sul 1° libro dell’Iliade, su Socrate e ancora
osservazioni, etimologie e differenze notate studiando diversi
autori greci . La lingua greca, come si può facilmente notare,
rappresentò un polo di attrazione per il Camodeca; egli ne
divenne padrone e riuscì a coglierne tutte le sfumature. Mons.
Pietro fu un umanista per il quale la Grecia e Roma erano le
patrie ideali, in cui l’anima sua trovava appagamento e quiete e
intensamente ne godeva. Tra gli scrittori latini le sue
preferenze andarono al poeta Orazio. Molte lodi vennero
all’autore additato come un benemerito della diffusione della
cultura greca. Particolare interesse e valore rivestì la lettera
che Gerolamo De Rada gli scrisse a proposito di tale
pubblicazione; essa ci dimostrò, tra l’altro, che le relazioni
tra i due erano già in atto nel 1876. L’attività poetica
rappresentò un aspetto della personalità di Pietro Camodeca,
ingegno versatile e multiforme, il lato meno appariscente,
quello che egli con una certa ritrosia non volle scoprire, preso
com’era da studi severi e tutto assorbito dalla realizzazione di
alcune iniziative che avrebbero avuto risonanza larghissima tra
le popolazioni di origine albanese dell’Italia meridionale. Fu
quella poetica un’attività preminentemente giovanile: versi di
un collegiale, che rimasero inediti. Il manoscritto, che anche
nel titolo << L’Olimpo>> di Pietro Camodeca denotò il giovanile
entusiasmo e la mentalità scolastica dell’autore, recava la data
del 1868. I versi furono scritti durante la sua permanenza nel
Collegio di San Demetrio e nel Seminario di Tursi. I sonetti,
che tali furono quasi tutti i componimenti, rappresentarono, più
che altro, delle esercitazioni accademiche. La raccolta portava
sul frontespizio due versi di un poeta locale, ricordato nella
nostra letteratura per una sua “onda di meridionale e canora
eloquenza”. Nicola Sole, che, nato nella vicina Senise nel 1821,
aveva studiato nello stesso Seminario di Tursi ed era morto da
pochi anni. «..... Non é misera valle la terra a lui ch’oltre la
tomba ha fede ». I sonetti furono composti in particolari
circostanze, scritti di getto nell’impeto improvviso di un
sentimento o di un’impressione, come quello « A Serafina
Bellusci per la morte del figlio sacerdote »: « Deh cessa, o
Madre, alfin in tanto duolo di trarre i giorni avvolti in nero
ammanto, non volermi turbare il bel consuolo che godo lieto in
Ciel tra il riso e il canto.» Troviamo tra le carte, scrive
sempre LAVIOLA, qualche sonetto che sembra indulgere ad una
certa trivialità di linguaggio, testimonianza di un ambiente
infuocato di invidie e di gelosie, che, nel piccolo centro
montano, si risolvevano, o meglio, degeneravano in una lotta
sorda e senza esclusione di colpi Riportiamo la prima strofa di
un suo sonetto.
«Tu un prete sei
della più bassa lega,
ch’ogni giorno Gesù meni al bargello:
tu della Chiesa hai fatto una bottega,
e di tua casa un lurido bordello! »
Camodeca non permetteva
che gli si pestassero i piedi ed aveva sempre pronto il suo
scudiscio, quando le calunnie assumevano la forma del
cannibalismo morale. Assente fu la poesia di argomento amoroso.
Il Camodeca, al quale, d’altra parte, come sacerdote di rito
greco, era concessa la facoltà di contrarre matrimonio, non
restò certamente insensibile al fascino delle donne della sua
terra, ma nessuna traccia é rimasta tra i suoi scritti.Tra le
memorie di Donna Giuseppina, sua diretta nipote, aleggia il
ricordo che tante lotte che zio monsignore dovette sostenere
erano rivolte alle calunnie che venivano a lui rivolte perché
era molto sensibile all’avvenenza femminile. Il suo aspetto
mastodontico, i lineamenti fini, la barba lunga procuravano
tanti desideri a molte donne del tempo. Crediamo opportuno, a
questo punto, menzionare un’altra attività, connessa con quella
poetica ed alla quale il Camodeca si dedicò con passione e con
lusinghieri risultati: quella del traduttore. Tra le leggende
albanesi la più suggestiva è, senz’altro, quella di Costantino e
Iurindina; portò a termine solo la traduzione non letterale
della leggenda ed egli stesso sul frontespizio scrisse « La
leggenda di Iurindina» in forma lirica parafrasata. |
 |
|
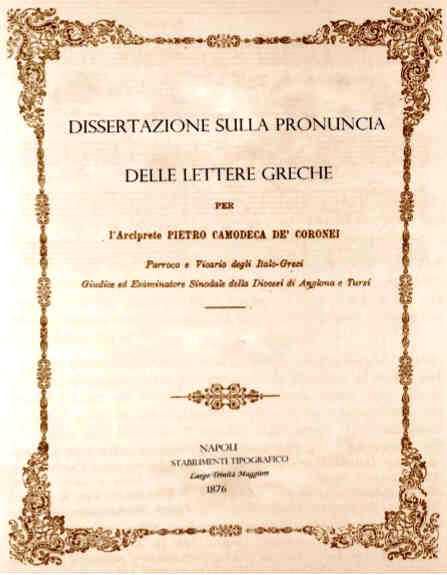 |
|
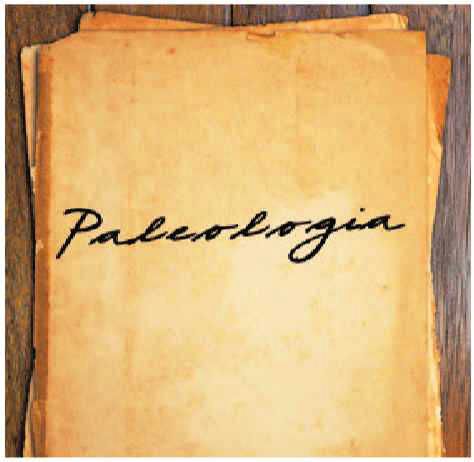 |
|
 |
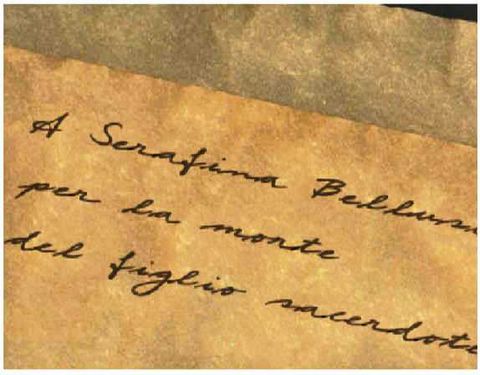 |
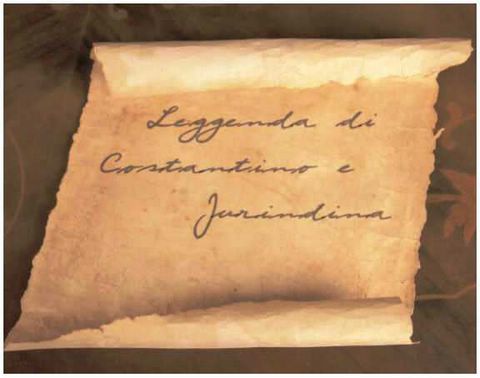 |
|
 |
D) PRIMI INCARICHI
RELIGIOSI E PROGETTO DELL’EPARCHIA
Dopo il suo insegnamento
in alcuni convitti e collegi sparsi nelle regioni limitrofe
(della Campania, della Basilicata e della Calabria) si aprì per
Camodeca un altro mondo, nel quale le polemiche non erano solo
cartacee ( come quelle con il canonico Caputi e i notabili di
Viggiano), ma assumevano toni di violenza e sconfinavano nella
diffamazione. Nei piccoli centri la lotta delle idee era un
pretesto, molte volte, per celare propositi di predominio
nell’ambiente locale. Nel 1879 Don Pietro, trentenne,
esuberante, in possesso di una salda cultura umanistica, ritorna
al suo paese Castroregio, dove nuove esperienze lo attendono,
quando viene nominato parroco di Santa Maria ad Nives . I reduci
dalle guerre ed i protagonisti dei vari moti erano pervasi da
spirito anticlericale e il loro atteggiamento nei confronti del
Pontefice, del Clero e della Chiesa era tenacemente ostile ed il
Papa era ritenuto nemico dell’Unità d’Italia. Nei piccoli centri
bersaglio era il prete e la lotta si accendeva e si acuiva in
rapporto alla sua statura morale. Alcuni sacerdoti soccombevano,
perché gli avversari avevano in mano il potere ed appartenevano,
quasi sempre, a famiglie ricche ed influenti. In molti di questi
sacerdoti si era creato un complesso di inferiorità e, qualche
volta, si alleavano con i potenti, tra i quali si erano inseriti
anche elementi dal passato non sempre chiaro. Il Camodeca, che
possedeva purità di intenti e di ideali, non poteva tollerare
certe situazioni e, levando alta la voce, sferzava i mercanti
della patria e i piccoli milites gloriosi della politica locale.
Don Pietro, per formazione spirituale, per carattere e per
censo, non si piegava e portava nella lotta coraggio e fierezza.
Anche contro di lui fu ingaggiata una lotta sorda e spietata,
sollevata contro la sua persona da uomini che, inizialmente,
forse in buona fede, si tramutarono, poi, in denigratori
violenti e senza scrupoli. Lotte siffatte assumevano forme più
bellicose proprio nei piccoli comuni, anzi erano in rapporto
inverso al numero degli abitanti. Bisognava averle vissute
alcune situazioni che si creavano nei centri con scarsa
popolazione e isolati dal resto del mondo, per potersi fare
un’idea di quanto deleterie fossero le passioni e con quanto
odio e livore si guardavano persone che abitavano a pochi passi
da sempre e che si incontravano tutti i giorni e tutte le ore,
perché una sola era la strada del paese. Egli non era un uomo
comune, non era il modesto prete del paese dagli umili natali;
aveva tutta una formazione, nella quale la componente umanistica
e teologica tenevano il primo posto. Accettò la lotta, non
avendo potuta evitarla, e sopportò le amarezze che essa gli
procurò; all’assalto rispose con armi pari, non ritenendosi
inferiore a nessuno dei suoi avversari e convinto che la sua
fosse la causa giusta. In qualche occasione trascese,
dimenticando la sua posizione di sacerdote, forse per difendere
quello che rappresentava il prestigio di una famiglia, che
riconosceva in lui il proprio capo. La sua nomina a parroco col
titolo di Arciprete della Chiesa di Santa Maria della Neve non
fu, certamente, accolta con piacere dai nemici della sua
famiglia. Questo prete ferrigno, ricco, dalle focosità e dalle
impennate drastiche della gente della sua razza, faceva ombra:
rappresentava un po’un ostacolo alle mire di molti. La nomina ad
arciprete certamente dette un grande impulso alle opere
parrocchiali e la giovane età del novello sacerdote riuscì a
restituire lustro alle funzioni del tempio e assistenza
spirituale ai fedeli. Le opere eseguite nel lungo periodo del
suo mandato per rendere più accogliente e più bella la Chiesa
furono tante. I rapporti degli italo-albanesi con il clero
latino avevano raggiunto limiti non più superabili e la
situazione di disagio in cui versavano le comunità albanesi di
rito greco non sfuggì al Camodeca, il quale era stato costretto
a farne quotidiana esperienza nell’assolvimento della sua
attività di sacerdote e di parroco. La politica di favore,
adottata in un primo momento nei riguardi dei profughi, aveva
subito, con l’andar del tempo, un cambiamento in senso inverso,
per diversi motivi: alcuni, di ordine pubblico, imputabili agli
stessi albanesi, altri, di ordine religioso, imputabili, invece,
alle autorità ecclesiastiche diocesane. Il progetto avanzato dal
Camodeca, cioè di farsi propugnatore di una diocesi autonoma
(eparchia), rappresentò un’esigenza sentita e reale. I rapporti
degli italo-albanesi, dunque, con il clero latino si
trascinavano, ormai da tempo, in un clima di diffidenza latente,
ma continua; era stata, in ogni tempo, da parte degli ordinari
diocesani un’azione di lenta erosione e di sottile distruzione
del rito: né erano mancate, a seconda dei casi e delle
circostanze, le lusinghe e le minacce. Molti nuclei albanesi non
avevano saputo opporsi e avevano dovuto abbandonare il rito
tradizionale per cambiarlo con quello latino, quello del proprio
vescovo. Esempi di questi cambiamenti vi furono anche nelle
decisioni di alcuni Sinodi. (Nel terzo Sinodo di Cassano,
apertosi il 17 novembre 1591; lo stesso divieto viene ribadito
dal Sinodo del 1623 e nel Sinodo dell’aprile del 1651.) Nessuna
meraviglia, dunque, se alcuni scrittori parlano di un popolo
albanese ribelle che non riusciva ad amalgamarsi con la
popolazione indigena. La pressione fu tenace, continua e
costante e voci di protesta si levarono e giunsero fino a Roma,
tanto che il Pontefice Paolo III si rivolse ai quattro vescovi
latini di Cosenza, Bisignano, Rossano e Anglona e Tursi, facendo
loro presente che avrebbe provveduto a sanzioni severe se
avessero continuato a dare molestia al clero albanese per la
pratica delle loro speciali liturgie. Tale esigenza era
maggiormente avvertita proprio nella seconda metà dell’ottocento
e già sappiamo che lo stesso Camodeca aveva dovuto chiedere alla
Sacra Congregazione il permesso di ricevere la ordinazione
sacerdotale da un vescovo latino, Mons. Acciardi. Il disegno
della creazione di una diocesi autonoma occupava la mente di
Pietro Camodeca ed a lui andava il merito di averlo espresso e
reso di pubblico dominio. Purtroppo i tempi non erano maturi ed
egli chiuse gli occhi alla vigilia della realizzazione del
progetto per il quale tante battaglie aveva combattuto. I
vescovi ed i parroci latini, calpestando le Bolle papali, li
tormentavano incessantemente per la loro religione greca.
« La Bolla di Leone
X del 18 maggio 1521 così si esprimeva: « Tamen Ordinarii
locorum latini, ubi in praesenti Graeci morantur, quotidie
molestant, perturbant, et inquietant ». « Questo dualismo di
greci e latini fu mal tollerato dai vescovi diocesani, i quali,
approfittando dei tempi e delle circostanze, commisero non lievi
usurpazioni ai nostri privilegi, alle nostre usanze ed ai nostri
riti, fino a latinizzare la maggior parte dei nostri paesi ».
Tutto preso da questo
grandioso disegno, Camodeca si rivolse, nel novembre del 1886, a
tutti i confratelli di rito greco e li incitò a collaborare e
sentire tutta l’importanza e la portata dell’avvenimento. Nel
gennaio dell’anno successivo inviò una lettera circolare ai
vescovi di Anglona e Tursi, di Cassano Ionio, di Rossano e delle
diocesi riunite di San Marco e Bisignano. Le sue idee erano
chiare: egli andava diritto allo scopo e sapeva che la meta
doveva essere raggiunta; la sede del nuovo vescovo sarebbe stata
Spezzano, che era stata costretta ad abbandonare il rito greco
fin dal 1568 e che avrebbe potuto riprenderlo con il seducente
ed ambizioso miraggio di essere scelta come capoluogo della
nascente diocesi. Quale atteggiamento assunsero i vescovi
interpellati? Il problema delicatissimo investiva interessi di
vario genere e di varia natura. Era umano che nessuno volesse
volontariamente favorire smembramenti e riduzioni nella propria
giurisdizione e per uno spirito di conservazione ogni cedimento
sarebbe stato ritenuto quasi un sintomo di debolezza. La parola
chiarificatrice sarebbe dovuta venire anche dall’alto, da Roma,
ma i vescovi interpellati non furono entusiasti della proposta
del Camodeca. Il solo vescovo di Anglona e Tursi, mons. Rocco
Leonasi, nella cui giurisdizione cadeva Castroregio e quindi il
Camodeca (e ciò dimostra la stima in cui egli era tenuto),
rispose con una lettera nella quale esplicitamente si diceva
subordinato alle disposizioni della Santa Madre Chiesa. Mons.
Antonio Pistocchi, vescovo di Cassano e nativo di Cerchiara,
inviò in risposta una lettera garbata nella quale, tuttavia, non
ravvisava un’esplicita accettazione della proposta. Gli altri
vescovi non tolleravano la diminuzioni delle loro parrocchie.
L’eco di tale progetto fu vasta ed è doveroso riportare da un
raro volumetto, edito a Bologna il 1887, una pagina, che è
dedicata al nostro Don Pietro e, nello stesso tempo, è una
conferma dell’interesse che egli aveva saputo polarizzare
attorno al suo disegno ed alla sua persona. In occasione del
Giubileo sacerdotale del Sommo Pontefice Leone XIII, Pietro
Camodeca ebbe l’onore di umiliare a Sua Santità un indirizzo,
unitamente a parecchie migliaia di firme di italo-albanesi, per
felicitarsi con lui del lieto avvenimento e per reclamare la
autonomia ecclesiastica con la creazione di una diocesi con a
capo un vescovo indigeno di rito greco. Si tenne in Chiaromonte,
nel 1888, in provincia di Potenza, una memorabile accademia in
onore di Leone XIII, alla quale con il vescovo ed il clero
parteciparono i notabili della diocesi di Anglona e Tursi. Il
Camodeca vi rappresentò tutti gli italo-albanesi ed in quella
occasione prese la parola e fu il suo dire un vero trionfo. « E’
necessario, scrive l’autore del volumetto, il canonico Daniele
Virgallita di Terranova di Pollino, dire qualche cosa di questo
parroco; giacché col suo discorso seppe infondere tanto affetto
nel pubblico per la sede di Pietro, e per le condizioni del
clero albanese sulle spiagge dell’Ionio, che nessuno potrà
dimenticare per tutta la vita! Il parroco ha nome Pietro
Camodeca dei Coronei ed è sulla quarantina. Studiò nel Collegio
di San Demetrio, ma compì gli studi ecclesiastici nel Seminario
di Tursi, e dal vescovo di Anglona e Tursi si ebbe con dispensa
pontificia l’ordinazione, mancando allora il vescovo pel rito
italo-greco. Educato tra i latini, mantenne con essi affettuose
relazioni, e ne fu contraccambiato egualmente; di qui a che
nella solenne circostanza dell’accademia non volle, o meglio non
poté fare a meno, per l’affetto onde è legato ai latini di
trovarsi in mezzo a loro e prendere parte alla gioia. Alto, di
bello aspetto, occhio vivace, lunga la barba, scendevagli al
petto …… eloquente, inneggiò a Leone XIII nell’idioma greco,
leggendone anche la traduzione in lingua italiana e poscia si fè
a leggere un discorso sublime per la semplicità e nobiltà del
concetto.»
Il discorso del simpatico oratore fu applaudito poiché egli con
la sua parola facile ed eloquente conquistò l’animo degli
ascoltanti, muovendoli tutti in favore della sua causa,
patrocinata con amore e zelo indicibile . La stampa, e non solo
quella cattolica, non poté ignorare una proposta di così grande
portata e si espresse, infatti, favorevolmente al progetto del
Camodeca, il quale raccolse e pubblicò, nel volumetto ricordato
prima, gli scritti che riguardavano tale sua iniziativa.
Scrissero parole di assenso “La Libertà cattolica “ di Napoli
del 3 agosto 1887, la «Voce della Verità » dello stesso giorno e
il « Fiamuri » del De Rada.
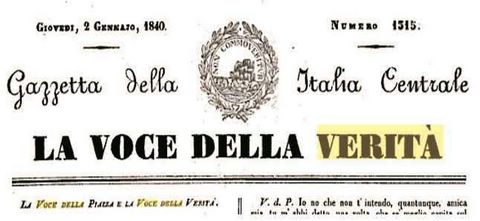
Noi non sappiamo se nel
1919, quando il Papa Benedetto XV istituì la Diocesi autonoma di
Lungro, qualcuno abbia ricordato colui che quarant’anni prima
aveva posto il problema e che solo da pochi mesi, stanco ma non
domo, per le mille lotte sostenute, riposava nel piccolo
cimitero della natia Castroregio.
|
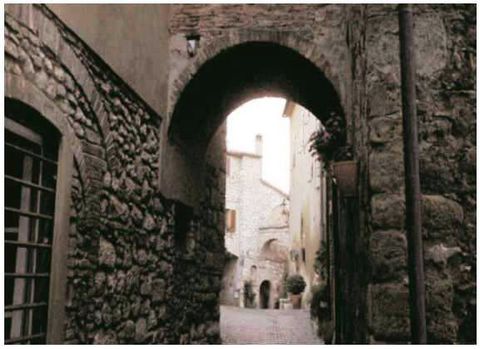 |
|

Campanile di Castroregio |
|
 |
|
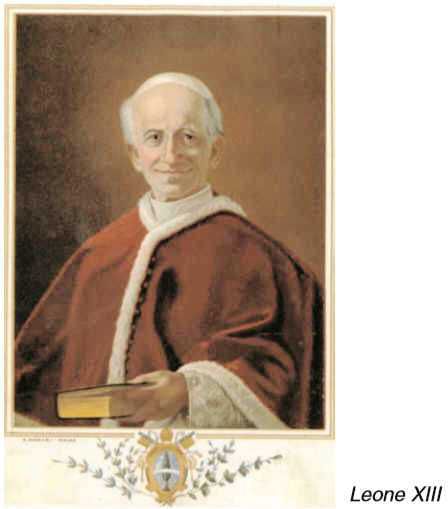 |
|
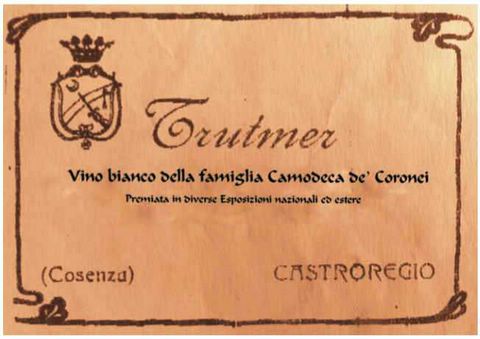 |
E) INTERESSI
CULTURALI E RAPPORTI CON IL MONDO ITALO-ALBANESE
Camodeca svolse in campi
diversi numerose attività: passò senza difficoltà dalla
dissertazione sulla pronunzia delle parole greche, alla
realizzazione di un vino, per il quale aveva coniato un nome
significativo e pubblicitario insieme “ Trut mer”:
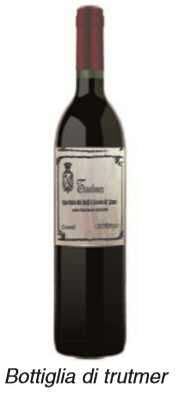 “
Che piglia il cervello! “ , «Che dà alla testa ». Ma di queste e
altre sue occupazioni di natura pratica egli nel suo paese, ed
in quelli limitrofi, fu un precursore ed un pioniere. Certo non
gli mancarono i mezzi per la attuazione delle sue iniziative.
Meraviglia non poco questa poliedricità in un uomo che viveva in
un borgo, rappresentato da poche case sferzate da tutti venti e
ammantate di bianco fin dalla prima neve; eppure egli mantenne
stretti rapporti con tanti studiosi del suo tempo e veniva
raggiunto fin lassù da tante pubblicazioni e riviste, da tanti
periodici e giornali! Egli fu l’uomo dotto della vasta zona,
allora depressa, compresa tra le propaggini del Pollino e le
coste ioniche. Non poté, perciò, non subire le sollecitazioni
degli studi di storia e di archeologia; infatti, venne preso dal
fascino di questa scienza perché, era risaputo, le nostre
contrade erano e sono la testimonianza più viva di un passato
che affondava le sue radici nel mondo greco. Poté avvicinarsi a
questo mondo, in quanto la conoscenza profonda della lingua
greca lo poneva nella felice condizione di poter consultare
direttamente le fonti storiche. Per motivi inerenti al suo
ministero sacerdotale e per suoi affari personali, egli si
recava spesso in Amendolara, un paese che distava pochi
chilometri da Castroregio e che conservava una tradizione di
studi su ricerche archeologiche mai interrotte. Camodeca vi era
spesso chiamato per predicare ai fedeli, specie nella ricorrenza
della festa del Patrono, perché era un bravo oratore, sapeva
porgere gli argomenti con un certo stile, ma nello stesso tempo
anche addentrarsi nel mondo delle lettere e delle arti. Il
Laviola nel suo volume riporta note e appunti di Camodeca
scritti su giornali riviste e pezzi di carta sparsi. Vi sono
note su Amendolara e sulla Cappella dell’Annunziata, presentate,
per lo più, sotto forma di interrogativi, ai quali l’autore
avrebbe dovuto dare delle risposte. “
Che piglia il cervello! “ , «Che dà alla testa ». Ma di queste e
altre sue occupazioni di natura pratica egli nel suo paese, ed
in quelli limitrofi, fu un precursore ed un pioniere. Certo non
gli mancarono i mezzi per la attuazione delle sue iniziative.
Meraviglia non poco questa poliedricità in un uomo che viveva in
un borgo, rappresentato da poche case sferzate da tutti venti e
ammantate di bianco fin dalla prima neve; eppure egli mantenne
stretti rapporti con tanti studiosi del suo tempo e veniva
raggiunto fin lassù da tante pubblicazioni e riviste, da tanti
periodici e giornali! Egli fu l’uomo dotto della vasta zona,
allora depressa, compresa tra le propaggini del Pollino e le
coste ioniche. Non poté, perciò, non subire le sollecitazioni
degli studi di storia e di archeologia; infatti, venne preso dal
fascino di questa scienza perché, era risaputo, le nostre
contrade erano e sono la testimonianza più viva di un passato
che affondava le sue radici nel mondo greco. Poté avvicinarsi a
questo mondo, in quanto la conoscenza profonda della lingua
greca lo poneva nella felice condizione di poter consultare
direttamente le fonti storiche. Per motivi inerenti al suo
ministero sacerdotale e per suoi affari personali, egli si
recava spesso in Amendolara, un paese che distava pochi
chilometri da Castroregio e che conservava una tradizione di
studi su ricerche archeologiche mai interrotte. Camodeca vi era
spesso chiamato per predicare ai fedeli, specie nella ricorrenza
della festa del Patrono, perché era un bravo oratore, sapeva
porgere gli argomenti con un certo stile, ma nello stesso tempo
anche addentrarsi nel mondo delle lettere e delle arti. Il
Laviola nel suo volume riporta note e appunti di Camodeca
scritti su giornali riviste e pezzi di carta sparsi. Vi sono
note su Amendolara e sulla Cappella dell’Annunziata, presentate,
per lo più, sotto forma di interrogativi, ai quali l’autore
avrebbe dovuto dare delle risposte.
Scrive Laviola: “Non
deve meravigliare il fatto che, troppe volte, noi citiamo e
trascriviamo parole, frasi o intere pagine del Camodeca. Ciò noi
lo facciamo deliberatamente, perché é questo l’unico modo per
far conoscere scritti che sono inediti e resteranno tali,
trattandosi di appunti e non di opere complete. Questa
precisazione era necessaria, come pure l’assicurazione che tutto
il materiale, di cui ci siamo serviti nella composizione di
questo nostro modesto lavoro, é gelosamente conservato
nell’avita casa della natia Castroregio”
Egli scriveva « Essendo
questo luogo (cappella dell’Annunziata di Amendolara) (n.d.a) in
mezzo tra Siri, Eraclea Sibari e Turio cosa doveva essere? Non è
certamente una città, perché di ciò nulla nella storia, o, se
mai, quale era? Un porto? Un mercato pubblico? Un paese? Una
tenuta principesca? ….”.…….. “Rapporti archeologici in generale.
Ispezioni. Esortazione ai cittadini di Amendolara a custodire
scrupolosamente un siffatto tesoro di antichità “. Vi era, poi,
lo schizzo della cappella, disegnato dallo stesso Camodeca (non
mancava, infine, un elenco degli autori consultati.)» Tali
appunti risalivano alla fine del secolo scorso e, perciò,
meravigliavano, come pure meravigliano altri appunti che
riportavano i passi originali in latino e in greco di tutti gli
autori consultati. Le osservazioni sopra trascritte mettevano in
risalto la versatilità dell’ingegno del nostro Don Pietro ed il
suo metodo di ricerca.
L’autore poco più che ventenne, pur essendo ancora studente di
teologia, insegnava latino e greco, all’Istituto Petta di Oriolo
Calabro. Durante questo periodo presero vita numerose opere
manoscritte che sono rimaste tali e che sono andate
definitivamente perdute se non per qualche appunto riportato dal
Laviola.
Il breve studio non portato a termine “Dissertazione sul
Protestantesimo”, Oriolo 20 Aprile 1869, era, pertanto, opera
principalmente scolastica e rappresentava solo una esercitazione
accademica. Allo stesso genere si possono assegnare altri due
brevi saggi « L’Errore del Secolo » che, per il Camodeca, era il
razionalismo, e « Cupido e Psiche e l’Arte Critica », che,
scriveva Laviola, ” non abbiamo trovato” Anche un trattatello
sulle «Divinazioni presso gli italo-albanesi» rimase incompiuto:
eppure esso si presentava già ricco di interesse (perciò ne
dette un saggio, come scriveva sempre Laviola) ed avrebbe
portato un contributo non trascurabile a quel genere di studi ed
alla conoscenza del nostro popolo. « Tra gli albanesi vi sono
ancora molte superstizioni di tal genere con le quali la gente
crede divinare il futuro in diversi modi. Il canto notturno del
gufo è segno di lutto in quella famiglia sopra la cui casa il
gufo si è posato a cantare. Questa credenza era generalizzata
anche presso la gente latina.
IL canto della gallina,
non nel modo consueto, è segno di perturbamento dell’aria, di
terremoto, di morte in persona di uno della famiglia. — La si
ammazza subito. E’ segno di infortunio l’incontro di qualche
serpente che attraversa orizzontalmente la strada del viandante.
-Questo era anche presso i greci. E’ triste segno l’inciampo al
limitare della porta prima di partire di casa la mattina. -Era
questo anche presso i romani. » «Anche per mezzo di certe erbe
si pretende scoprire l’avvenire: sono diverse le combinazioni di
erbe a cui si attribuisce una forza misteriosa» . « Si masticano
le foglie di una certa erba, poi si spandono e si applicano al
braccio. Se la foglia porta sopore è segno che l’amante o la
persona per cui la si è messa vuole del bene alla persona che
l’ha applicata. Il forno non si deve lasciare mai vuoto. Si
cacciano le focacce, poi si lascia una e via le « carveglie» (i
pani), poi si toglie quell’una.» “Se uno vuole orinare la notte
davanti la casa, non può; o se è necessitato, deve sputare tre
volte” . «Cosi come si é sciolto il sale, si sciolga il tumore e
ritorni la salute », queste parole si pronunziano mentre il
pezzo di sale, che è servito per toccare il tumore, si liquefà
nell’acqua dove, dopo l’uso, è stato gettato. « Nel fascino si
dice: « Lontani gli occhi maligni: non sono né medico né
medichessa, ma è il nome del Signore del Cielo» «Le ossa di un
rospo pestate erano un potentissimo filtro per muovere una donna
ad amare un giovine. Tale era l’amore che la donna presa da
cieca libidine, seguiva l’uomo ovunque, senza che forza alcuna
la distogliesse. Questo filtro doveva dopo essere dedicato allo
spirito maligno con delle misteriose parole e poi posto nella
Chiesa e precisamente sotto o vicino o dirimpetto all’altare
maggiore» . « Altri bruciano le foglie del lauro e traggono
argomenti di amore dal crepitare delle foglie. Nel fare le
magie, o meglio dei giuochi magici di prestigio, si crede che
chi abbia una lacerta o un ramarro nascosto sotto le vesti veda
gli inganni ottici dell’altro. Bruciare il giogo usato o parte
di esso spezzato è un peccato».
Scriveva Laviola: « di
appunti come questi ve ne sono altri ed anche con riferimento ai
classici, segnati un po’dappertutto, il più delle volte su
foglietti volanti o sui margini dei giornali». Pietro Camodeca
era tra gli italo-albanesi molto in vista e non solo tra il
clero; egli era una personalità di primo piano tra coloro che
erano impegnati alla soluzione dei vari problemi inerenti le
comunità albanesi. Le sue visite a Roma erano frequenti e di non
breve durata; negli Uffici della Congregazione di Propaganda
Fide egli era di casa e la figura di questo sacerdote greco, dal
portamento maestoso e dalla lunga barba fluente, era notissima
in tutta la zona di Torre Argentina, dove era situata la sua
abituale pensione. Era un innamorato di Roma, dei suoi
monumenti, dei suoi archivi e delle sue biblioteche. Molte note
c’erano tra le sue carte e molti appunti, frutto di ricerche
negli archivi vaticani, riguardanti sempre l’Albania e gli
italo-albanesi. L’una e gli altri erano in cima ai suoi
pensieri. Nella grande città andava alla scoperta di tutto ciò
che aveva attinenza con la storia degli italo-albanesi, del
rito, delle bolle pontificie, che gli sarebbero servite per
preparare lo studio e chiedere la istituzione della diocesi
autonoma di rito greco. Allacciò in questo periodo le sue
amicizie non solo con uomini di chiesa, ma anche con uomini
politici. Non solo i confratelli guardavano lui come guida, ma
uomini di ben altra statura, assorti in studi severi, non
tralasciarono occasione per scrivergli, chiedere consigli,
sollecitare raccomandazioni presso le alte sfere di Propaganda
Fide e presso le genti della sua zona, su cui esercitava tanta
influenza e presso la quale godeva di tanto prestigio. Gerolamo
De Rada nell’agosto del 1895 da Trebisacce, dove si trovava per
i bagni, scriveva al Camodeca a Castroregio e gli manifestava il
desiderio di poterlo vedere per << convenire, per un paio di
giorni almeno, su cose diverse ma tutte care ad entrambi »Gli
comunicava inoltre la imminente comparsa del periodico “Fiàmuri
Arberit” . Una figura di prima grandezza nel movimento per la
causa della rinascita e l’indipendenza dell’Albania fu,
senz’altro, quella di Anselmo Lorecchio di Pallagorio(
Catanzaro), che gli propose la stampa di una rivista non
letteraria ma politica, che prendesse a cuore le sorti
dell’Albania. La rivista venne pubblicata e fu «La Nazione
Albanese », l’organo che rappresentò per parecchi lustri una
bandiera di fede e di patriottismo, in quanto pose
all’attenzione del popolo italiano e, in particolar modo, a
quella degli italo-albanesi il problema della indipendenza
dell’Albania dal giogo ottomano. Camodeca annunziava che era
riuscito ad ottenere un sussidio per la pubblicazione della
rivista e il Lorecchio al riguardo gli espose altri problemi,
altri disegni che aveva in mente- Il primo numero della Rivista
usci il 15 Marzo del 1887. A Pietro Camodeca si rivolgevano
parroci di piccole chiese e confratelli, a lui esponevano i
propri bisogni e quelli della propria chiesa e dei propri
fedeli: egli donava consigli, forniva arredi sacri,
sovvenzionava con denaro
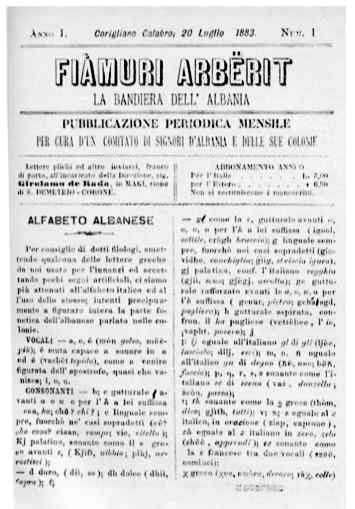
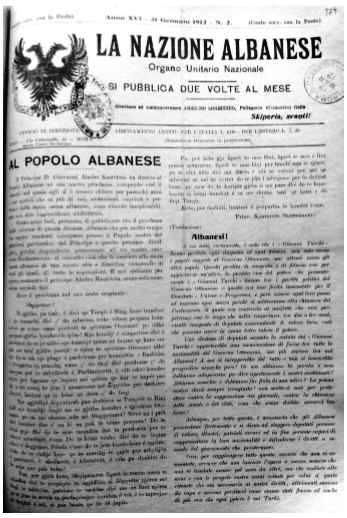
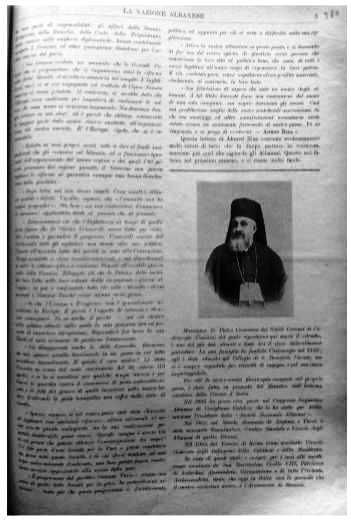
Erano parroci di comuni
depressi, come Plataci, dove il tempo si era fermato e gli
uomini a stento riuscivano a raggiungere un sia pur minimo
tenore di vita e vivevano con le bestie e come le bestie, finché
non esplodevano ed allora si avevano i tumulti e il sangue
scorreva per le strade. Il parroco rappresentava l’unica luce di
cultura, ma era quasi sempre povero e squallide erano le chiese.
Tra questi ricordiamo Demetrio Chidichimo, un buon patriota e un
buon cultore di lettere di Plataci: un sacerdote preparato, che
riportò tutti gli avvenimenti del suo tempo ed aveva tradotto e
dato alle stampe documenti antichi ( alcuni dei salmi di
Davide). In una lettera, che egli inviò al Camodeca, dava la
misura esatta di quello che il nostro Don Pietro rappresentava
per i sacerdoti albanesi. « L’altro ieri seppi che tu sei a
Roma, tu eterno cive dell’eterna città. Beato te che di tratto
in tratto esci dal lezzo e dalla povertà dei nostri tuguri e ti
spazi fra le bellezze seducenti e incantatrici di monumenti che
parlano il linguaggio della grandezza e non l’infinto della
miseria e dell’invidia! Se non avessi saputo che eri costà, io
stavo proprio per venire a sorprenderti in Castro-regio. Cosi ho
dovuto rinunziare al desiderio grande di poterti
abbracciare[…..]fammi per carità avere qualche poco di stoffa
per pianeta od altro, qualche elemosina di S.Messe……». I
sacerdoti italo-albanesi avvertivano la mancanza di un proprio
vescovo, che potesse sentire, comprendere i loro problemi, che
parlasse la stessa lingua e seguisse lo stesso rito. Lettere di
questo tenore si scrivevano solo a confratelli, che si erano
ritenuti al di sopra per virtù e per dottrina; non si apriva il
proprio animo al primo venuto, non si mettevano a nudo i propri
sentimenti. Gli attestati di stima, di cui Pietro Camedeca era
fatto segno da parte di tanti qualificati galantuomini, si
concretò in un significativo riconoscimento ottenuto nel primo
congresso linguistico albanese svoltosi nei giorni 1-2 e 3
ottobre 1895 a Corigliano Calabro. Si riunirono, in quella
circostanza, gli uomini più rappresentativi delle nostre
colonie. Al congresso dette la sua adesione, tra gli altri,
Francesco Crispi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale si dichiarò> albanese di sangue e di cuore » .
Pietro Camodeca vi partecipò tra i primi e la sua presenza si
rivelò in alcuni momenti determinante: egli prese la parola sui
vari argomenti posti all’ordine del giorno e fu nominato
componente della commissione incaricata della compilazione di un
dizionario. Nella seduta pomeridiana del giorno 2 si posero le
basi e si creò la Società Nazionale Albanese, che aveva lo scopo
di affratellare le varie colonie albanesi per l’incremento degli
studi linguistici delle sacre memorie patrie. I congressisti
ebbero la possibilità di riconoscere ed apprezzare le qualità
del Camodeca, la sua lucidità nella impostazione dei problemi ed
il suo dinamismo, e non fu, quindi, una sorpresa, quando,
esaurito lo scrutinio, proprio egli risultò eletto nella carica
di Presidente effettivo della Società Nazionale Albanese, mentre
al De Rada andò la Presidenza onoraria. Un trionfo meritato ed
un giusto riconoscimento, perché egli alla causa aveva dato
sempre tutto se stesso. Nel secondo congresso linguistico
albanese, svoltosi a Lungro, nei giorni 20 e 21 febbraio 1897,
Gerolamo De Rada comunicò all’assemblea che l’arciprete Pietro
Camodeca de’Coronej, per motivi familiari era stato costretto a
dare le dimissioni. Dimessosi il Camodeca, gli successe nella
carica di Presidente il Cav. Uff. Anselmo Lorecchio. |
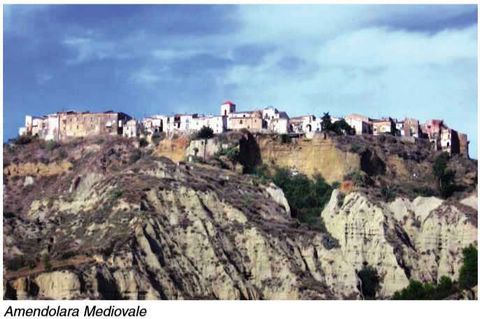 |
|
 |
|
 |
|
Oriolo Calabro |
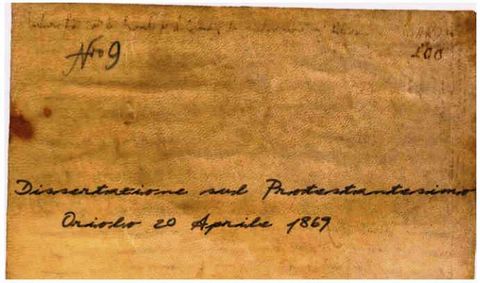 |
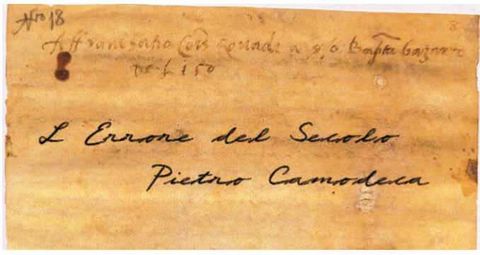 |
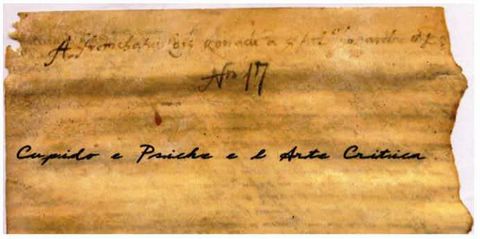 |
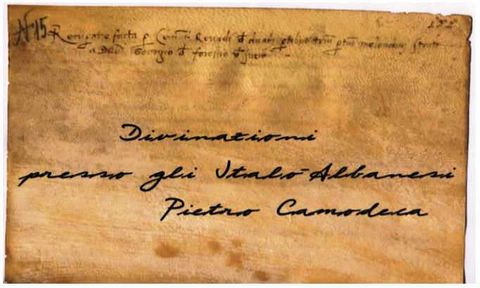 |
 |
 |
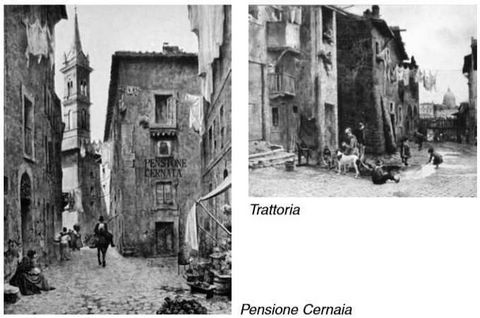 |
 |
|
 |
|
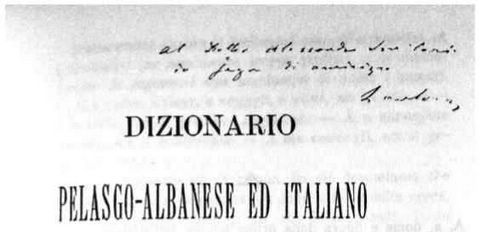
Compilato da Pietro Camodeca De' Coronesi
|
F) PRODUZIONE
LETTERARIA, DIFESA DELLA CHIESA E DELLE TRADIZIONI.
Camodeca nella sua
produzione letteraria produsse numerosi manoscritti e pochi
volumi a stampa. Egli era l’autore di un dizionario albanese,
dato alle stampe solo in parte; Pietro Camodeca de’Coronei
(Dizionario pelasgo-abanese italiano.- Roma - Tip. Befani, 1900)
. Furono pubblicate solo le lettere A e B e fu il pomo della
discordia di tutta quella generazione di intellettuali,
galantuomini entusiasti, ma testardi, alle volte, e fieri della
propria opinione. Riteneva di avere idee chiare in proposito
sull’argomento e sosteneva che la lingua vera era quella che si
parlava, mentre De Rada tentava di crearne una letteraria; essa
andava scritta come si pronunziava ed andava usata sempre, anche
nelle manifestazioni e nelle celebrazioni pubbliche.
Interminabili discussioni sorsero tra linguisti e glottologi,
circa la pubblicazione del vocabolario ed al Camodeca, autore
del dizionario, un amico inviò la sua brava lettera aperta che
riportiamo.
« L’idea di
compilarlo definitivamente questo benedetto vocabolario è
vecchia, e tu lo sai, come lo spirito contradditorio che anima
la nostra razza. Prima del De Rada, quanti altri non hanno
sognato di vedere il loro nome appiccicato sul frontone di un
grosso volume che doveva chiamarsi vocabolario albanese. Ed
ancora si sogna, ed io temo che anche tu, amico mio carissimo,
resterai qualificato come un sognatore impenitente».
Il Camodeca, però, come
era suo costume, si dedicò con entusiasmo alla compilazione del
vocabolario albanese: un lavoro indubbiamente di grande impegno,
uno dei primi del genere in ordine di tempo. Se poi si tiene
conto delle polemiche, di cui abbiamo fatto cenno, maggiore fu
la fatica, ma il nostro autore si buttò a capofitto e le
ricerche lo assorbirono per anni. Tutti questi studi sulla
lingua andarono perduti? Prima di dare una risposta a questi
interrogativi, bisogna precisare che tutte le carte e i
manoscritti in originale di Pietro Camodeca, riguardanti il
dizionario o comunque la lingua, si trovavano presso l’Istituto
Linguistico dell’Università di Copenaghen, in Danimarca. Il
Prof. Gangale, il glottologo che si era interessato dei
manoscritti del Camodeca, riuscì a portarli in Danimarca,
operazione che, in precedenza, aveva fatto anche per quelli di
Giuseppe Serembe. Essi furono ceduti perché formassero oggetto
di studio da parte dei filologi di quell’Istituto, ma ciò non
avvenne; auspichiamo che ciò possa, un giorno, avvenire.
Attualmente i manoscritti (vocabolario e modi di dire) vengono
studiati ed interpretati dal Prof. Francesco Altimari,
dell’Università di Calabria e dalla sua scuola, che li darà alle
stampe quanto prima. Durante un lungo periodo della sua vita
dinamica il Camodeca coltivò due idee linguistiche, i cui
limiti, a sua insaputa, si confusero: una raccolta di materiale
lessicologico e un’altra di proverbi. Né l’una né l’altra furono
portate a termine: del dizionario, come abbiamo scritto,
comparvero solo le prime due lettere. E’difficile stabilire a
quale delle due idee egli abbia prima pensato: forse, opina il
Gangale, fu il dizionario e solamente tentando di dare degli
esempi a fianco di ciascuna parola egli si accorse della natura
del proverbio. In seguito fu talmente preso dal lavoro che
cominciò a scrivere lunghi elenchi di proverbi, senza rendersi
conto dei casi in cui li aveva composti egli stesso (l’epoca
della raccolta coincise col periodo che va dal 1870 alla fine
del secolo). Sebbene avesse ricevuto una cultura umanistica e
discendesse da una famiglia di feudatari (la parola è usata da
numerosi scrittori), il Camodeca si avvicinò alla lingua ed allo
spirito dei contadini, senza le inibizioni non linguistiche che
tormentarono il moralista De Rada. Il fondamento della lingua
registrata era sicuramente il linguaggio del popolino e dei
domestici, che egli sentì durante la sua infanzia: risulta,
infatti, da qualche nota che verso il 1865 una donna nonagenaria
frequentava la sua casa e proprio da essa egli ascoltò vecchie
canzoni popolari. Le case dei ricchi dei nostri paesi, come si
sa, erano il luogo dove si incontravano vecchie donne senza
protezione, le quali, in cambio del cibo, rendevano dei piccoli
servizi. D’altronde la lingua di Castroregio, quella di Plataci
e di Farneta, costituirono un gruppo conservatore delle parlate
albanesi per l’isolamento secolare delle tre località, meno
esposte agli influssi della lingua italiana. I giornali
dell’epoca riportano che a Castroregio, per la morte del re
Umberto I, il Sindaco Crispino Camodeca fece celebrare un
servizio funebre ed organizzò una pubblica manifestazione,
durante la quale i discorsi vennero pronunziati nella madre
lingua albanese. Questo stava a dimostrare che il fuoco di Don
Pietro aveva acceso l’ambiente e Castroregio viveva in pieno,
nel rito, nei costumi e nella lingua, la sua vita di centro
albanese. Pietro Camodeca era un innamorato di tutto ciò che era
legato al suo popolo: tradizioni, usi, lingua, rito; desiderava
che il patrimonio non si sperdesse nel tempo e si adoperò con
ogni mezzo, perché fosse conosciuto al di là della stretta
cerchia diocesana e regionale. I suoi scritti trovarono
ospitalità su riviste a diffusione internazionale. Un saggio
dello stile di Don Pietro fece rivivere uno spettacolo (1900),
cioè la descrizione dell’arrivo e delle accoglienze che il
popolo di San Paolo Albanese riservò al vescovo di Anglona e
Tursi, Mons. Pujia, in visita pastorale. «Come comparve il
Vescovo, ad un certo punto, vicino e prospiciente all’abitato,
una salva di moschetteria partita dagli uomini che erano andati
ad incontrarlo, diede il segnale al paese, donde si rispose
immediatamente con lo sparo di mortaretti e col suono delle
campane. Vidi allora sbucare da altra via una bandiera, portata
da un uomo fiancheggiato da un altro armato di moschetto, e
questi due dall’aspetto marziale erano seguiti da due file di
donne vestite a festa, con abiti rossi ingallonati, che
tenendosi per mano l’una all’altra unite venivano ballando e
cantando nella lingua patria. Canzoni di lode al leggendario
nostro eroe Giorgio Castriota Skanderbeg, l’atleta di Gesù
Cristo! Mons. Pujia, contento di queste spontanee, entusiastiche
e non mai viste dimostrazioni di affetto e di fede viva, si
compiacque rivolgere a quei buoni fedeli una parola di
ringraziamento, ed evocando nella sua mente i ricordi della loro
nobile storia, li esortò a perseverare nell’amore di Gesù
Cristo, perché l’esodo doloroso degli avi loro dalla
madre-patria a queste rive incantate d’Italia, l’addio al
domestico focolare ed alle aure dolci dei patrii monti avvenne
appunto per la fierezza del loro carattere e per la nobiltà del
loro sentire!» . Finita la visita, cantando altre canzoni
tradizionali, il corteo accompagnò il vescovo fino all’uscita
del paese, ove, cessando definitivamente i festeggiamenti,
ciascuno andò a baciargli la mano, augurandogli il buon viaggio.
La mente viva e sveglia di Camodeca escogitò anche un progetto
che avrebbe dovuto interessare tutto l’orbe cattolico. Sul
soglio di Pietro vi era il vecchio Leone XIII (1898), il Papa al
quale il Camodeca aveva già proposto l’istituzione della diocesi
autonoma per gli italo-albanesi. Dal piccolo borgo di
Castroregio si levò una voce per proporre un gesto di tangibile
solidarietà verso il romano pontefice. Il suo progetto era
grandioso e non si esauriva nei limitati confini della propria
diocesi e della propria nazione, ma si allargava, abbracciando
tutto il mondo cattolico. Leggiamo dagli stessi suoi scritti. «
Nelle critiche ed anormali condizioni economiche in cui oggi
versa la Santa Sede, il rinvenire dei mezzi che possono
agevolare in qualche modo l’esplicazione della sua grande, alta
e nobile missione civilizzatrice del mondo, ci sembra cosa
estremamente utile ed accettevole, massima quando questi mezzi
provengono spontaneamente sotto la forma collettiva della
cooperazione e della associazione. Non è chi non conosca quali
vantaggi e quali consolazioni abbia avuto in questi ultimi tempi
il cuore afflitto del Sommo Pontefice dalla carità promossa e
riscossa spontaneamente sotto il titolo dell’obolo di S. Pietro,
con cui il Santo Padre seppe lenire le sventure che colpirono le
città ed i popoli; e sussidiare le missioni estere, che tanto
bene apportano alla civiltà ed all’umanità! Ed ora che gli alti
concetti della papale Enciclica Orientalium Dignitas hanno
riempito il mondo di non vane speranze, per superare le
difficoltà che naturalmente le possono intralciare il cammino,
viviamo certi che non potrà mai dirsi inutile e superfluo ogni
sussidio che muova in aiuto di questa opera, esplicandosi nella
forma di un obolo novello. E’cosi che facciamo voti che
all’obolo di San Pietro, seguisse l’obolo di San Paolo, inteso
nel concorso economico dei parroci di tutto l’orbe cattolico». «
Ciascuno di noi, ed in ogni lembo di suolo irradiato dal sole
della cristianità, sentirà l’animo commosso piegarsi alla voce
riverente del proprio vescovo diocesano che lo chiami al tenue
contributo pel trionfo della grande e nobile causa - l’unione
delle chiese - e verserà in ciascun anno la piccola somma di
lire dieci, poiché, se e vero che per la chiesa noi godiamo il
beneficio parrocchiale, è d’altro canto ben giusto che del
beneficio medesimo, una cosi minima parte, che nulla sottrae al
necessario per vivere, sia invertito in pro del Sommo Pontefice,
Capo Supremo della Chiesa. In tale guisa anche col nostro
speciale concorso l’idea grandiosa per l’unione delle chiese
avrà un impulso ed un vantaggio, e potremo un giorno esultare
vedendo radunato tutto il gregge sotto un sol pastore, et fiat
unus Pastor et unum ovile!»…. ….« L’Obolo di San Paolo, ove avrà
la fortuna della sovrana approvazione, dovrebbe essere raccolto
esclusivamente dai vescovi, ciascuno nella propria diocesi, ed
inviato a Roma nel dicembre di ciascun anno per essere poi, da
chi venisse proposto, offerto al Santo Padre nel giorno
dell’Epifania, siccome i doni dei Re Magi al Bambino Gesù»! Non
vi fu chi non si rese conto, leggendo quanto sopra, della
chiarezza e della concretezza delle idee di Pietro Camodeca,
della sua naturale capacità ad impostare problemi di largo
interesse e di vasta risonanza. Accanto agli studi linguistici
ed alle proposte di aiutare il Santo Padre con delle opere di
beneficenza Pietro Camodeca concepì anche la creazione di una
diocesi autonoma per gli Albanesi di Calabria e di Basilicata,
di cui abbiamo già parlato. Il Collegio di S. Adriano di San
Demetrio Corone dopo il 1860 aveva subito un profondo mutamento
con la progressiva eliminazione dell’amministrazione
ecclesiastica; il vescovo perdette man mano la sua autorità e
nella scuola entrò la mentalità dei tempi nuovi.
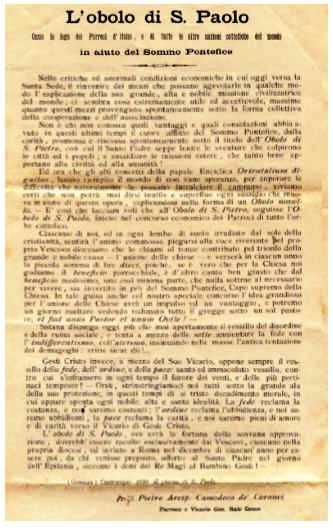
Pietro Camodeca concepì,
allora, la creazione di una diocesi autonoma per gli Albanesi di
Calabria e Basilicata, con una propria giurisdizione, non
accettando la nuova situazione e il cambiamento di indirizzo di
studi del collegio, che non educava più, secondo le prescrizioni
del fondatore e dei sommi pontefici, i giovani destinati al
sacerdozio. Con la collaborazione dell’amico Gugliemo Tocci, che
era stato deputato, si adoperò affinché, il collegio italo-greco
venisse inserito nel movimento per la unione delle Chiese,
creato dall’Enciclica “Orientalis Magistralis” di Leone XIII
«eretto al fine di servire gli interessi spirituali dei greci
d’Italia e di quelli della madre patria»,. Nello stesso tempo si
adoperò perché «fosse ripristinato ed ampliato l’antico collegio
Internazionale italo-greco di San Basilio di Roma, eretto a
beneficio degli italo-greci e dei greci esteri, in cui gli
alunni sacerdoti (usciti da Sant’Adriano e quelli provenienti di
Sicilia e di Grecia e dall’impero ottomano) potessero venire a
perfezionarsi nelle superiori discipline teologiche e
filosofiche » . L’azione, s’intende, sarebbe dovuta essere
concordata anche con la Santa Sede, ma i tempi non erano
favorevoli e perciò nulla si poté fare per arrestare la
laicizzazione del Collegio. La trasformazione del Collegio
rappresentò l’inizio di un periodo di decadenza, non solo per il
clero albanese, ma per tutta la vita delle colonie. Per Camodeca
il Collegio era un centro di coesione che così si sarebbe
sfaldato, e, d’altronde, anche il progetto della egemonia
ecclesiastica per il mantenimento del rito e conseguentemente
della lingua era stato accantonato. Camodeca volse, poi, con
tanta passione l’opera sua anche al campo pastorale: egli si
dedicò dalla cura delle anime, venne assorbito dai compiti del
suo ministero ed anche qui portò il suo entusiasmo e il suo
dinamismo insieme con la formazione e l’ardore della sua carità.
Dal verbale di una visita pastorale, effettuata da Mons. Pujia,
si ricavano notizie che si riferiscono alle opere compiute dal
Camodeca, quasi sempre a sue spese. Venne eseguita la chiusura
delle tombe nella chiesa, venne riattato il pavimento, costruita
la balaustra che divide l’iconostasio dal centro della chiesa,
rifatti i due quadri della SS.— Annunziata e di San Nicola di
Bari. La chiesa, costruita nel 1551 e terminata e consacrata
dopo 50 anni, fin dal 1888 era senza porte, senza finestre,
senza tetto. Dalla solerzia e dallo zelo del Camodeca fu
trasformata in una modesta casa del Signore, ornata di marmi e
di pitture, riattata, in una parola, ab imis fundamentis.
Riportiamo dal verbale citato (archivio Camodeca) «La chiesa non
è sufficiente a contenere l’intiera popolazione. E’isolata da
tre parti e dalla 4‘ attacca con un vaglio scoverto della nobile
famiglia Camodeca de’Coronej, che furono i fondatori del paese.
Non esistono i quadri della Via Crucis, e non si pratica questo
devoto esercizio. Esiste un solo banco per la famiglia Camodeca
de’Coronei, permesso da Mons. Leonasi contro la contribuzione di
L. 100 erogata a favore dei restauri. Vi si tollera l’uso di
qualche sedia». Anche il Battistero fu riattato dal Camodeca e
vennero, a sue spese, restaurate le tre statue, esistenti nella
chiesa, Sant’Antonio di Padova, il Rosario e la Madonna della
Neve. Ai due quadri, che ornavano la chiesa, vennero aggiunti
altri sei. Non gli mancò, ad opera compiuta, il riconoscimento
da parte delle autorità ecclesiastiche centrali: infatti, in
data 28 settembre 1894, il prefetto della Sacra Congregazione di
Propaganda Fide per gli affari di rito orientale gli scrive: «
ho appreso con mia soddisfazione le cure da V. S. impiegate per
condurre a termine i restauri di codesta chiesa parrocchiale » .

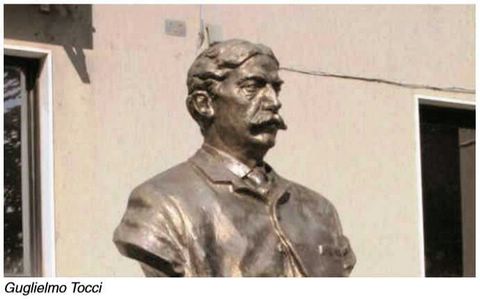
La Cappella di San Rocco,
costruita nel 1846-48, tutta lesionata, fu legata con catene di
ferro ed abbellita di tre altari di marmo e di un quadro di
Santa Lucia.
Camodeca fu un costruttore in tutti i campi ed anche un
coraggioso ed un intransigente, perché solo gli uomini forti
sono capaci di eliminare quegli abusi che nei nostri piccoli
centri si tramandano da sempre e sono quasi radicati nell’anima
del popolo. Anche l’ALBANIA, come nazione giovane, in questo
periodo, stava rigenerandosi ed il clero albanese d’Italia poté
aiutare queste modificazioni. La principessa Dora d’Istria-, in
una intervista rilasciata alla famosa Revue des deux mondes di
Parigi, aveva intuito, con molta chiarezza, il contributo che
gli italo-albanesi avrebbero potuto dare alla causa della
rigenerazione dell’Albania. Aveva, infatti, dichiarato: « Il
clero albanese d’Italia, di cui la tolleranza ed il patriottismo
si sono in più d’una occasione manifestati in modo tanto
segnalato, non perverrà egli d’altronde, specialmente ora che i
rapporti fra le due rive dell’Adriatico si fanno più frequenti,
ad esercitare un’azione salutare nel senso della conciliazione?
In generale gli Albanesi dell’Italia meridionale, che hanno
serbato in modo così fedele e pietoso il culto degli avi e le
tradizioni nazionali, possono rendere considerevoli servizi ai
loro fratelli d’Oriente».

Ismail Kemal, del quale in
casa Camodeca si conservava una fotografia con dedica autografa,
alla presenza dei delegati di tutte le regioni della Albania, il
28 novembre 1912, innalzava a Valona la bandiera della patria
libera e indipendente. Si coronava, in parte, con successo
un’azione intrapresa da vari lustri, che aveva interessato tutti
i nostri uomini migliori. Una prova della partecipazione di Don
Pietro, viva ed attiva a questa realizzazione, poté essere
considerato un suo progetto per la trasformazione della casa di
Scanderbeg, religiosamente da lui visitata, per la prima volta,
nel 1887 a Roma. Tra le sue carte esistevano degli appunti che
noi riassumiamo. «Acquistare la casa di Scanderbeg in Roma per
farne un centro ed una rappresentanza degli albanesi: addobbarla
e creare un museo nel quale dovrebbero trovare posto un busto di
marmo dell’eroe e, oltre il suo ritratto, vi dovrebbero anche
figurare le armi del grande condottiero». Nel telegramma di
congratulazioni al Presidente del Governo provvisorio
dell’Albania, Camodeca ricorda di essere stato il primo
Presidente della Società Nazionale Albanese; tale Società era
stata fondata nel 1895, in occasione del primo Congresso
albanese di Corigliano Calabro e le sue sezioni erano sorte in
tutti i comuni italo-albanesi. Organo della società fu il
periodico “La Nazione Albanese”, fondato e diretto da Anselmo
Lorecchio. Il Camodeca aiutò tale pubblicazione, la sovvenzionò
e le fece avere dei contributi.
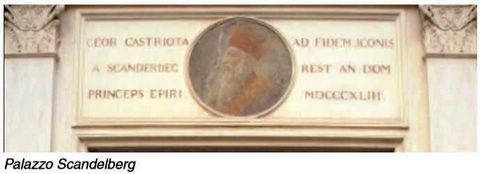
Altro giornale battagliero
fu « La Nuova Albania » diretto da Gennaro Lusi, di Greci (
Avellino). Lo spirito battagliero, nonostante l’età e le
delusioni, non era venuto meno e quel suo volersi sentire il
rappresentante ufficiale di tutti gli italoalbanesi di Calabria
e di Basilicata era ancora presente nel suo animo.
 |
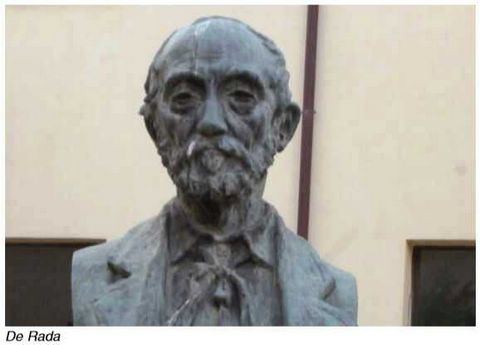 |
|
 |
|
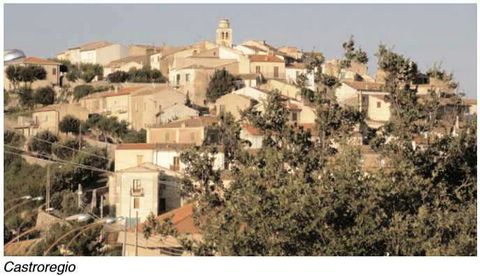 |
 |
 |
 |
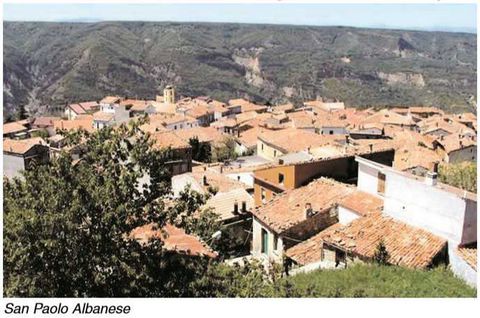 |
 |
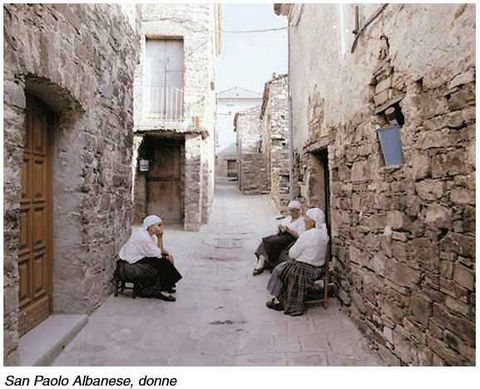 |
 |
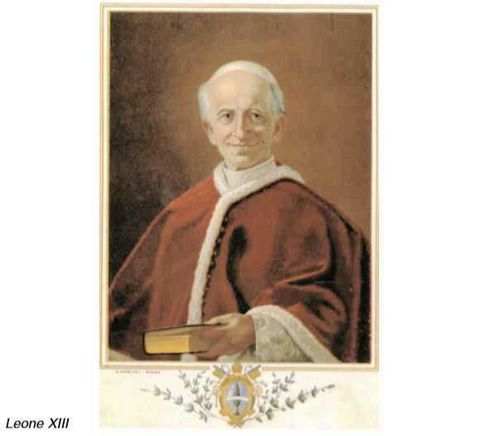 |
|
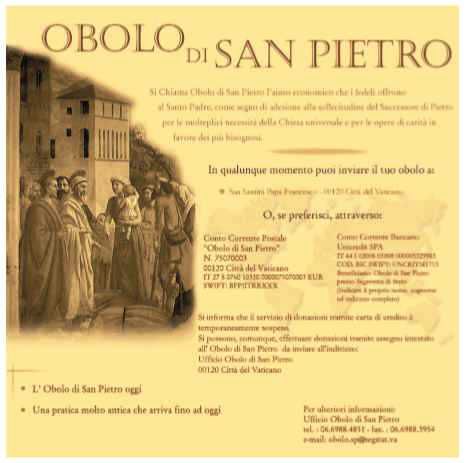 |
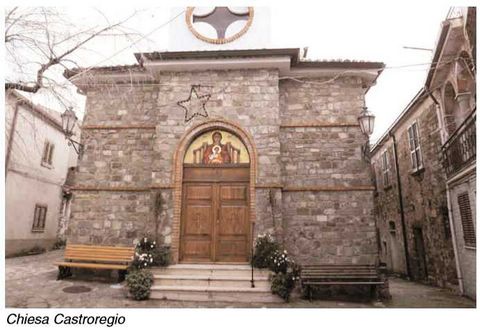 |
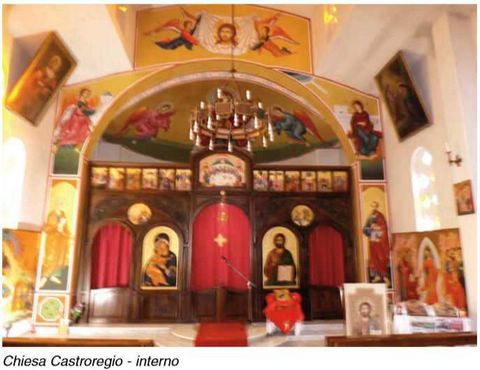 |
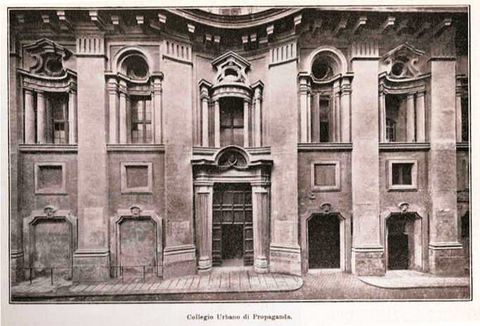 |
 |
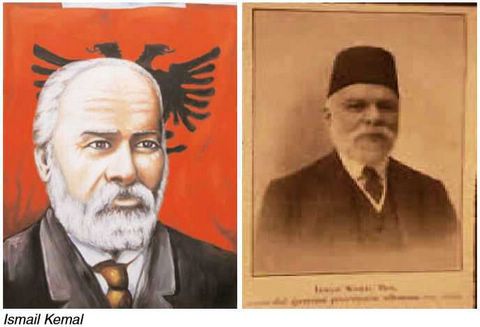 |
|

|
G) RICONOSCIMENTI,
NOMINE RELIGIOSE ED INIZIATIVE PER LA RINASCITA DEL SUO PAESE
Tra le personalità
religiose più in vista delle colonie italo-albanesi, tra i nomi
che venivano proposti alla guida della chiesa di rito
grecoalbanese come ARCHIMANDRITA E VICARI0 GENERALE DEGLI
ITALO-ALBANESI, quello di Pietro Camodeca ricorse con più
frequenza. Egli, infatti, era in possesso di tutte quelle doti
che servivano a formare la personalità di un prelato, che doveva
esercitare il suo alto e difficile ministero in un ambiente che
andava riformato ed avviato verso nuove mete; era un uomo
energico, che aveva la forza di opporsi alla marea che saliva e
che, nello stesso tempo, sapeva arginare fermenti e aspirazioni
in atto. Camodeca, ormai cinquantenne, era figura nota non solo
negli ambienti romani, ma in tutti i comuni italoalbanesi della
Calabria e Basilicata. La nomina, però, non venne forse per
alcune sue prese di posizione ed alcuni suoi giudizi sui
Gesuiti, che non erano stati dimenticati. Anche gli avversari
del suo paese, pochi ma spietati, lo attaccarono sul piano della
moralità, spargendo voci calunniose, lanciando accuse infamanti,
che trovarono il loro epilogo nei Tribunali, ma dalle quali egli
ne uscì indenne. Ma gli odi dei piccoli centri erano tenaci e i
meriti quasi mai venivano riconosciuti per quel deteriore
sentimento di invidia, che avvelenava l’ambiente di tutti i
piccoli comuni, tramandando e perpetuando inimicizie e rancori.
Don Pietro, però, era uno scoglio e resistette a tutti i marosi,
anche se, amareggiato, si vide costretto ad inviare al Papa la
seguente supplica.
«Io sottoscritto, D.
Pietro Arciprete Camodeca dei Nobili Coronei da Castroregio,
diocesi di Anglona e Tursi, avendo saputo da fonte sicura a, che
intorno al mio nome è stato qualche appunto presso la
congregazione del Santo Ufficio; perché cosi hanno voluto i miei
nemici, i quali, per odio di partito, più che ferire la mia
famiglia che domina nel paese per mente e posizione sociale, si
sono divertiti di i ferire me sacerdote che la rappresento». «
Santità, io tengo moltissimo al buon nome ereditato dagli avi
miei, i quali vennero nel 1535 5 da Corone della Morea, dopo che
questa città venne definitivamente in potere dei Turchi,
portando seco la spada e la croce e ci tengo altresì per essere
io in cura di anime.
« Pertanto supplico la Santità Vostra vigile custode della
verità e della giustizia e l’avrò come da Dio consolatore degli
oppressi ».
Gli incarichi e le
successive nomine dimostrarono che le gerarchie ecclesiastiche e
le autorità civili non avevano dato credito alle voci
tendenziose messe in giro per distruggere un uomo, che troppo
aveva dato, ed avrebbe ancora dovuto dare al suo paese e alla
sua gente, in quanto ottenne: • Nel 1895 la nomina a Presidente
della Società Nazionale Albanese, • Nel 1898 dal vescovo Mons.
Pujia la nomina di Vicario Generale per le parrocchie
italo-greche, in conformità delle prescrizioni della Bolla “
Etsi Pastoralis “ del Santo Pontefice Benedetto XIV.
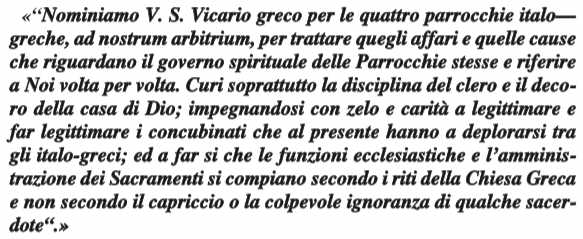
Nel 1899, su proposta del Ministro
dell’Interno, gli fu conferita dal Re la nomina di Cavaliere
della Corona d’Italia, come riconoscimento per gli atti di
filantropia compiuti nel proprio paese. Nel 1903, nel sinodo
diocesano di Anglona e Tursi, venne nominato Esaminatore,
Giudice sinodale e Vicario degli albanesi di quella diocesi.
L’anno seguente, Mons. Giovanni Barcia, vescovo di Croia, lo
nominò vicario Generale degli italo-greci della Calabria e della
Basilicata.
« Quale persona idonea per mente e
cuore, ed a me ben nota ed accetta, da impromettersi sicuri
risultamenti di zelo chiesastico e civile nella missione che gli
ho affidato »
Lo stesso vescovo inoltrò, anche una
proposta al Sommo Pontefice perché il Camodeca fosse nominato
suo Coadiutore. I vescovi latini, delle diocesi meridionali, non
riuscivano sempre a capire i problemi di questa gente che
parlava un’altra lingua e seguiva un altro rito e i cui
sacerdoti avevano la facoltà di sposarsi; inoltre, il vescovo
greco, sempre lontano, non conosceva i paesi, né le persone, e
le sue mansioni erano molto limitate. Tutte queste
considerazioni inducevano ad esprimere un giudizio negativo
sull’operato delle autorità ecclesiastiche centrali, le quali
non avrebbero dovuto procra-stinare l’istituzione della diocesi
autonoma di rito greco, per la quale tanto si era battuto il
Camodeca. Il titolo, che più degli altri fu un segno di
distinzione, gli venne dall’oriente, quale riconoscimento dei
suoi alti meriti, acquisiti nel campo delle rivendicazioni e del
suo attaccamento al rito greco. Sua Beatitudine Cirillo VIII,
Patriarca di Antiochia, di Alessandria, di Gerusalemme e di
tutto l’Oriente, nominò, infatti, il Rev.do Arciprete D. Pietro
Camodeca dei nobili Coronei di Castroregio, Archimandrita.
Riportiamo integralmente il testo del decreto di nomina, che si
trova conservato in casa Camodeca.
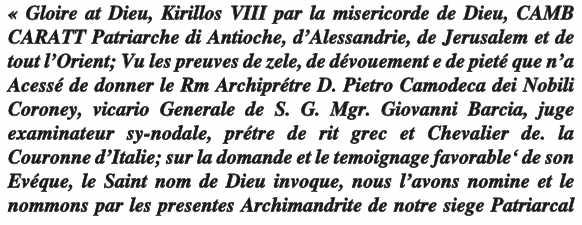
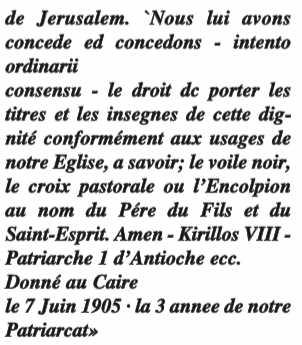
Già lo stemma della famiglia Camodeca de
Coronej, “una stella che da occidente manda un raggio di luce
sulla mezzaluna contro la quale un pugno punta la spada”,
mostrava la fierezza della sua razza. In una pubblicazione, in
lingua francese, edita dal Collegio Pontificio Greco, vennero
descritti i solenni festeggiamenti svoltisi per il quindicesimo
centenario di S. Giovanni Crisostomo, a Roma, dove convennero
personalità da tutto il mondo orientale. Il 12 febbraio 1907,
alla presenza del Papa, venne celebrato un solenne pontificale
in rito bizantino e nel citato volume, tra le immagini delle più
alte dignità ecclesiastiche presenti, è riprodotta anche quella
del Camodeca, la stessa che comparve nel lavoro, con la seguente
didascalia << Le Rév. Archimandrite Pierre Camodeca dei nobili
Coronei, Representant les colonies albaneises de la Calabre » .
Ai primi del 1900 l’Italia da poco riunita tentava di ripartire
così come le regioni meridionali, dove la povertà era più
evidente. L’agricoltura produceva il fabbisogno per la popolazione, ma vi
erano delle nicchie di territorio dove si producevano prodotti
di qualità che potevano rappresentare la nazione anche
all’estero. Questa era la Calabria, dove un piccolo paese,
Castroregio, produceva ed esportava prodotti apprezzati nel
mondo. Il Camodeca era una personalità polivalente, che agli
studi severi per le iniziative culturali e religiose accoppiò
alcune realizzazioni nel campo dell’agricoltura e della
industria. Più che servirci di quanto scritto su questo
argomento e sulle sue atti-vità preferiamo riportare quello che
fu pubblicato su « Il Lavoro Internazionale illustrato »,
un’autorevole rivista specializzata che si stampava a Napoli.
Nei numeri 4 e 5, dell’ottobre-novembre 1906, e 6 e 7, del
dicembre-gennaio 1906-1907, furono dedicate intere pagine al
Camodeca, del quale venne pure pubblicata la fotografia accanto
al panorama di Castroregio. «Tra le altre cose ed opere di
carità e di filantropia cittadina, fece costruire un mulino a
vapore ed un oleificio dove si estraeva un ottimo olio, premiato
in tutte le maggiori esposizioni italiane ed esteri»
L’agricoltura produceva il fabbisogno per la popolazione, ma vi
erano delle nicchie di territorio dove si producevano prodotti
di qualità che potevano rappresentare la nazione anche
all’estero. Questa era la Calabria, dove un piccolo paese,
Castroregio, produceva ed esportava prodotti apprezzati nel
mondo. Il Camodeca era una personalità polivalente, che agli
studi severi per le iniziative culturali e religiose accoppiò
alcune realizzazioni nel campo dell’agricoltura e della
industria. Più che servirci di quanto scritto su questo
argomento e sulle sue atti-vità preferiamo riportare quello che
fu pubblicato su « Il Lavoro Internazionale illustrato »,
un’autorevole rivista specializzata che si stampava a Napoli.
Nei numeri 4 e 5, dell’ottobre-novembre 1906, e 6 e 7, del
dicembre-gennaio 1906-1907, furono dedicate intere pagine al
Camodeca, del quale venne pure pubblicata la fotografia accanto
al panorama di Castroregio. «Tra le altre cose ed opere di
carità e di filantropia cittadina, fece costruire un mulino a
vapore ed un oleificio dove si estraeva un ottimo olio, premiato
in tutte le maggiori esposizioni italiane ed esteri»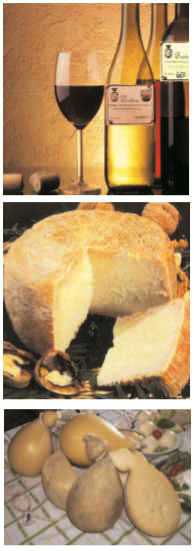 All’Esposizione di Salerno del 1870 figuravano, meritevolmente
ad uno dei primi posti, dei generi commestibili del cav.
Camodeca dei nobili Coronej da Castroregio (Cosenza), cui
l’aristocrazia del casato non impediva un lavoro assiduo. «...Il
suo olio era di pura oliva; non imbrogli di filtri o di chimiche
composizioni, ma tale e quale era colato dai torchi. Nella
cottura dei cibi esso poteva sostituire con vantaggio, senza
tema di disgusto, il burro o il grasso. Anche il vino era un
ottimo prodotto, un vino bianco da dessert, che portava il
caratteristico nome albanese di Trutmer, parola che vuol dire:
far girare la testa. Questo vino univa alla robusta sostanza una
delicata fattura, che lo rendeva gradevolissimo, sì da poter
fare splendida figura in qualsiasi aristocratico pranzo». «Di
vero e proprio latte di vacca, erano i caciocavalli, anch’essi
di produzione propria. Nulla avevano da invidiare ai migliori
della Basilicata e delle Puglie, e se ne producevano di tutte le
forme e grandezze, per lo più piccoli, per soddisfare le
richieste dei mercati locali e per non farli deteriorare
all’aria: erano apprezzati per la bontà, per il sapore squisito
e per la sicurezza che ispirava la loro manifattura». « Il
formaggio di ghiande era una novità e una specialità nel
contempo introdotta dal cav. Camodeca. » «L’idea della
fabbricazione di questi formaggi di ghiande fu suggerita al Cav.
Camodeca dal fatto che si perdevano i due terzi del prodotto
delle querce in tempo di carica, per mancanza assoluta di
commercio, mentre poi, in tempi di scarsezza, si desiderava il
necessario; questi formaggi di ghiande erano un pasto assai
desiderato e buono per i suini, secondo esperienze fatte ed
accertate; la manipolazione di essi era facile e poco costosa.
Se questa nuova industria, di cui il cav. Camodeca gettò le basi
con intuito così lodevole ed ispirazione tanto felice, si fosse
estesa su vasta scala, i primi a ricavarne un frutto e un utile
sarebbero stati gli agricoltori e gli allevatori di suini; gli
uni per i guadagni che avrebbero ricavato dalla vendita di
questi formaggi, gli altri per il pasto, igienico e benefico,
che avrebbero dato ai propri animali, migliorandone le qualità
intrinseche.
All’Esposizione di Salerno del 1870 figuravano, meritevolmente
ad uno dei primi posti, dei generi commestibili del cav.
Camodeca dei nobili Coronej da Castroregio (Cosenza), cui
l’aristocrazia del casato non impediva un lavoro assiduo. «...Il
suo olio era di pura oliva; non imbrogli di filtri o di chimiche
composizioni, ma tale e quale era colato dai torchi. Nella
cottura dei cibi esso poteva sostituire con vantaggio, senza
tema di disgusto, il burro o il grasso. Anche il vino era un
ottimo prodotto, un vino bianco da dessert, che portava il
caratteristico nome albanese di Trutmer, parola che vuol dire:
far girare la testa. Questo vino univa alla robusta sostanza una
delicata fattura, che lo rendeva gradevolissimo, sì da poter
fare splendida figura in qualsiasi aristocratico pranzo». «Di
vero e proprio latte di vacca, erano i caciocavalli, anch’essi
di produzione propria. Nulla avevano da invidiare ai migliori
della Basilicata e delle Puglie, e se ne producevano di tutte le
forme e grandezze, per lo più piccoli, per soddisfare le
richieste dei mercati locali e per non farli deteriorare
all’aria: erano apprezzati per la bontà, per il sapore squisito
e per la sicurezza che ispirava la loro manifattura». « Il
formaggio di ghiande era una novità e una specialità nel
contempo introdotta dal cav. Camodeca. » «L’idea della
fabbricazione di questi formaggi di ghiande fu suggerita al Cav.
Camodeca dal fatto che si perdevano i due terzi del prodotto
delle querce in tempo di carica, per mancanza assoluta di
commercio, mentre poi, in tempi di scarsezza, si desiderava il
necessario; questi formaggi di ghiande erano un pasto assai
desiderato e buono per i suini, secondo esperienze fatte ed
accertate; la manipolazione di essi era facile e poco costosa.
Se questa nuova industria, di cui il cav. Camodeca gettò le basi
con intuito così lodevole ed ispirazione tanto felice, si fosse
estesa su vasta scala, i primi a ricavarne un frutto e un utile
sarebbero stati gli agricoltori e gli allevatori di suini; gli
uni per i guadagni che avrebbero ricavato dalla vendita di
questi formaggi, gli altri per il pasto, igienico e benefico,
che avrebbero dato ai propri animali, migliorandone le qualità
intrinseche.
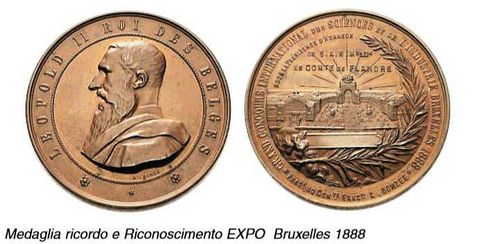
...Nel cavaliere Camodeca
si fondevano insieme le qualità migliori del carattere calabrese
con quello albanese. Pure altre volte abbiamo detto dei suoi
arditi impianti industriali, come il molino a vapore,
l’oleificio, in cima al monte, sulle cui coste si arrampica
Castroregio dalle belle vigne e dagli scuri olivi ». « E’pertanto con nostro grande compiacimento che registriamo le
onorificenze spettate al Cav. Camodeca a Salerno: diploma e
medaglia d’oro e Gran Premio per gli squisiti caciocavalli; così
pure per il bellissimo olio puro d’oliva e per il limpido e
fragrante Trutmer e per i pani di ghiande per i suini: non solo
presso di noi sono stimati i bei prodotti del Cavalier Camodeca,
ma anche fuori d’Italia: a Bruxelles, all’ope-roso uomo
toccarono altissime onorificenze per il purissimo olio e il
generoso Trutmer. Il cavalier Pietro Camodeca trovò pure il
tempo di dedicarsi a studi e ricerche letterarie e filo logiche
intorno al greco, all’albanese e all’italiano in relazione con
le predette lingue ». «Il cavalier Camodeca si recò dal sindaco,
nelle cui mani depose dieci mila lire- somma abbastanza
considerevole- per istituire due premi per quei contadini che
facessero alcune determinate piantagioni nel modo migliore e più
razionale» (n.d.a. per prolungare nel tempo queste magnifiche
produzioni). La citazione sopra riportata era stata ripresa da
una rivista seria, qualificata a livello nazionale; d’altra
parte era servita a delineare la figura di Don Pietro sotto un
particolare suo aspetto e a dimostrare che il patrimonio avuto
venne tenacemente salvaguardato e consolidato dal suo lavoro
assiduo, tenace e intelligente. Anche gli ultimi anni della sua
vita furono operosi; egli, che aveva affrontato in ogni epoca
della sua esistenza problemi di varia natura, si accorgeva, ora,
che l’isolamento del suo piccolo paese era un fattore negativo
per qualsiasi tentativo di rinascita; per modificare un tale
stato di fatto, lavorò con la sua nota passione, sfruttando le
sue amicizie e le sue aderenze. A Terenzio Tocci, in una lettera
del 1916, chiese il suo appoggio autorevole; il senatore
Martuscelli ed i deputati La Cava e Sprovieri vennero
sollecitati per il disbrigo di pratiche familiari, ma anche di
interesse collettivo. Anche con costoro seppe mantenere i
rapporti su un piano di sincerità e di dignità, dal momento che
nelle contese elettorali egli faceva la sua scelta e poi si
schierava apertamente, senza ricorrere al doppio gioco, perché
incapace di venir memo alla parola data. Il Camodeca aveva
biasimato l’operato di un vescovo, che, appena arrivato in
diocesi, si era «messo a capofitto nella lotta politica per
l’elezione del deputato del Collegio di Chiaromonte parteggiando
per un certo Cerabona, contro il deputato uscente Mendaia; e
tanto si era ingolfato, tanto si era appassionato nella mischia
che si dimostrò affatto di essere vescovo e volava di paese in
paese in cerca di voti pel suo Cerabona». Per la rinascita di
Castroregio le richieste di aiuti furono rivolte agli uomini
politici, perché erano problemi temporali quelli che urgevano,
problemi la cui soluzione poteva creare le premesse per la
trasformazione della zona depressa che comprendeva il suo paese
Castroregio e Farneta. Non si voleva restare più isolati, si
volevano creare rapporti nuovi e la strada rappresentava una
necessità inderogabile. I cittadini di Castroregio la
scorgevano, dall’alto, giù, ai piedi del monte, la strada che
portava ad Oriolo, ma essi, a dorso di mulo o a piedi, dovevano
scendere attraverso impervi sentieri, per raggiungerla. Dopo
suppliche e istanze il Sottosegretario di Stato del Ministero
dei Lavori Pubblici dell’epoca ragguagliò il Camodeca, che era
l’anima di questo movimento, che la strada che avrebbe dovuto
congiungere Castroregio al confine di Amendolara si sarebbe
realizzata a breve. Col problema della strada altri ne
riemersero in un paese fermo nel tempo! Egli avrebbe voluto
risollevare le sorti dell’agricoltura, lo abbiamo letto sul «
Lavoro interazionale » e, dopo una visita a Cassano Jonio,
concepì un vasto disegno: far sorgere un istituto enologico e
una cantina sperimentale sul monte di quella cittadina. «La
ricchezza del suolo, la mitezza del clima, la ricercatezza dei
vini mi ha fatto gettare gli occhi sul vostro monte, il quale
con la grande sua estensione di vigne, meglio di tutte le altre
contrade delle provincie meridionali si presta ». Interessanti
gli argomenti che produsse per la realizzazione di un tale
progetto, e quante citazioni di classici, che a lui erano
familiari! «Non erano rinomatissimi e salutari i vini di Sibari,
di Turio, di Lagaria? Plinio li rammenta e Strabone li loda». “
Vinum Thurinum inter vina nobilissimum “. “ Lagaritanum vinum
nobile, dulce ac molle a medicis mirifice commendatum “. “E
Sibari, e Turio, e Lagaria non avevano forse levigne su questo
monte?”. “I nostri vini dunque ebbero anche un tempo la loro
rinomanza: a Roma, ove l’apparecchio del triclinio assorbiva il
maggior tempo e le maggiori cure degli imperatori, a fianco
dell’anfora di Falerno, aveva posto la anfora del vino
calabrese!” Una stasi, però, sopravvenne, perché un grande
cataclisma si abbatté sull’Italia: la prima guerra mondiale.
Furono anni di sacrifici e di dolore: da Castroregio partirono
tanti giovani ed alcuni non ritornano. Erano anche gli ultimi
anni di Don Pietro, che anelava la pace, quella che egli, forse,
trovava tra gli ulivi del suo Frangile, lambito, giù, a valle,
dal fiume Ferro. Lo lasciarono anche i fratelli: nel 1917, l’uno
dopo l’altro, scomparvero Crispino e Domenico. Si avvicinava la
fine anche per lui: l’annosa quercia, come una delle tante di
quelle che i suoi antenati, arrivando, avevano trovato a
Cerviola, quattro secoli prima,si schiantò. Era il 19 Settembre
del 1918.
« E’pertanto con nostro grande compiacimento che registriamo le
onorificenze spettate al Cav. Camodeca a Salerno: diploma e
medaglia d’oro e Gran Premio per gli squisiti caciocavalli; così
pure per il bellissimo olio puro d’oliva e per il limpido e
fragrante Trutmer e per i pani di ghiande per i suini: non solo
presso di noi sono stimati i bei prodotti del Cavalier Camodeca,
ma anche fuori d’Italia: a Bruxelles, all’ope-roso uomo
toccarono altissime onorificenze per il purissimo olio e il
generoso Trutmer. Il cavalier Pietro Camodeca trovò pure il
tempo di dedicarsi a studi e ricerche letterarie e filo logiche
intorno al greco, all’albanese e all’italiano in relazione con
le predette lingue ». «Il cavalier Camodeca si recò dal sindaco,
nelle cui mani depose dieci mila lire- somma abbastanza
considerevole- per istituire due premi per quei contadini che
facessero alcune determinate piantagioni nel modo migliore e più
razionale» (n.d.a. per prolungare nel tempo queste magnifiche
produzioni). La citazione sopra riportata era stata ripresa da
una rivista seria, qualificata a livello nazionale; d’altra
parte era servita a delineare la figura di Don Pietro sotto un
particolare suo aspetto e a dimostrare che il patrimonio avuto
venne tenacemente salvaguardato e consolidato dal suo lavoro
assiduo, tenace e intelligente. Anche gli ultimi anni della sua
vita furono operosi; egli, che aveva affrontato in ogni epoca
della sua esistenza problemi di varia natura, si accorgeva, ora,
che l’isolamento del suo piccolo paese era un fattore negativo
per qualsiasi tentativo di rinascita; per modificare un tale
stato di fatto, lavorò con la sua nota passione, sfruttando le
sue amicizie e le sue aderenze. A Terenzio Tocci, in una lettera
del 1916, chiese il suo appoggio autorevole; il senatore
Martuscelli ed i deputati La Cava e Sprovieri vennero
sollecitati per il disbrigo di pratiche familiari, ma anche di
interesse collettivo. Anche con costoro seppe mantenere i
rapporti su un piano di sincerità e di dignità, dal momento che
nelle contese elettorali egli faceva la sua scelta e poi si
schierava apertamente, senza ricorrere al doppio gioco, perché
incapace di venir memo alla parola data. Il Camodeca aveva
biasimato l’operato di un vescovo, che, appena arrivato in
diocesi, si era «messo a capofitto nella lotta politica per
l’elezione del deputato del Collegio di Chiaromonte parteggiando
per un certo Cerabona, contro il deputato uscente Mendaia; e
tanto si era ingolfato, tanto si era appassionato nella mischia
che si dimostrò affatto di essere vescovo e volava di paese in
paese in cerca di voti pel suo Cerabona». Per la rinascita di
Castroregio le richieste di aiuti furono rivolte agli uomini
politici, perché erano problemi temporali quelli che urgevano,
problemi la cui soluzione poteva creare le premesse per la
trasformazione della zona depressa che comprendeva il suo paese
Castroregio e Farneta. Non si voleva restare più isolati, si
volevano creare rapporti nuovi e la strada rappresentava una
necessità inderogabile. I cittadini di Castroregio la
scorgevano, dall’alto, giù, ai piedi del monte, la strada che
portava ad Oriolo, ma essi, a dorso di mulo o a piedi, dovevano
scendere attraverso impervi sentieri, per raggiungerla. Dopo
suppliche e istanze il Sottosegretario di Stato del Ministero
dei Lavori Pubblici dell’epoca ragguagliò il Camodeca, che era
l’anima di questo movimento, che la strada che avrebbe dovuto
congiungere Castroregio al confine di Amendolara si sarebbe
realizzata a breve. Col problema della strada altri ne
riemersero in un paese fermo nel tempo! Egli avrebbe voluto
risollevare le sorti dell’agricoltura, lo abbiamo letto sul «
Lavoro interazionale » e, dopo una visita a Cassano Jonio,
concepì un vasto disegno: far sorgere un istituto enologico e
una cantina sperimentale sul monte di quella cittadina. «La
ricchezza del suolo, la mitezza del clima, la ricercatezza dei
vini mi ha fatto gettare gli occhi sul vostro monte, il quale
con la grande sua estensione di vigne, meglio di tutte le altre
contrade delle provincie meridionali si presta ». Interessanti
gli argomenti che produsse per la realizzazione di un tale
progetto, e quante citazioni di classici, che a lui erano
familiari! «Non erano rinomatissimi e salutari i vini di Sibari,
di Turio, di Lagaria? Plinio li rammenta e Strabone li loda». “
Vinum Thurinum inter vina nobilissimum “. “ Lagaritanum vinum
nobile, dulce ac molle a medicis mirifice commendatum “. “E
Sibari, e Turio, e Lagaria non avevano forse levigne su questo
monte?”. “I nostri vini dunque ebbero anche un tempo la loro
rinomanza: a Roma, ove l’apparecchio del triclinio assorbiva il
maggior tempo e le maggiori cure degli imperatori, a fianco
dell’anfora di Falerno, aveva posto la anfora del vino
calabrese!” Una stasi, però, sopravvenne, perché un grande
cataclisma si abbatté sull’Italia: la prima guerra mondiale.
Furono anni di sacrifici e di dolore: da Castroregio partirono
tanti giovani ed alcuni non ritornano. Erano anche gli ultimi
anni di Don Pietro, che anelava la pace, quella che egli, forse,
trovava tra gli ulivi del suo Frangile, lambito, giù, a valle,
dal fiume Ferro. Lo lasciarono anche i fratelli: nel 1917, l’uno
dopo l’altro, scomparvero Crispino e Domenico. Si avvicinava la
fine anche per lui: l’annosa quercia, come una delle tante di
quelle che i suoi antenati, arrivando, avevano trovato a
Cerviola, quattro secoli prima,si schiantò. Era il 19 Settembre
del 1918.
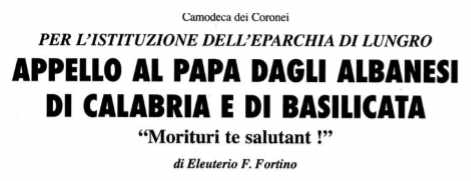
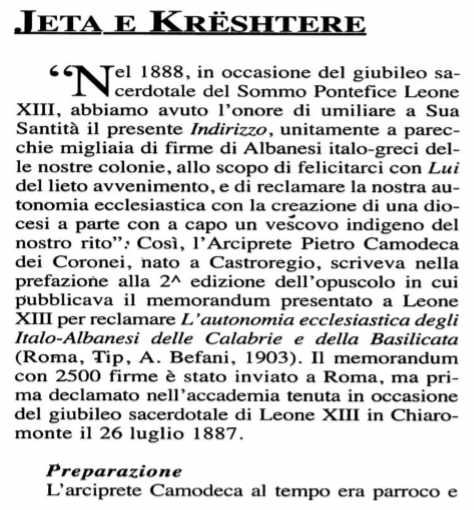
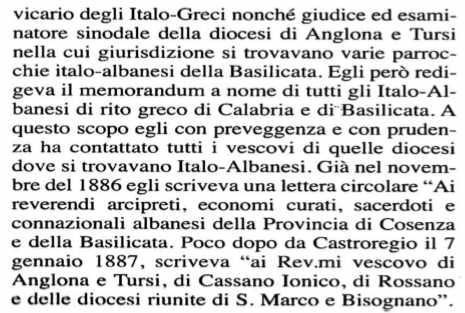
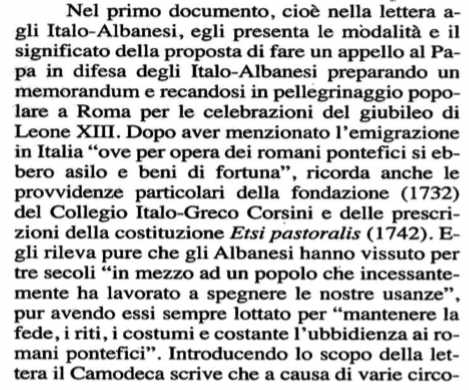
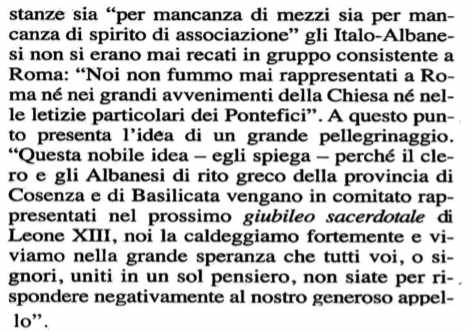
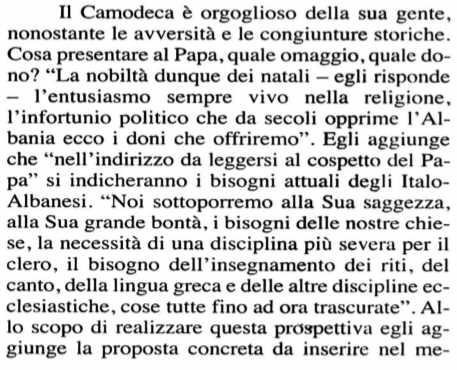
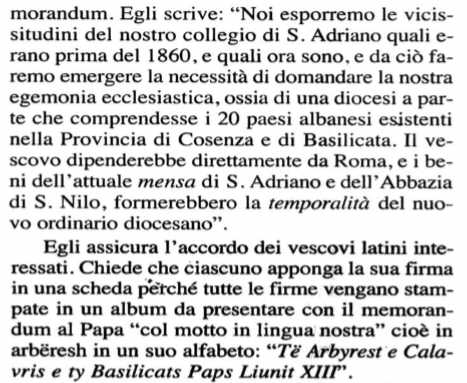
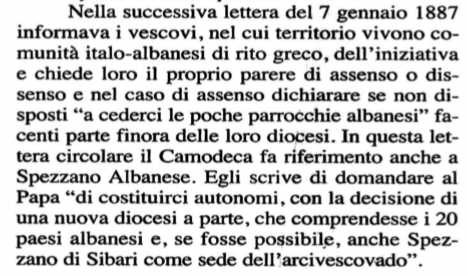

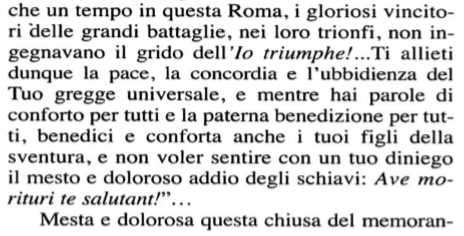
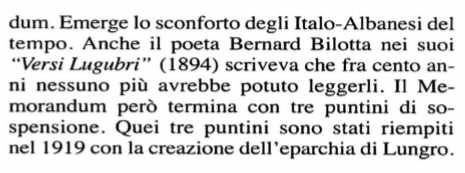


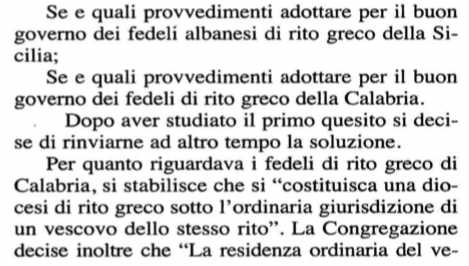
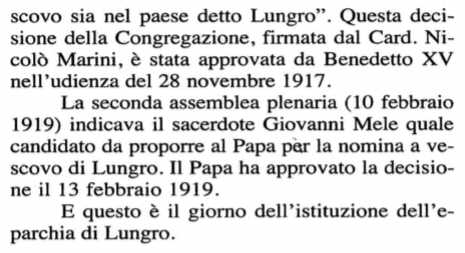
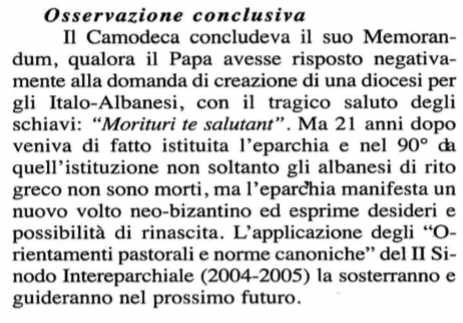 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
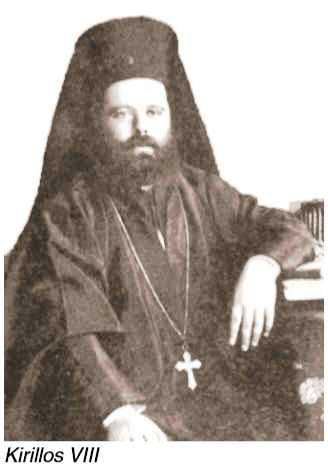 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
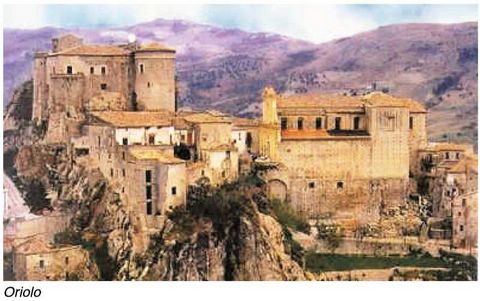 |
 |
|
 |
|
 |
BIBLIOGRAFIA - SEGUE >>
|