|
PARTE VI
(continuazione)
 |
|
Vico Mazzolla (dalla Via C. Battisti) |
Si era preparato
un validissimo tecnico, il buon Mario Molinari, che fu, poi, tecnico
all'Istituto d'Igiene e Profilassi di Potenza e, in seguito e sempre per
concorso, apprezzatissimo tecnico dell'Igiene e Profilassi di Salerno.
In quel laboratorio e con loro due cominciai a fare le prime conoscenze
con provette e pipette e microscopio, che mi furono di sicuro e prezioso
giovamento.
« Il professore » fu uomo buono, retto, onesto, fustigatore del
malcostume, fu implacabile con i vili e i fessi; fu aperto cordiale con
gli amici e altrettanto chiaro e intransigente con gli ipocriti e i
nemici; amò la sua terra e sopra ogni cosa la Patria; non amò il
protagonismo e le smargiassate chiazzaiole tant'è che, appena ebbe
l'impressione di dover morire, consegnò al fedele Peppino Troiano
tassative disposizioni per la malattia, che fu brevissima, e per il
funerale, per concludere nel silenzio la sua vita terrena.
Sull'imbrunire, chiuso in quattro modeste tavole e con carro di terza
classe, l'accompagnammo in quattro-cinque, non eravamo figli, perché non
ebbe figli, eravamo quelli che potevamo dire di conoscerlo veramente ed
eravamo dietro la sua bara per onorarlo nel silenzio, non nel culto
della personalità, ma nel culto dell'uomo.
E ritorno a Piazza del Sedile ed il ritorno mi serve anche per ricordare
che la piazza vide l'alba e la crescita, culturale e tecnica, di una
grande tipografia, la « Tipografia Garramone e Marchesiello », a
proposito della quale, ai primi del secolo il « Lucano » così scriveva:
« ... in piazza Sedile gemono i torchi della Tipografia Garramone e
Marchesiello, nota ormai in Judea per la precisione e l'eleganza dei
suoi lavori: l'impareggiabile proto, i bravi operai sono occupati nella
stampa... ». Non ho ricordi personali ma le testimonianze raccolte mi
hanno convinto che l'onesto riconoscimento del « Lucano » era anche
modesto nei confronti dei meriti della Tipografia, dei dirigenti, delle
maestranze. Non ho documenti visivi eccezionali da mostrare, ho soltanto
due cartoline illustrate, che mi pare dicano molto e tanto.
 |
|
Particolare del Palazzo Castellucci (il portone con il balcone) |
Mi incammino,
quindi, verso la piazza Prefettura, passando per il Larghetto, che fu «
Dea Mefiti » prima, « Martiri Lucani » poi, ed, infine, dopo il 1900,
intitolato a Rocco Brienza, nei cui pressi vi era la « Chiesetta di San
Nicola », che fu al centro di numerosi ed importanti momenti religiosi,
sociali ed artistici della città, per proseguire per via XX settembre,
Larghetto Fratelli Cairoli, a monte, e via San Francesco, a valle.
Il palazzo, che presento in due bellissime fotografie, in una visto
nell'intera facciata, nell'altra nel particolare del portone con il
balcone sovrastante dalla bella ringhiera in ferro battuto, e che,
purtroppo, esiste solo nelle immagini e nella memoria di alcuni perché
da tempo fatto scomparire e sostituito da un palazzone moderno e dalle
moderne vetrine, faceva bella mostra di sé proprio nella piazzetta Rocco
Brienza, a cui dava prestigio e austerità. Anzi, dava anche il nome. Il
palazzo, infatti, era della famiglia Castellucci, a mio ricordo storico,
forse, l'unica famiglia che potesse vantare una nobile origine e,
perciò, il Larghetto era indicato e conosciuto come « Largo Castellucci
».
 |
Un Largo sempre
frequentato ed affollato sia perché punto di passaggio quasi obbligato
per gli studenti dell'Istituto Magistrale e del Ginnasio-Liceo, sia per
quelli che venivano dal Rione Santa Maria ed erano diretti a Piazza
Sedile, sia per le nostre mamme perché nel Largo vi erano le bancarelle
con qualche utile mercanzia ma, innanzitutto, vi era il forno a legna e
la simpatica ed instancabile Arcangiolina, « furnara », con cui, almeno
una volta alla settimana, bisognava mettersi d'accordo per il pane e ad
Arcangiolina bisognava dire il numero delle « scanare », le panelle, e
se si preferiva al primo, al secondo o al terzo forno, le tre infornate
di ogni giorno.
E, sì, perché, allora, il pane si faceva in casa e ogni famiglia
provvedeva per proprio conto e, in base al numero delle bocche, si
faceva una tavola o « na scanatora » o mezza tavola, tenendo presente
che su ogni tavola si mettevano sette o otto « scanare », che erano
delle vere e proprie macine di mulino. Ma, tanto, il pane si consumava
perché era l'elemento essenziale e, talvolta, anche il solo ma si
mangiava lo stesso anche quando era « seriticce », forse, era più
gustoso.
In genere, quando si faceva il pane, si pigliava un pezzo di pasta, si
schiacciava con il palmo della mano, si faceva un buco al centro e si
cuoceva « alla vampa », era « lu ruccule ». Talvolta, veniva condito con
l'origano, la « cirasedda » ed anche con l'aglio triturato per renderlo
più saporito. In genere, si mangiava caldo e fumante, appena uscito dal
forno, talvolta, non arrivava nemmeno a casa e quando arrivava veniva
innaffiato con lunghe bevute di « sottapera », direttamente dalla fiasca
e a garganella.
Certamente, più squisito, ma non per tutte le tasche, era « lu ruccule
'chiene », cioè pieno di formaggio e di toppe di salsiccia ma ottimo era
anche « lu ruccule cu li frìttele », immancabile quando si uccideva il
maiale e si preparava la sugna.
Era quasi un rito uscire dal forno con la tavola piena di panelle
fumanti e fragranti e quasi in processione. Pur sotto il peso, che
gravava sulla testa e sul collo, le donne con il loro sorriso mostravano
la gioia di portare a casa l'indispensabile mezzo di sostentamento e la
loro gioia era anche rispetto per il pane « che si guadagnava con il
sudore della fronte».
Nella loro letizia offrivano un assaggio a tutti quelli che
incontravano, conoscenti e non, e anche con un pizzico di orgoglio per
sentirsi dire « ccch' bello pane c'hai fatto ». L'offrivano con maggiore
insistenza a « li femine prene », anzi, le obbligavano perché « 'mmoglia
a Dio lu piccininne nascìa cu lu vulìe ». Era come portare un grande
scrupolo per tutta la vita.
La specialità tradizionale e che era di tutte le case, da quelle più
benestanti a quelle più povere, era « lu piccilatiedde », che si faceva
a Natale. « Nu tortano » grande di forma, pesante, fatto con fiore di
farina scelta, « la carosella », che prima di essere impastata veniva
setacciata più volte e con le setine sempre più strette.
Si cominciava un mese prima a trovare il grano adatto, a sceglierlo, a
pulirlo bene, si portava al mulino direttamente perché non lo
mischiassero con il grano comune e i giorni della vigilia erano i giorni
di vera febbre, anche perché bisognava starsi attenti alla pasta che
crescesse bene, al momento opportuno per infilare le mandorle, nel senso
e nello spessore giusto, in modo che, a cottura, apparissero bene
sotto-crosta, e stare con un orecchio al forno per sentire a tempo « li
cummanne d' la furnara ».
Il forno di Arcangiolina era dove, oggi, si ammira il negozio di
elettrodomestici dei Fratelli Cassano. Era un locale molto ampio,
servito da un'apertura, altrettanto ampia, a volta, ai cui lati
pendevano, più che essere bene infissi, i due battenti di una specie di
porta, poco utile alla funzione che avrebbe dovuto svolgere, molto
fastidiosa, come cosa inutile, specialmente quando arrivavano i
mulattieri e dovevano scaricare dai muli le pesanti some di « 'ddegne e
frascedde ». I due battenti, nella parte inferiore, erano fatti di
legname, non certo pregiato, a sfoglia sottile, mentre nella parte
superiore erano a vetri, quelli comuni, quelli che si usavano per le
finestre, in verità io non li ricordo mai tutti interi, c'era sempre
qualcuno rotto e, talvolta, erano tutti rotti, vittime di spifferi di
vento o di maldestro mulattiero. Ma tutta questa necessità dei vetri non
c'era e non né parliamo dei vetri sofisticati di oggi, antifurto,
antiproiettili, termici e via discorrendo, ma non vi era nemmeno la
necessità della porta, in primo luogo perché il forno era aperto
dall'alba alla nera notte e poi perché nessuno sparava a bersaglio
preciso o all'impazzata e, innanzitutto, si usava ancora rispettare il
comandamento di Dio di non rubare.
Eravamo proprio fessi a quei tempi, ai tempi di vavone! Nientemeno non
si rubava e non sapevamo rubare e menomale che siamo fatti tutti vecchi
perché con questa grave e imperdonabile lacuna culturale, ai tempi
andanti, non avremmo fatto alcuna carriera.
Bè, non vorrei proprio esagerare, ma qualche furtarello, pure, si
faceva: la gallinella, qualche uovo, un po' di frutta da sopra l'albero,
perché era fresca e più saporita, un po' di uva alla vigna ma o si
finiva con le chiappe impallinate a sale dai padroni, ben vigili, o si
finiva nelle mani di don Aniello, il brigadiere che la sapeva lunga ed
aveva fiuto e mestiere e faceva anche simpatia, con il suo sorriso
sornione e con i suoi modi cavallereschi, che quasi quasi faceva venire
il desiderio di farsi arrestare.
|
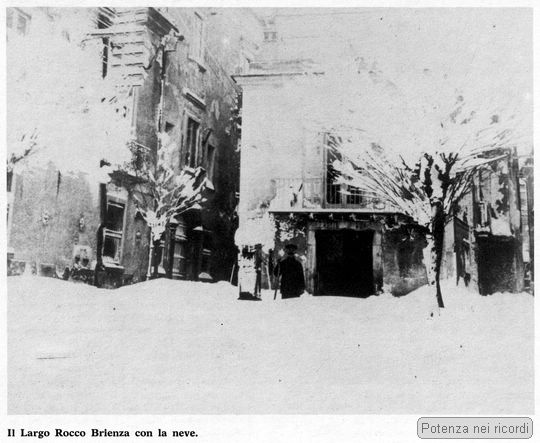 |
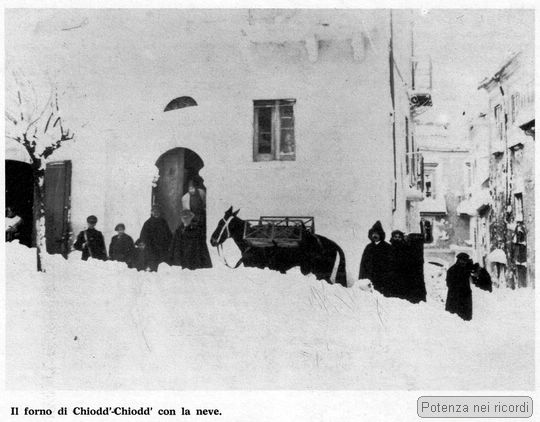 |
Insomma, senza
divagare molto, il forno era sempre aperto anche quando Arcangiulina si
recava a domicilio a ritirare le tavole, chiene di scanare o quando le
riportava cotte e fumanti, appena uscite dal forno. E, sì, perché la
povera Arcangiulina, oltre alle « pubbliche relazioni » « Gerarda
'mpasta subito e scana p' lu primo » (cioè per il primo forno), oppure «
Filumena dorme 'npo' 'cchiù e scana p' lu sicondo », oppure « Angeluzza
nunn' t' 'mprescià e scana p' lu terzo », oltre a curare il
riscaldamento del forno e quando i mattoni diventavano bianchi « ca
tanne tanne savìa 'nfurnà », andava anche a domicilio a servire quelle
clienti « ca nunn' tenienne salute » e che non avevano un aiuto.
Poggiava « la spara », una specie di cercine fatto di stracci, al centro
della testa e sopra caricava le lunghe tavole « cu la grazia di Dio »,
come facesse a mantenersi in equilibrio e a fare stare in equilibrio
quelle tavole, tenendo conto anche dello stato delle strade e della
ubicazione delle case, io non me lo sono spiegato mai a sufficienza se
non tenendo conto dell'esperienza acquisita nei tanti anni di duro,
durissimo lavoro. Ed era un lavoro per il quale non bastava impegnarsi
soltanto fisicamente ma bisognava fare molta attenzione perché la caduta
di una tavola determinava scompiglio, grida e disperazione per il
quantitativo di pasta o di pane che si poteva perdere, ed era già
importante, ma soprattutto perché era di cattivo augurio.
Le tavole entrate nel forno venivano poggiate, in attesa che tutto fosse
pronto, sopra paletti infissi nel muro a giusta distanza, sia sulla
parete di destra che su quella di sinistra, ed una sull'altra fino ad
una certa altezza, compatibile con la statura delle utenti.
Era un rito l'infornata perché ogni donna si stava attenta a mettere il
suo segno particolare di riconoscimento sulla pasta, appena Arcangiulina
caricava la panella sulla pala, ma era un rito chiassoso, anche gioioso,
la sfornata con il riconoscimento delle proprie « scanare ». E questo
era il tran tran di tutti i giorni per la povera Arcangiulina, distrutta
dalla fatica fisica, dagli improvvisi cambiamenti dal caldo al freddo,
dalle grida e dalle chiacchiere perché purtroppo quando si ha da fare
con la gente « gn'è 'cchi la vole cotta e gn'è 'cchi la vole crura ».
Una donna che conservava sul volto ancora i segni di una sfiorita
bellezza e nell'espressione si leggeva tutto il suo buon cuore e la sua
comprensione e che non si scomponeva mai « mè... sì... chiane...
chiane... e mò accuntenta a tutte ».
Uscendo dalla scuola passavamo a chiedere quando mamma poteva fare il
pane, era l'ora in cui, ancora affannosa, poteva asciugarsi il sudore,
ci guardava come solo una mamma sa guardare, « scanasse dimane p' lu
sicondo » e non mancava mai di aggiungere « studiare, figli miei,
studiare ca quedda puveriedda (era mia madre) s'accire 'cchiù d' mì ».
|