|
PARTE X
La frase « nu gire
p' la Strara », dunque, ha significato sempre per il « putenzese »,
quello verace, genuino, quello nato a Portasav'ze o a lu Castiedde, a
Portamendola o al vico Corrado, ma anche per il « putenzese » di
adozione, un momento di piacere, di distensione, un momento di riposo
dopo una giornata di lavoro, un momento di ricreazione dello spirito e
del corpo, un momento di aggregazione.
Salvo impedimenti di forza maggiore, la « giurnara d' lu putenzese nunn'
s' putìa 'chiodd' senza nu gire p' la Strara » e non era soltanto per
una buona o cattiva abitudine, solo « p' svalià lu pensiere » o « p' li
solite doie chiacchiere cu l'amisce » ma era perché in quella strada era
la città, la vita, la storia, in quella strada ognuno si sentiva
realizzato, si sentiva, innanzitutto, cittadino di Potenza. E « la
Strara » del passeggio, delle chiacchiere, dei pettegolezzi, delle
scappellate, degli inchini, delle maldicenze, degli affari, degli
appuntamenti amorosi, delle feste, dei funerali, degli studenti
filonisti era veramente breve perché cominciava a Piazza Sedile per
terminare molto prima di Portasalza. Difficilmente, anche i più
distratti o i più impegnati in animate discussioni, superavano quei
limiti.
Era breve il tragitto, certo, qualche centinaio di metri, ma le persone,
i fatti, gli avvenimenti di quella via Pretoria e che affollano i miei
ricordi e di quanti hanno vissuto qui la loro vita, riempirebbero
chilometri di pellicola cinematografica e tonnellate di carta scritta.
Sono ricordi che partono da lontano, da « quanne cu lu mocco a lu nase »
e con la cartella e grembiulino della scuola elementare andavamo spiando
nelle vetrine, in quelle delle pasticcerie, in modo particolare, e solo
per farci venire l'acquolina in bocca perché soldi da spendere non ne
avevamo. Le altre vetrine o gli altri negozi ci appartenevano poco
perché erano salumerie, erano negozi di scarpe, di cose per grandi e non
che non li guardassimo proprio, li guardavamo come si può guardare un
sogno proibito ma senza invidiare niente e nessuno anche perché, in
fondo, avevamo la speranza che un giorno saremmo entrati anche noi.
Non vi erano negozi particolari per bambini, né per ragazzi, « il
negozio della moda giovane » e dai nomi stranieri, come ci sono ora,
anche perché non avevamo importato dall'estero e nemmeno le nostre
industrie del Nord le avevano preparate, le mode strane e bizzarre, i
jeans, le giacche e i giacconi a quadroni e dai colori più strani e più
vivaci. Tanti di noi ereditavano gli indumenti, anche ben rattoppati,
dai fratelli più grandi. Eravamo poveri noi, appartenenti a ceti sociali
modesti, contadino o artigiano, ma non scialavano, certamente, nemmeno i
figli di quei pochi professionisti, esistenti sulla piazza, né i figli
dei tanti impiegati dello Stato e del Para-Stato, di cui era piena la
città per via che qui erano tutti gli Uffici.
Il reddito generale era modesto, era appena sufficiente per vivere, per
alcuni solo per vivacchiare e, quindi, i giovani non avevano pretese e
non ne potevano avere, anche perché si rendevano ben conto di quello che
c'era in casa e dei sacrifici dei genitori, pure dei sacrifici di tutti,
comunque, non vi era l'abitudine di chiedere ma si aspettava che fosse
donato e « a caval donato non si guardava in bocca » anche perché tutto
era buono e tutto era utile.
Tanti di noi erano appartenenti a famiglie numerose, magari orfani di
padre, ed era facile rimanere in tenera età orfani, sol che si pensi che
bastava una semplice polmonite per andare all'altro mondo e non che
mancassero medici capaci, anzi, mancavano, però, le medicine.
La polmonite si curava con il cataplasmo di semi di lino e l'iniezione
di olio canforato, si diceva per sostenere il cuore e tra la scarsa
abitabilità delle case, l'inclemenza del clima, la gente aspettava, in
ansia e con giustificata preoccupazione ,lo scadere del terzo, del
quinto, del settimo giorno, ritenuti i giorni più pericolosi del male e
durante i quali si poteva verificare il cambiamento in meglio o in
peggio. Il tifo si curava con latte e letto e fermenti lattici e si
aspettava, contando le settimane, che la febbre finisse.
Il più delle volte prima che finisse la febbre finiva il malato e quando
il malato superava la malattia si parlava di miracolo, i più cattivi, i
maldicenti (una razza sempre esistita) mormorava « è giù 'ddà (cioè
all'altro mondo) e nù l'hanne vulù... gn' l'hanne mannà 'ndreta... ». Ma
il poveretto che superava il tifo appariva veramente mal ridotto, tra
malattia lunga, non meno di quaranta-sessanta giorni, dieta assoluta e
letto, dimagriva di parecchi chili, si riduceva pelle e ossa, tanto è
vero che quando si incontrava uno mal ridotto in salute si usava
esclamare «... Marò... sarrà asciù da nu tife...!»
Nonostante tutto, miseria e mancanza di mezzi, non era una malattia
molto frequente, l'acqua era buona e non mancava mai, la città era
pulita, la gente era attenta e rispettosa delle proprie cose e di quelle
della comunità. In casa non c'era la tinozza, non c'erano i detersivi ma
non mancava un buon pezzo di sapone e se era « Lo Faro » tanto meglio,
il bucato si faceva con la cenere e la biancheria non solo si conservava
di più ma era veramente bianca e pulita.
Portavamo i capelli molto corti, alla « Umberto », come li portava, cioè
il Re Umberto I, a spazzola, ma tanti « s' fascienn' lu caruso »
tagliavano i capelli cortissimi con la macchinetta, alcuni si facevano
rapare addirittura con il rasoio, specialmente d'estate. Era un modo
spicciolo, in mancanza di antiparassitari chimici, per difendersi
specialmente dai pidocchi. Le nostre maestre erano attentissime e tutte
le mattine ci passavano in rassegna, uno per uno, capelli, biancheria
intima, vestiti e tutte le mattine chiedevano se in casa vi era qualcuno
ammalato. Allora tenevano campo le malattie infettive e se non ci fosse
stata tutta questa attenzione da parte della famiglia e della scuola ci
sarebbero state grandi epidemie e, quindi, vere carneficine.
Portavamo i pantaloni con le pezze al sedere ma eravamo puliti, mutande
rattoppate, maglie di lana di pecora, originali e fatte in casa ma
pulite, non eravamo unti di cosmetici né massaggiati con unguenti
vitaminici (!), ma eravamo tonici, freschi e profumati di acqua e sapone
ma eravamo profumati anche « di dentro », checchè se ne dica e piaccia o
non piaccia. Dovunque, in casa e fuori, nella scuola come nel lavoro, vi
erano insegnamenti, esempi di sacrifici e di doveri e in ognuno di noi
vi era soltanto l'ansia, la preoccupazione di esserne degni. Guardavamo,
certo, le vetrine della via Pretoria ma non ci creavamo complessi perché
non potevamo avere il dolce o le scarpe nuove consideravamo già troppo
la minestra calda e il pezzo di pane che trovavamo in casa ogni giorno.
Vi sono anche ricordi più vicini, personaggi di quella via e che hanno
lasciato il segno nella storia della città, episodi semplici, forse
futili, ma che ad una rimeditazione non sono, poi, così semplici, né
trascurabili e che, in fondo, sono proprio quegli episodi il volto e
l'essenza del popolo. Eravamo nel 1946, ero da poco tornato dalle tristi
e dolorose vicende ed esperienze belliche ed ero in via Pretoria, in una
mattinata piuttosto uggiosa e, forse, in carattere con la sfilata, che
si stava svolgendo: un funerale.
Come gli altri mi accostai al muro per fare largo. Vicino a me c'era «
nu bracciale » ed anche altri signori. Al passaggio del carro con il
feretro il povero bracciale, commosso e compunto come sa essere solo la
povera gente, con la mano sinistra si tolse il cappello ed alzò la mano
destra nel saluto romano. Così si usava nel deprecato ventennio e lo
facevano tutti, giovani, anziani e vecchi, poveri e ricchi, signori e
cafoni ed erano tutti solerti e solleciti.
Ma eravamo nel 1946, e, ubbidienti ad una delle caratteristiche del
popolo italiano, molti si erano fatti furbi e si erano legata la mano
destra dietro la schiena o dentro la tasca per non essere tentati ad
alzarla nel saluto romano, il contadino no. Venne letteralmente
aggredito e strattonato da quei signori che gli erano vicino, con colpi
da carate gli abbassarono il braccio, gridandogli: « Abbascia stu
braccio... gnurante e cafone ».
Chiunque, forse, lo stesso S. Francesco, si sarebbe ribellato ed avrebbe
risposto allo stesso modo e con le stesse armi, « lu bracciale » no,
dimostrando di avere non solo più buon senso e buona educazione ma di
avere, innanzitutto tanta dignità e tanto rispetto del luogo e di quanto
si stava svolgendo in quel momento. Si ricompose, riportò il braccio nel
saluto romano, con fermezza ma senza particolari atteggiamenti, rispose:
« No, cazzo, sò stà vent'anni p' av'zà stu braccio e mò nù l'abbasce
manch' si m' sparano».
Quei signori se l'erano già squagliata prima che il contadino finisse di
parlare ma se l'erano già squagliata anche perché il funerale era finito
e non avevano platea a cui mostrare la loro bravata né nuovi capi che
potessero apprezzarli e prenotarli per un posto in prima fila.
A proposito di ricordi non molto lontani ma significativi di una certa
saggezza contadina, del nostro contadino, il più delle volte dileggiato
ingiustamente e ingiustificatamente, e di una certa sicumera pseudo
culturale e cittadina, mi viene in mente un episodio, avvenuto sempre in
via Pretoria, e non poteva essere diversamente, e proprio all'imbocco
del vico Picernesi.
Era il momento del referendum « Monarchia - Repubblica » e « nu povero
bracciale », appoggiato ad un angolo del vico, più dentro l'arco che
fuori, forse, per la vergogna di comparire in via Pretoria in quelle sue
spoglie, mostrava, con un certo ben apparente malessere, una pezzotta di
formaggio pecorino e poche uova fresche in un paniere. Aspettava qualche
anima del Purgatorio che avesse comprato la sua merce e l'avesse tolto
da quell'incomoda situazione e posizione, ma in maniera dignitosa, senza
gridare, senza strattonare la gente, insomma « s' fascìa li fatt sove
e... penzava a li vaie sove ».
|
 |
|
Vico Marone già San Domenico |
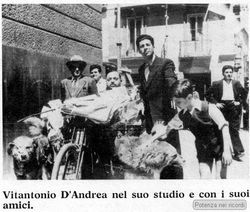 |
Due bellimbusti,
oggi maturi signori, (ma chissà se hanno cambiato carattere), gli si
avvicinarono e strattonandolo di qua e di là, d'altronde si sentivano in
diritto di agire così, loro i cittadini coltivati quello « lu bracciale
incolto », cominciarono ad impartirgli la lezione per la scelta giusta,
che, poi, era quella da loro patrocinata, « perché questo è il senso
della Storia... così vuole la storia... » « ... e sì, sì ca è proprio
sta cazz' d' storia ca adda finì... » li raggelò lu bracciale e si girò
di « cuozzo », lasciandoli alla storia.
Ogni volta che da Piazza Sedile mi avvio per il solito giro « p' la
Strada » guardo e riguardo a destra e non per vedere il chiosco dei
giornali ma quasi illudendomi di rivedere in quei paraggi una persona
cara a tanta gente e, in modo particolare, proprio « a li poveri
bracciali ». Era il buon Vitantonio, aviglianese di origine, potentino
di adozione, affetto da multiple gravi menomazioni, in particolare, agli
arti inferiori. L'amaro destino lo aveva costretto a vivere in una
carrozzella, che, nei trasferimenti da casa al posto di lavoro, per
andare in Chiesa o al campo sportivo, la fede in Dio che era la sua
forza e la passioncella per il suo svago, di cui non faceva mistero, era
tirata da due cani pastoregni, robusti e forti ma mansueti con la gente,
affezionati al padrone, di cui conoscevano bene la voce ed obbedivano ai
suoi ordini in maniera veramente impressionante. Vitantonio era là,
proprio dove ora è il chiosco; d'inverno e d'estate, con il sole o con
il maltempo, nella sua carrozzella, con i suoi cani accucciati ai due
lati, vendeva giornali e non li vendeva soltanto ma li leggeva e li
leggeva anche agli amici, che non mancavano mai proprio intorno alla sua
carrozzella. I suoi amici erano « i bracciali », aviglianesi o putenzesi
o ruotesi o anzesi o di altri paesi, erano tutti uguali e tutti suoi
amici, e non soltanto per ascoltare le notizie del giornale, per essere
consigliati, indirizzati, per farsi scrivere qualche domanda.
Quella carrozzella era diventata un piccolo studio di consulenza e
Vitantonio l'uomo di fiducia della gente. Di ottima intelligenza,
autodidatta, sapeva tutto dei vari uffici, conosceva tutte le leggi e
norme vigenti in materia di Previdenza Sociale, di Assistenza, di
tributi, i suoi consigli verbali erano esatti e quello che scriveva, con
molta fatica perché anche le mani non erano sfuggite alla devastazione
del male, era indiscutibile per forma e contenuti. Faceva tutto con
molto garbo, con il sorriso sulle labbra, con tanta pazienza e tenace
volontà, quella pazienza e volontà non di tutti, che gli facevano
sopportare le sue condizioni fisiche e non soltanto dal punto di vista
psicologico ma anche della sofferenza perché, ogni tanto, il buon
Vitantonio era un ammasso di dolori.
Lo ricordo non perché eravamo amici e mi circondava della sua stima ma
perché è un esempio di come lo spirito, la mente, l'anima dominano la
materia.
Lo ricordo come ho ricordato altri umili, ne ricorderà ancora, perché
sono convinto che la storia della città l'hanno fatta questi personaggi,
che frettolosamente abbiamo dimenticato, e non tipi come quei due
bellimbusti, che volevano impartire la lezione di storia a « lu
bracciale ».
La storia della città l'hanno fatta i Cascavadd', i Trentacarrine, i
Culacizze, i Taccariedd', i Pappacionne, i Brachettedda, i Malamugliera,
i Baccalà, gli Sciarrilli, i Canaria e tanti altri e l'hanno fatta con
le loro opere umanitarie, con il loro lavoro, con la loro serietà ed
onestà. Questi sono stati gli artefici della vita di una città, tenuta
chiusa nel suo orizzonte, lontana dalle grandi ventate di rinnovamento e
di progresso e tenuta chiusa e lontana proprio da quelli che hanno avuto
il potere e che si illudevano, così, di fare la storia, proprio da
quelli che sapevano leggere e scrivere, intellettuali o
intellettualoidi.
Poco più in là dello studio di Vitantonio, sulla sinistra andando verso
la Piazza Prefettura, in uno di quei locali che la furia devastatrice
non ha distrutto né stravagantemente rinnovato, vi era il negozio della
« Riccia Cammellota ». Per i bambini, ma anche per i meno bambini e per
gli adulti, la vetrina di quel negozio costituiva una fermata d'obbligo,
specialmente durante il periodo di Carnevale, per i costumi da maschera,
sempre nuovi e fantasiosi, che quella vetrina mostrava.
L'artista-artigiana di quei costumi, di vestiti stupendi anche non
carnevaleschi, di cappelli, sciarpe e scialli, era una donna di media
statura, con un cespuglio di capelli ricci, « la Riccia Cammellota »,
che io ricordo già brizzolati, con occhi vividi e vivaci, con lo sguardo
intelligente ed era veramente una donna di intelligenza pronta e piena
di ingegno.
Oggi, paghiamo la firma dei grandi sarti o creatori di moda e la
mostriamo con un certo sussiego ed orgoglio sulle cravatte, sui vestiti,
alla « Riccia Cammellota » si pagava appena appena la stoffa e il lavoro
materiale e poco peso si dava alle sue « creazioni », che erano
veramente degne di essere chiamate così per la originalità delle linee,
per la cultura che esprimevano, che, con l'accuratezza e la precisione
della manifattura, ne facevano di esse dei veri capolavori di arte.
Avrebbe potuto lasciare eredi e continuatori della sua arte ma non ebbe
tempo e possibilità di creare una scuola e non ebbe nemmeno
incoraggiamenti, forse, come tutti coloro, che sanno fare qualche cosa
di diverso e di bello, fu circondata da invidia e raccolse più spine che
rose. Il piccolo paese? Direi proprio di no, i piccoli uomini, proprio
quelli della storia, che non hanno saputo o voluto guardare mai al di là
del proprio naso, che non hanno mai visto un futuro per la gente, per la
città, e la gente, quella migliore, è scappata e la città è scivolata
verso i casermoni, abitati da quelli che aspettano e corrono soltanto
quando devono andare a comprare tutto ciò che proviene dal Nord, specie
se reclamizzati dalla Televisione.
Avevamo un grande artigianato e dei grandi artigiani ma abbiamo
preferito rincorrere le chimere.
Dal portoncino accanto alla « Riccia Cammellota » usciva a tutte le ore,
e spesso nelle ore più strane e in quelle della notte, e non perché
fosse un viveur o qualche cosa di simile, ma per ragioni professionali,
un signore distinto nella figura e nel vestire, dal colletto duro e
dall'immancabile mezzo toscano fra le labbra, d'inverno anche con ghette
e cappotto foderato di pelliccia: il dottor Luigi Coiro, Primario del
Reparto ostetrico-ginecologico dell'Ospedale S. Carlo.
Averlo conosciuto, come l'ho conosciuto io per essere stato a lui vicino
e, non soltanto, materialmente, per essere stato nel suo Reparto ed aver
lavorato con lui, nelle ore del giorno e in quelle più faticose della
notte, è più che sufficiente per poterlo ricordare, nella sua giusta
dimensione di uomo e di professionista, a me stesso per un ulteriore
tributo di stima e di affetto, agli altri, in particolare ai frettolosi
e superficiali giudici, colleghi e non, perché recitino l'atto di
contrizione, se sono in vita, se sono morti ci penserà il « giorno del
giudizio ».
Il suo aspetto burbero nascondeva un animo buono e generoso, sempre
pronto ad apprezzare i progressi degli altri, sempre disponibile verso
l'umanità, modesto nell'umiltà, non aveva la presunzione di fare il
maestro né disdegnava i suggerimenti e i consigli degli altri. Proprio
per questo, e anche per l'ignavia degli altri, lui, senza titoli
specifici ma maturo per grande pratica ed esperienza, raggiunse il
primariato. Era laureato in Medicina Veterinaria, prima, e in Medicina e
Chirurgia, dopo, aveva fatto l'Ufficiale Medico in servizio effettivo,
raggiungendo i gradi di Ufficiale Superiore, ed era stato anche
assistente dell'oculista prof. Sbordone presso la Clinica « Remigia
Gianturco », di cui, mi pare, era anche socio.
Non conosco le cause del suo completo cambiamento di indirizzo
professionale, forse una vocazione tardiva per la specialità o il
fascino del suo predecessore e maestro: il Professore Vincenzo Lenzi.
Al Lenzi si devono le prime isterectomie, i primi tagli cesarei a
Potenza, oltre la grande ostetricia, via vaginale, di cui era tenace
assertore e valentissimo esecutore. Sembrava che anche la natura lo
avesse fatto apposta per quel mestiere: piccolino di statura e con delle
« manine » create, veramente su misura.
Non mancava mai alla mensa di casa Mancinelli, che sapeva rallegrare
perché era un uomo simpatico, spassoso, dalla aneddotica pronta, varia,
inesauribile. Veri o falsi, specie quelli che riguardavano i medici,
egli li raccontava nella convinzione che l'inesperienza,
l'impreparazione si potessero combattere più con il sorriso che con
l'aggressione diretta verbale o, peggio, indiretta legale.
|
 |
|
Mario Albano campione italiano dei 100 m. festeggiato dai
compagni. |
Dopo il portoncino
del dottor Coiro, andando verso la Piazza Prefettura, vi era un negozio
di stoffe di proprietà Giacummo. Un locale buio, angusto, che vendeva
poco anche se in quel negozio non faceva difetto la roba buona né la
cortesia, nella vita come nel commercio ci vuole anche un po' di
fortuna. Comunque, io non lo ricordo per questo ma lo ricordo per i due
dei figli del titolare: Emilio ed Enrico.
Stralcio dal libro « un pugno di speranza », curato da Pino Gentile,
quanto scrissi (pagg. 109-110):, « Ero poco più di un bambino e ricordo
che un giorno tutta la città era a lutto. La sera precedente sul ring,
allestito sul palcoscenico del Teatro Stabile, un giovane di Potenza,
Emilio Giacummo, un bel giovane biondo e ricciolino, era morto per una
violenta epistassi, irrefrenabile, causata da una gragnuola di pugni
sulla faccia, scaricatagli dal suo avversario. Se ne dissero, come
capita in occasioni del genere, di cotte e di crude, ma, a
considerazioni postume, mi pare di poter dire che, nell'allestimento del
match, ci fu molta leggerezza, si tenne conto della prestanza fisica del
giovane Emilio ma non si tenne conto che nel pugilato, come del resto,
in tutte le discipline sportive, le doti fisiche valgono un terzo mentre
i due terzi valgono la preparazione atletica e la preparazione e
l'esperienza tecnica ».
Ricordo il fratello Enrico, invece, perché un patito di Mussolini e del
Fascismo, eppure dal Fascismo non aveva ottenuto né privilegi e né
vantaggi e, tantomeno, direttamente da Mussolini, che conosceva in
fotografia e venerava in fotografia. L'uomo dalla sahariana in tutte le
occasioni e solo perché così intendeva dimostrare il suo attaccamento al
Regime. Se la portò anche a Torino, dove fu costretto a trasferirsi dopo
la guerra, e nel testamento personale aveva scritto che doveva indossare
la sahariana anche da morto e con quella essere sepolto. Ricoverato alle
Molinette, pressoché in fin di vita, anche se in stato preagonico curò
che nella borsa i familiari avessero messo la sahariana ed ai medici
dell'Ospedale rivolse viva preghiera che gliel'avessero fatta indossare
appena morto. La sua volontà fu rispettata. Un esempio di fanatismo? No,
di coerenza, eppure aveva bisogno ma preferì rimanere « povero ma onesto
nei principi e moralmente », onorò soprattutto se stesso.
Il ricordo della tragedia di Emilio Giacummo mi rattrista ancora oggi ma
la città ricavò dallo Sport anche delle soddisfazioni e di alto livello,
nell'atletica, nella scherma, nel calcio e, in tempi più recenti, nella
stessa boxe: Rocco Mazzola, campione italiano dei medio massimi e dei
massimi da dilettante e da professionista onorò largamente la memoria di
Emilio. Un uomo, don Alfredo Viviani, con la sua passione, la sua
pazienza, la sua competenza, il suo personale sacrificio portò a livelli
nazionali la squadra di atletica, nella quale eccelsero Nocera, campione
italiano degli 800 m., e Mario Albano, campione italiano dei 100 m., ed
a livello di tutto rispetto la squadra di calcio. E sono ricordi,
certamente, esaltanti specie se si tiene conto che non c'era una lira
per nessuno e che le trasferte si facevano con i mezzi meno costosi e
con il panino.
Anche nella scherma la città scrisse nel suo albo d'oro i « due volte »
campioni d'Italia: Italo e Gigi Mastrilli, fiorettista il primo,
spadista il secondo. Erano stati creati ed allenati dal padre, seniore
della Milizia Volontaria, preparatore atletico eccezionale e profondo
conoscitore dell'arte della scherma, severo nell'insegnamento.
Italo mi fu compagno di scuola e prezioso compagno di pedana, Gigi, dopo
la scuola Magistrale e il diploma di maestro, frequentò l'Accademia
Fascista e fu Insegnante di Educazione Fisica, ma, dopo la guerra emigrò
in America, dove fece diversa fortuna. La famiglia Mastrilli abitò a
Santa Maria, nel Rione Manicomio, per essere più preciso, vicino alla
mia famiglia ed era una famiglia esemplare, corretta e molto distinta,
il primo dei figli, tenente di Fanteria in Servizio Permanete effettivo,
cadde gloriosamente in Albania, onorando la sua fede e la sua scelta
professionale.
Ma lo sport, in genere, fu vera gloria anche per il contributo dei Luna,
Santagata, Padula, Cassibba, Lamorgese, dei fratelli Lasorella, dei
fratelli Ottavio e di tanti altri, a cui va il mio ricordo affettuoso e
riconoscente per aver contribuito a far conoscere Potenza oltre i
confini della nostra Regione. E tutti meriterebbero ben altra menzione
e, spero, che qualcuno, seguendo l'esempio di Pino Gentile, raccolga le
loro imprese, costruite sulla volontà e con il cuore, in trattazioni più
complete e più specialistiche e, certamente, meglio di come potrei fare
io anche se volessi tradire il compito, che mi sono assunto.
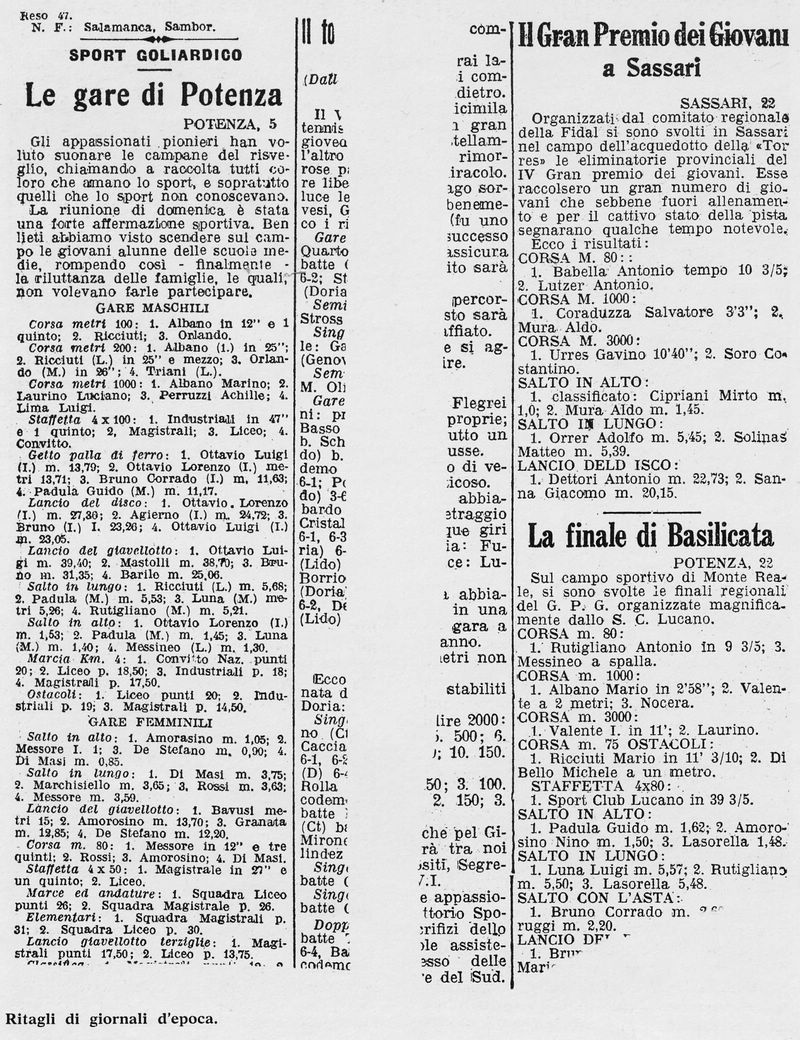
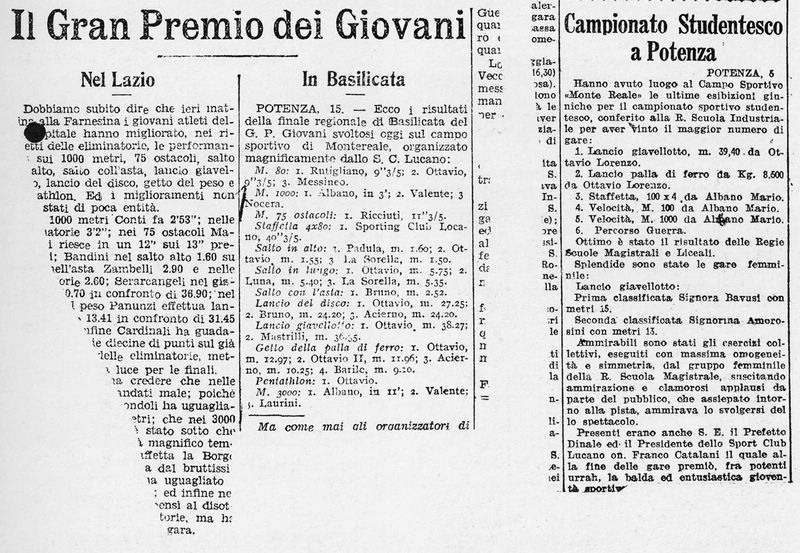
|