|
PARTE
V
(continuazione 2)
|
 |
|
Vico Lavanga
|
 |
|
Vico Corrado |
Accanto a quei
giochi, che si potevano trovare anche negli altri rioni e in altri
paesi, vi erano giochi originali come quello di « Sant' Zulfariedde ».
Si menava « lu tuocche » e chi usciva saliva a cavalluccio sulle spalle
di un compagno ben piantato, che sfilava «'nsotte e sova» tra le due
file degli altri ragazzi partecipanti al gioco. Durante questi viaggi
veniva chiesto al cavalluccio: « Chi passa? ». Se la risposta era San
Gerardo, San Rocco, o altri Santi del comune calendario, il capo-ciurma
si affrettava a dire: « dascialu passà » ma non appena il portatore
rispondeva « Sant'Zulfariedde » allora una gragnuola di pugni si
abbatteva, impietosamente, sul malcapitato, che alla meglio e come
poteva, cercava di schernirsi.
Forse, nella ideazione e condotta di questo gioco, certamente cattivo,
vi era una logica ed una spiegazione perché il « Sant'Zulfariedde » era,
nella credenza popolare, il Diavolo e il Diavolo non doveva passare, al
Diavolo non si doveva concedere né diritto e né spazio.
I più grandi giocavano a « la staccia », a « tozzamuro », ma erano
giochi per i quali bisognava disporre di qualche centesimo e, perciò,
non erano giochi per tutti.
Gli uomini giocavano con le bocce ed era sempre più bravo chi sapeva
bocciare, far saltare, cioè, fuori misura le bocce degli avversari; si
facevano la passata di morra e si giocavano la bottiglia di vino a «
padrone e sotto », il padrone era padrone di bere tutta la bottiglia ma
per fare bere gli altri ci voleva sempre il consenso del sotto. Tante
volte assistere alle battute di morra era un pericolo per i timpani,
talmente forte venivano gridati i numeri.
Ma vi erano anche i giochi che si facevano in famiglia e le piccole
festicciuole, allietate dall'organetto e dall'immancabile « tarantella
». Vi era sempre chi dirigeva il ballo e che, naturalmente, non sapeva
nemmeno dove stesse di casa il francese. Usava la sua lingua, che, quasi
certamente, aggiungeva qualche cosa in più alle stesse figure del ballo,
gridava le sue frasi con atteggiamenti e movenze, che facevano di lui
uno spettacolo nello spettacolo: « ... e fascemme lu tortaniello » - «
... e avòtalo ca s'abbruscia » - « ... e 'mbrugliammesce nu' poco » - «
sini stra... destra e cu prescezza » - e aggiungeva subito e con più
voce: « ... e aggarbete sà vagnardedda » - « ... e fascemm' la ciarla ..
e pure la menza ciarla » - « ... e cumm' s' porta la zita a la messa.. e
fagn' na riverenza » ed altre figure, che venivano marcate da grida
ritmate e battute di piedi sul pavimento.
Ma già i più esperti sapevano ballare la polca, la mazzurca, « lu val's
» e la controdanza e questo perché l'organetto e « lu tammurriedde »
cominciavano ad essere sostituiti con chitarre e mandolini ed anche con
qualche violino.
Durante la festa e tra un ballo e una risata si passava « lu ruccule e
la sottapera » e solo nelle grandi occasioni si passava il bicchierino
di rosolio, fatto in casa con l'estratto, l'alcool e lo zucchero, che
gli uomini, in genere, rifiutavano, preferendo « na passata d' iasca cu
lu cannitte », per bere a garganella, oppure « na passata cu l'ucciule »
per quelli meno bravi a garganella e che si vedevano sempre con le
macchie di vino sui pettorali della camicia.
Il più delle volte gli uomini non avevano torto di affidare le cure del
proprio stomaco ad una buona bevuta di vino perché il rosolio, preparato
con dosi sbagliate sia di alcool che di zucchero, era una autentica «
ciufeca » imbevibile.
Negli sbattimenti delle danze infuocate tintinnavano sui panciotti degli
uomini le catene d'oro, a cui, da un lato era attaccato « lu' nderlogge
» e dall'altro lato « nu belle curniciedde » perché la iettatura era
«sempe 'ndreta a li spadde» e li malefemmine zavardose e fattucchiere
erano « sempe 'ndreta a la porta » e alle donne rimbalzava dal seno,
attraverso le brevi scollature dei vestiti, l'abitino, una specie di
sacchettino di stoffa, dove era rinchiuso di tutto, sacro e profano,
figurine di santi, curniciedde, forbicine, pezzi di spago, savine,
melogna di mulo, capelli della prima tagliatura, chiodi della prima
ferratura di cavallino, anche denti di animali e pelle di lucertola o di
altro serpe, essiccata al sole.
Proprio nel Rione Addone ricordo di aver visto l'abbigliamento più
classico e più abituale del verace « bracciale putenzese », « lu
purcione, la cammisola, la braetta, gli stivali di filannina bianca, con
le pezze intorno ai piedi e gli scarponi, fatti sul tipo delle calzature
romane, di cuoio grezzo, legati con lacci fatti dello stesso cuoio e
fatti in modo da lasciare il calcagno, « lu arrone », libero così da
avere il passo più facile e più spedito.
Le contadine, « le pacchiane », portavano « lu suttaniedde », che era
una specie di gonna ricca di pieghe, «la fascetedda», la camicetta, il
busto, « lu vandesine » e intorno al collo il nastrino di velluto nero «
cu la crucetta o lu berlocche » e non mancava « lu facciulette 'ndesta
», che, nelle grandi ricorrenze, come feste religiose o matrimoniali, si
trasformava in « facciulettone », che, per lo più, era di raso damascato
e arricchito di lunghe frange.
Nei casi di lutto « lu facciulettone » era nero.
Era il Rione che, di buon mattino, si svuotava per ripopolarsi la sera
perché tutti, uomini e donne, andavano in campagna a lavorare.
Qualche volta rimanevano le donne o per impastare e « scanà » pane o per
fare una maggiore pulizia, come avveniva nei periodi che precedevano la
Santa Pasqua. Le « scanare », le panelle, erano delle vere e proprio
ruote di macina, tanto il pane si consumava e questo perché, il più
delle volte, costituiva la base della nutrizione. Ma si consumava anche
quando diventava duro, « seriticce », si « spunzava » camminando,
camminando sotto la funtana, serviva per fare « l'acquasale » una specie
di intruglio saporito, preparato con acqua salata, bollita con cipolla,
e qualcuno, più fortunato economicamente, ci buttava anche un uovo.
La donna rimaneva in casa quando doveva preparare « lu cascione » per il
grano nuovo e fare qualche piccola provvista, « la 'nzerta d'agli', di
cirasedde, li puparule crusche e quedde sott'aceto, 'ncarch cape d'
sav'cicchie ». Rimaneva « quanne avìa arrepezzà », rattoppare, perché a
« davà » andava « a la iumara » e asciugava, spandendo la biancheria
sulle siepi o sui cespugli.
Ma la donna rimaneva in casa, soprattutto, « quanne avìa accattà lu
piccininne » e, per l'occasione, rimaneva anche la mamma e la suocera e
qualche vicina di casa, le prime due per assisterla e « p' dà li boni
cunsigli », la vicina, magari giovane, per tenersi pronta per correre a
chiamare « la cummara », la levatrice, non appena cominciavano « li
ducculi », i dolori. Ma serviva anche per partecipare a parenti ed amici
il lieto evento ed era, veramente, lieto quando il neonato era maschio «
... ha fatte nu' belle piccininne... nu' fiore... nu' giaante » un po'
meno quando era femmina, assai meno, con visi lunghi e facce
amareggiate, quando di figlie femmine in casa ce n'era più d'una. Ma, in
fondo, passati i primi momenti di delusione, forse, anche comprensibili
perché comportava ben altri problemi e responsabilità, non esclusi
corredo e dote, si ricomponeva la felicità della famiglia e non poteva
essere diversamente perché i figli erano « grazia di Dio ».
Si faceva regolare lutto per un figlio nato-morto e per un figlio
abortito. Come sembrano lontani quei tempi, eppure non sono tanto
lontani, oggi, che, con una iniqua legge dello Stato, abbiamo
legalizzato l'aborto, cioè l'infanticidio. Quando abortiva
spontaneamente la donna si sentiva quasi in colpa e si vergognava anche
di uscire di casa perché il Padreterno non l'aveva ritenuta degna della
grazia della maternità, ora c'è chi si vanta di farsi procurare l'aborto
spesso e volentieri. Quello non era fanatismo ma senso di responsabilità
ed amore alla vita, lo schifo di oggi è comune delinquenza, anzi, la
peggiore perché la violenza è fatta contro chi non può ribellarsi e
difendere.
Di fronte al figlio nato non esisteva povertà perché in tutte le
famiglie si preparava, magari « duvannese lu buccone da 'mmocca », « na
bella naca e na ricca 'mbascianna ».
Per rendersi conto di quel che poteva rappresentare il figlio sarebbe
bastato assistere, magari una volta sola, al rito del battesimo, che,
allora, si faceva obbligatoriamente in chiesa. Dalla casa alla chiesa si
andava in corteo, preceduti dalla «mammana», che portava su un cuscino
disteso sulle braccia il neonato « vesture cumm' a n'angele » con la
gente del vico sulle porte e ai bordi della strada che indirizzava baci
di auguri al nuovo venuto nel Rione.
Era una festa, che continuava in chiesa con il suono dell'organo, le
candele accese nelle mani dei partecipanti, fra cui spiccava il compare,
o la cummara, che alla fine complimentava la mammana, il prete, gettando
qualche moneta nella fonte battesimale, i bambini e i ragazzi con il
lancio di altre monetine in mezzo alla strada.
Era la festa della famiglia ma anche di tutto il Rione, che era la
famiglia più grande, e tutto il Rione era orgoglioso di queste feste e
quelle più sontuose erano ricordate nei racconti ai nipotini.
Ho ricordi bene stampati nella memoria per la diretta partecipazione
come « cumpare, lu cumpare d' San Giuvanne », che era una cosa sacra e
seria, era una vera assunzione di parentela, se non di sangue, di
responsabilità nei confronti « d' lu cumpariedde » e verso la famiglia
era un giuramento di fede e di promessa per amarsi, aiutarsi e
difendersi fino alla morte. Vi ho partecipato come invitato di riguardo
e d'obbligo perché « avìa viste nasce lu piccininne ».
E già perché allora tutti i parti avvenivano in casa e con la sola «
mammana » e, proprio quando le cose erano più complicate, si chiamava «
lu duttore », che doveva essere « lu mierihe d' li femmine », era un
evento piuttosto raro ed era seguito con apprensione da parte di tutta
la cuntana.
Uscendo dalla casa della partoriente, più volte, mi sono commosso, in un
misto di emozione, rispetto, amore per quella gente, quella brava gente.
La mia apparizione li sollevava da un incubo, dopo Sant'Anna, la patrona
delle partorienti, venivo io, allora giovanissimo mi sentivo confuso, a
disagio perché tutti, in particolare le donne, mi sorridevano, mi
ringraziavano, qualcuna, più vecchia, mi sfiorava con la punta delle
dita, proprio come si faceva con la statua del Santo.
Era stata, magari, « la mala nuttara » ma « lu piccininne » era vivo, vi
era la nuova vita nella cuntana e vi era la ricchezza e la ricchezza per
tutti ed era giusto che tutti ne gioissero.
Mi commuovo ancora, oggi, al solo ricordo e, non credo, perché sono
nell'età dalle facili commozioni, credo, fermamente e per convinzione,
perché ho partecipato a queste belle manifestazioni dell'anima umana,
perché ho ricevuto queste ondate di calore umano, che lasciano il segno
e non si dimenticano, anzi, si risentono ancora più vive, oggi, in
questo mondo, che sempre più si allontana da questi eterni valori.
Che cosa avevo realizzato? In termini economici, poco, talvolta, anche
niente, ma non pretendevo e non ho mai preteso di più, avevo realizzato,
invece, un patrimonio immenso di spiritualità, di umanità, di nobiltà di
vita, di civiltà, di cultura.
Avevo avuto la possibilità di abbeverarmi direttamente alla vera fonte
della civiltà e cultura contadina, di cui tanti ne parlano, forse, più
in termini di moda, di snobismo, di saccenteria, di culturalismo, che di
conoscenza e convinzione. Se fosse vero il contrario non ci saremmo
avventati con la rabbia e la voracità dei più feroci animali sul Rione
Addone e su altri lembi dell'antica Potenza, avremmo avuto la coscienza
che non si distruggevano soltanto i ruderi, delle case non efficienti,
non belle e non igienicamente idonee, si distruggeva l'ambiente dove era
nato un popolo, dove aveva costruito la sua storia, dove aveva affondato
le sue radici, che avevano dato i frutti delle belle tradizioni, della
grande cultura, della nobile civiltà.
Se fosse vero il contrario avremmo conservato il Rione Addone e ne
avremmo fatto un Museo per la ricerca, lo studio, per tramite tra
vecchio e nuovo, per una continuità di cultura e di civiltà.
Ma abbiamo distrutto tutto e non solo per disattenzione, per disamore,
ma, per incultura e per rifocillare volgari appetiti speculativi.
« Risanare » poteva significare anche ristrutturare ma le
ristrutturazioni non avrebbero sedato appetiti, avrebbero una certa
aggregazione sociale, una testimonianza, ma non avrebbero dato la
possibilità a classi emergenti di risiedere al centro.
Se nel passato Potenza fu vittima di una certa burocrazia, quella che fu
definita « delle tre P » (prima nomina, punizione, prossima a pensione),
una certa burocrazia, a cui, per ragioni, forse, anche comprensibili,
Potenza stette sugli zebedei e non nel cuore, nel recente passato è
stata vittima proprio di queste classi emergenti, economicamente più
forti, quindi di potere, poi diventate anche di potere politico, a cui
la città doveva servire ed è servita solo per uso e consumo. La città si
è arricchita di pellicce, si è coperta di un manto di automobili, ha
curato, insomma, la veste esterna, anche se con poco gusto e niente
grazia, ma ha perduto il cuore, ha presentato un corpo artificioso e
sofisticato ma ha perduto le sue membra originali, la città ha perduto
la sua identità.
Non vi fu opposizione, d'altronde, chi avrebbe voluto opporsi non aveva
forza economica e tantomeno forza politica.
Non vi fu opposizione della « parrocchia », in senso proprio e lato,
arroccata su posizioni medievali e bizantineggianti, con la valutazione
di comodo per l'immediato e senza la previsione del futuro.
Si vide di buon occhio l'aggregazione di gente nuova, benestante, ma non
si considerò, che era un'aggregazione instabile, soprattutto, per
ragioni etniche e culturali ma anche per fede religiosa e labilità dei
principi morali e di costume.
Lo ha, chiaramente, dimostrato il tempo, lo ha, inesorabilmente,
confermato il dopo terremoto.
Scompariva con il Rione Addone una parte di popolazione ancora attaccata
ella benedizione pasquale delle case, all' assistenza spirituale al
moribondo, alla interminabile processione di San Gerardo con la sfilata
di tutte le congreghe delle varie chiese con i loro Santi, ad una certa
sfilata dei Turchi, variopinta e pittoresca manifestazione genuinamente
popolare ed in cui il popolo, nella continuità della tradizione, cercava
di esprimere, di anno in anno, tutto se stesso.
Nessuna opposizione politica, anzi, fu proposta e caldeggiata proprio in
sede politica e i « putenzesi » furono sloggiati con il miraggio della
casa nuova, comoda, con i servizi igienici e alla periferia, dove — si
diceva — c'era aria e luce. I loro ruderi, le loro case, fatiscenti e
malsane (come venivano definite per scoraggiare i vecchi proprietari e
invogliarli a vendere per quattro soldi) diventavano proprietà di nuovi
padroni, che, così, acquisivano il diritto all'appartamento o più
appartamenti nei costruendi scatoloni di cemento armato. Il resto è
storia recente e non ho bisogno di soffermarmi o di ricordare perché la
ricordano o, perlomeno, la dovrebbero ricordare tutti.
Si compiva; così, il genocidio. Proprio così « il genocidio ». Perché il
genocidio non è soltanto « la metodica distruzione di un gruppo etnico,
razziale o religioso, compiuto attraverso lo sterminio degli individui «
ma è genocidio anche la dissociazione e dispersione dei gruppi
familiari, lo scardinamento di alcune istituzioni sociali e culturali.
Con il Rione si seppelliva un vecchio mondo, che non aveva più diritto
alla vita e, quindi, secondo una sottile propaganda, anche la lingua
degli avi, la bella parlata dialettale, doveva seguire la sorte del
Rione perché « sconcia ed arretrata ».
Si codificava il lamento del padre in
« Quedde ca disce misire » (pag. 35 de « La Sartascina »)... «
Lu custumm' d' sà mamma / lu ariniedd' d' villuro / lu scarpone e lu
zappone / tutt' rrobba da giccà. / Tutt' quedde ca tuccarm' / s'
spurcava e s' rumpìa / tutt' quedde ca discièmm' / era brutte e non ci
và ».
Ed ecco uno dei tanti esempi a conferma.
Qualche anno fa una insegnante, che si dedicava a ricerche sul dialetto,
chiese ad una signora proveniente dal « gruppo sfrattato », della razza
« Scarrozza », quindi, « putenzese di fatto e di soprannome »: « Nel
dialetto, si dice ' cavegli ' »?
« La risposta della signora Scarrozza fu pronta e decisa: « Sia per
regola e norma vostra noi da sempre diciamo capelli ». Ed è quanto dire.
Ma questo episodio, come tanti altri, mi rattrista profondamente ma
senza distruggere, anzi, rafforzando i ricordi. Qualcuno bucolico come
il lattaio che, sull'imbrunire di tutti i giorni, si aggirava con le sue
caprette, il suo negozio ambulante, e mungeva il latte davanti a ogni
porta, non c'era, certo, sofisticazione o frode, mungeva « il misurino
di latte caldo » per i bambini, i vecchi e i malati.
Qualcuno, potrei dire, folcloristico, se mi è consentito, o umoristico.
Nel cuore di « na mala nuttara » venne alla luce, finalmente « lu
piccininne », era « nu' fiore... nu' gia-ante », mentre il volto della
puerpera si illuminava di gioia naturale e comprensibile, anche se aveva
sofferto molto, cominciava il vociare festoso delle presenti, era la
festa, la festa per il nuovo venuto, atteso e bene accetto.
Improvvisamente, da dietro ad un lenzuolo, ben disteso lungo una fune,
comparve la testa di un asino, « lu bone ciucciariedde » paziente e
indispensabile compagno di lavoro. Guardò attentamente, si rese conto e
ragliò ma ragliò lungamente e, direi, in modo insolito. Era il segno,
evidentemente, della sua soddisfazione, della sua partecipazione al
lieto evento, degli auguri al neonato, a cui dedicava, come nel presepe
di Betlemme, la prima zaffata di calore umano, era la « buona novella »
che, senza antenna, lanciava nel Rione.
Durante una delle sedute notturne di attesa, tra un grido della
partoriente, un sospiro degli astanti e il moto inquieto e comprensibile
della levatrice, da una delle pareti dell'unica stanza, dove vi era una
specie di tendina a fiori, veniva il rumore di una scorreggia, con ritmo
cronometrico, il genere, tenendo conto della classificazione volgare ma
popolare, era del « piritum cum rutella » (Tria sunt genera piritorum:
loffa, cataloffa et piritum cum rutella).
Approfittai di un momento di confusione per soddisfare la mia curiosità.
Dietro la tendina vi era una specie di loculo e dentro il loculo era
sistemato il nonno, Zì Peppe, brevilineo dalla nascita e reso ancora più
breve dal naturale accorciamento artrosico della colonna vertebrale,
quindi, un loculetto per il nonnetto, che, evidentemente, sforzandosi di
ritmare una respirazione insufficiente e rumorosa non si accorgeva di
espirare anche di sotto e con un po' più di rumore.
E, concludo, così il mio ricordo-omaggio al Rione Addone. È stato un
ricordo, certamente, sofferto ma anche patetico perché, con la scomparsa
del Rione Addone, io e quelli della mia generazione abbiamo visto
seppellire la parte migliore della nostra vita, e non per godimenti
materiali ma per spensieratezza, gioia di vivere, interessi da attuare,
piacere di lavorare, di essere utili a noi stessi ed alla società. Il
ricordo è stato associato al Rione San Luca, al Castello perché con la
loro scomparsa è scomparsa Potenza antica e genuina.
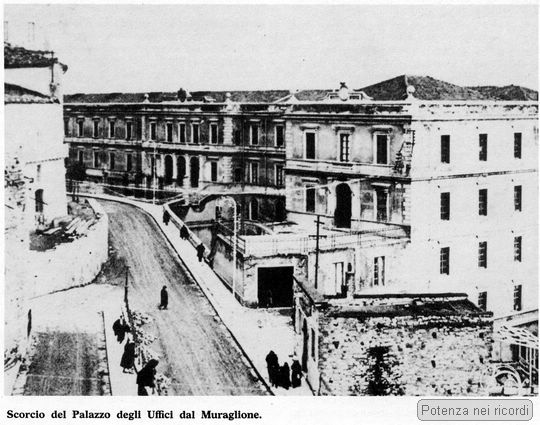
|