|
PARTE SECONDA
DIARIO
DI UN VIAGGIO IN ALBANIA ALLA RICERCA DELLE RADICI
|
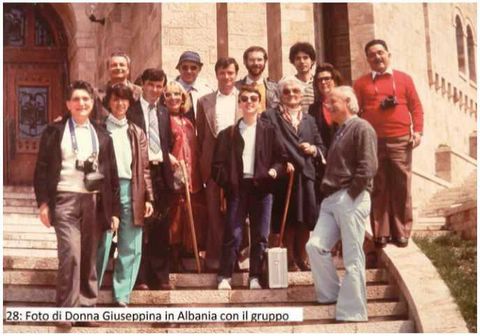 |
L’idea di trascorrere un
primo maggio a Tirana ci stimolò a tal punto che decidemmo di
andare a conoscere la patria dei nostri antenati, che nel 1500
lasciarono l’Albania sotto la pressione dei turchi.
La curiosità era immensa, anche da parte di mia madre,
Arberesche di Castroregio (Cosenza), appartenente alla famiglia
Camodeca de’ Coroney, che, all’età di 84 anni, aveva voluto
rendersi conto dei luoghi di origine dei suoi antenati. Ci
imbarcammo a Pescara sulla nave Tiziano per sbarcare a Spalato,
dal momento che i porti di Albania erano chiusi al traffico
turistico. Il traghetto appena fuori dal porto fu investito da
un mare lungo che mise in difficoltà tutto il gruppo, compresa
mia madre, che per la prima volta si imbarcava, e che riuscii a
far riposare per tutto il tragitto in una cabina del traghetto.
Il gruppo era formato da trenta persone, tutte aderenti al
movimento marxista -leninista e simpatizzanti del regime
albanese, fatta eccezione per noi che avevamo scelto di visitare
l’Albania per motivi eminentemente turistici. Il primo impatto
lo avemmo alla frontiera iugoslava, dove fummo invitati a
consegnare tutti i prodotti commestibili che alcuni avevano
portato in regalo alle famiglie albanesi che andavano a
visitare. Dopo un pernottamento a Spalato, l’indomani, a bordo
di un pullman, iniziammo verso il confine dell’Albania il
viaggio che durò circa 18 ore. Durante le prime ore immergemmo
la mente e gli occhi nei paesaggi della Yugoslavia, ma dopo un
po’la noia e la stanchezza cominciarono a prendere il
sopravvento e non vedevamo l’ora di giungere alla frontiera
albanese, anche perché curiosi di conoscere questo paese sempre
più avvolto dal mistero. Il pullman al confino iugoslavo ci
lasciò alla sbarra e dovemmo attraversare la terra di nessuno
con « armi e bagagli ›› in un coro di voci che è solito degli
italiani, specie dei meridionali. Appena in Albania, al confine,
presidiato da guardie con fucile mitragliatore, fummo accolti
dalle nostre due guide, una turistica e l’altra politica, che ci
avrebbero fatto compagnia durante tutta la nostra permanenza. La
guida turistica era un insegnante di matematica mentre la guida
politica era un odontotecnico. Dopo una accurata ispezione ai
bagagli e completate le pratiche burocratiche, iniziò il viaggio
per Tirana: strade strette e polverose, numerose buche e
traffico di carretti dipinti in colori vivaci trainati da
cavalli; traffico automobilistico inesistente. Attraversammo
delle immense pianure tutte coltivate,tenute in ordine da torme
di persone che lavoravano i campi e che al nostro passare
levavano le mani in segno di saluto. Era un’agricoltura molto
curata, con colture irrigue e con un buon sfruttamento del
suolo,dal momento che con il raccolto dovevano soddisfare i loro
bisogni minimi ed esportare la rimanenza dei prodotti, che
avrebbero portato alle casse dello stato valuta pregiata. Lungo
tutto il percorso si potevano osservare colture pregiate in
serra, curate da contadine che al nostro passaggio alzavano la
testa e momentaneamente la distoglievano dal lavoro. Nel tardo
pomeriggio giungemmo a Skodra e non un’auto era parcheggiata
nella grande piazza, dove facemmo una sosta per rifocillarci e
per soddisfare i nostri bisogni corporali. C’erano solo
biciclette e carretti variopinti che avevamo incrociato e che
scorazzavano per le strade e trasportavano frotte di contadini
di ritorno dal lavoro. Durante il percorso ogni tanto sulle case
più elevate e su terrazzamenti protetti erano appostate delle
mitragliatrici a difesa del territorio. Verso mezzanotte,
ubriachi di stanchezza, giungemmo a Tirana e di corsa andammo in
albergo, nel migliore della capitale, ad assaporare il meritato
riposo. L’albergo era pulito e il vitto accettabile. La vita
nella terra albanese scorreva secondo metodi antichi scanditi
dalle stagioni e dalla povertà, dignitosa, tipica dei popoli
slavi. |
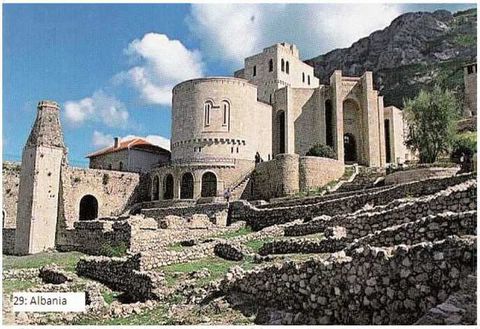 |
 |
 |
 |
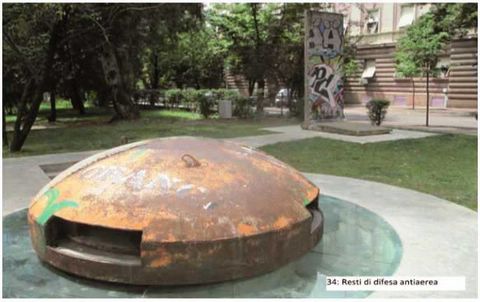 |
|
 |
Nel periodo di permanenza
facemmo delle gite a Cruia, a Durazzo, a Valona, a Scutari per
osservare le vestigia della dominazione romana ed i segni delle
lotte sostenute dal popolo albanese, guidato dal loro eroe
nazionale Giorgio Scanderberg. Durante il breve soggiorno
chiedemmo di visitare un ospedale ma ci fu risposto che solo
verso la fine del viaggio saremmo stati forse accontentati (cosa
che non avvenne). La visita al museo ed al palazzo
dell’esposizione e della tecnica fu molto interessante, anche
perché veniva illustrato con immagini il progresso compiuto dal
popolo albanese dalla liberazione dalle truppe nazi-fasciste ai
giorni nostri. Il massimo della sorpresa venne raggiunto il
primo maggio quando una folla oceanica di adulti, ma soprattutto
di bambini, era schierata nella piazza principale di Tirana per
festeggiare l’avvenimento. Erano vestiti, i maschi, con
pantaloni neri corti, camicia azzurra e fazzoletto rosso al
collo, le femminucce con gonna nera, camicetta bianca e
fazzoletto rosso al collo. Tutti impettiti e agli ordini dei
loro rispettivi insegnanti attendevano lo svolgimento della
manifestazione, quando mi accorsi che alcuni di loro avevano i
piedi coperti dalla tomaia ma senza la suola. Mi si strinse il
cuore e mi venne alla mente che anche i nostri soldati furono
mandati in guerra in mezzo alla neve con scarpe di cartone che
al primo impatto con l’acqua si dissolvevano come neve al sole.
Con canti popolari, discorsi ufficiali pronunciati dal
presidente Halia in commemorazione di Henver Hogia, la cerimonia
andò avanti per tutta la mattinata ed era tanta la
partecipazione emotiva della folla che gridava a squarciagola
che il loro cuore batteva al ritmo di Henver Hogia. Come in
tutti i paesi dell’Est i ragazzi, specie quelli più piccoli,
chiedevano alcuni regali, gomme da masticare o penne biro, a noi
turisti in giro per la città. anche se le persone adulte che
erano in loro compagnia con gli occhi e con i gesti vietavano ai
bambini di fare queste richieste. A spasso per la città, sempre
seguiti da un accompagnatore, visitammo i negozi, in genere poco
forniti; davanti a quelli di generi alimentari, specie al
mattino, vi erano delle lunghe code. Mi riferì una signora
albanese che le file spesso, in alcuni giorni della settimana e
per alcuni generi (zucchero, carni), iniziavano alle 4 del
mattino e andavano avanti fino a quando il negozio chiudeva per
esaurimento delle scorte. La visita alla tomba di Henver Hogia
fu un momento di tensione collettiva, per il fatto che quasi
tutti i partecipanti del gruppo erano marxisti-leninisti e
quindi salutavano la tomba a pugno chiuso, mentre noi cattolici
sulla tomba facemmo soltanto il segno di croce. Accadde però un
fatto singolare, perché, nel momento in cui il gruppo di
italiani visitava la tomba arrivò anche una coppia di donne
provenienti dalla parte sud dell’Albania, che appena arrivate al
cospetto della lapide, cominciarono a fare il « pianto greco ››,
lamenti recitati e accompagnati da lacrime per il tempo che
sostavano nel cimitero, ma appena fuori riprendevano il discorso
che avevano interrotto prima di entrare. Il viaggio di ritorno
fu faticoso come quello di andata; continuammo a vedere
un’agricoltura ordinata e progredita e con buona redditività,
anche se ottenuta a duro prezzo grazie al pesante lavoro
dell’uomo che, chino sui campi, vivificava il raccolto con
abbondanza del suo sudore. Anche durante il ritorno osservammo
sparuti camion, ma soprattutto carretti trainati da cavalli, per
le strade spesso polverose per lavori in corso, e carichi di
lavoratori. I carretti colorati con tinte sgargianti erano
tirati da ronzini, stanchi ma incoraggiati dal guidatore, che
immancabilmente come tutti o la maggior parte dei suoi
connazionali fumava. L’esperienza in definitiva per tutto il
gruppo fu molto positiva. Potemmo vedere e visitare la terra dei
nostri antenati e forse calcare il suolo che i nostri avi
abbandonarono per sfuggire all’invasione turca.Per continuare
questo tenue filo che ci lega all’Albania (terra che amo molto)
ho posto le basi ad una collaborazione per sistemare un
manoscritto riguardante un vocabolario albanese-italiano scritto
dal Monsignor Pietro Camodeca nel lontano 1902. Mi auguro che
questo vocabolario possa essere pubblicato con l’ausilio dei
glottologi albanesi, che hanno mostrato molto interesse nel
pubblicare le modifiche, le evoluzioni che ha avuto la lingua
parlata nelle colonie albanesi della Calabria e della
Basilicata, una lingua cui solo la tradizione orale permette di
sopravvivere. |
 |
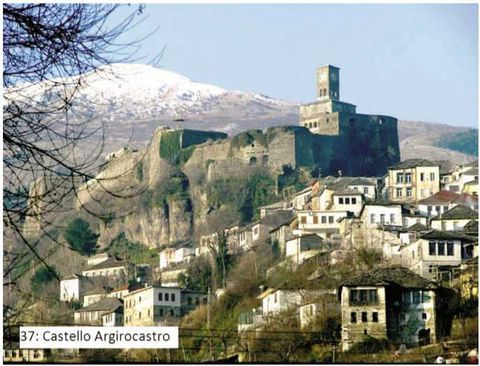 |
TERZA PARTE - SEGUE >>
|